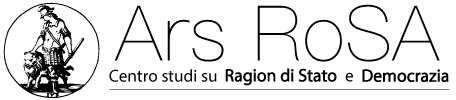di Patricia Chiantera Stutte (Univ. “Aldo Moro”, Bari)
Lo scoppio della pandemia nel mondo è stato un evento inaspettato e di portata catastrofica. Tuttavia la comparsa del virus e la sua propagazione non costituisce un evento unico nella storia e, inoltre, negli ultimi anni sono scoppiate ricorrenti emergenze sanitarie che solo per casi fortuiti non hanno interessato l’Europa e l’Occidente. Si potrebbe allora affermare che la percezione della novità e dell’unicità dell’evento sia stata falsata, esagerata da una cattiva informazione sulla ricorrenza di patologie e la possibilità di pandemie.
Eppure, abbiamo pensato che “la morte non doveva raggiungerci” forse per il desiderio di onnipotenza, la credenza nell’immortalità, la certezza che le pandemie si sarebbero fermate dinanzi al benessere, alla tecnologia, al progresso – e forse così facendo abbiamo seguito la storia di tutte le generazioni che si sono trovate impreparate davanti alle pandemie. Chi lo poteva sapere? Chi lo avrebbe immaginato?
Lo scoppio del Corona ha avuto, così, il tempo per compiere quello che fanno tutte le catastrofi: mostrare le debolezze del nostro tessuto sociale, spaccare l’immagine superficiale e lucente della felicità consumistica e mostrare le ineguaglianze, le crepe, le deficienze e il rimosso su cui si era fondata. Quelle diseguaglianze che pure c’erano nella società prima dello scoppio pandemico sono diventate visibili; la sperequazione fra parti del pianeta, fra diverse economie si è disvelata; la superficialità dei nostri modelli di vita, fondati sull’accelerazione dei tempi di lavoro e sull’affastellamento di impegni mondani ha lasciato il posto a giorni uguali, vissuti nella stessa cerchia intima, con ritmi quasi ancestrali: cibo, pulizia, spesa e lavoro online per chi è fortunato.
La pandemia è stata una cartina di tornasole: ha ampliato le differenze – sociali, lavorative, di modi di vita – e nello stesso tempo ha unito ancor più i gruppi – le famiglie, le comunità condominiali, i cittadini ai “loro” governanti e ai “loro” medici, i popoli alla loro “patria”. La pandemia ha personificato e dato un passaporto a chi non lo avrebbe mai potuto avere – il virus è diventato cinese, italiano, tedesco – e ha confinato i viaggiatori e i pendolari a casa, svuotando gli aerei e rendendo pantofolaie le elites cosmopolitiche, i Davos men. Ha invertito i ruoli: impone ai figli e ai nipoti di prendersi cura dei genitori e dei nonni.
Nell’intensificare il legame del popolo col “suo” governo, con la sua patria, la pandemia ha agito come emergenza, come stato di eccezione. Ha dis-velato le radici della “normalità” e lasciato intravvedere la condizione di emergenza, di guerra, che è a fondamento dello svolgimento normale della vita politica e sociale, ma è l’opposto di esso e accompagna come un’ombra tutte le istituzioni politiche e la “normalità” legale. Il disordine, il caos, la possibile guerra e la paura sono tutte sfaccettatura di questo punto di origine che si capovolge nel politico, ma non ne viene mai rimosso, aleggiando intorno alla vita ordinata come una costante minaccia – come scrive Carl Schmitt. Eppure, forse, proprio di questa minaccia ci siamo dimenticati.
Non è stata la guerra civile né quella nucleare a farci tornare allo stato di emergenza ma un piccolo virus, di cui non conosciamo ancora bene le caratteristiche. Di fronte al pericolo della morte molti sono ritornati a credere nell’autorità dello Stato e della responsabilità della politica – mai i governi hanno avuto tanto sostegno come ora. Mai la politica è stata più centrale di ora e le autorità politiche più ascoltate con serietà e interesse. Alcuni, come Aganben, hanno invece intravvisto nell’emergenza sanitaria e nella quarantena il profilo dello stato biopolitico, la fine delle libertà e il ritorno del “mostruoso Leviatano”, che si traveste da protettore della vita.
Varie letture sono state date del virus, diverse le crisi e le debolezze che la pandemia ha rivelato. Come lo skandalon della lettura girardiana, il virus ha mostrato una catena di violenza, di errori, di menzogne su cui era in parte fondato il patto sociale e politico, e forse ha indicato le vie di una possibile riflessione. Sembra, insomma. che il virus abbia messo in moto col suo ciclo di morte una serie di riflessioni, pensieri e spunti che sarebbero stati – quelli sì – imprevedibili qualche tempo fa: una riflessione sui fondamenti della comunità, sulla natura e sulla persistenza delle ineguaglianze, sulle varie culture politiche e sociali e sull’importanza della vita della popolazione. I filosofi hanno sottolineato il rapporto della politica con la popolazione e con la cura della vita; i politologi hanno riconsiderato il modello neoliberale e hanno avvertito della virata pericolosa di alcuni regimi populisti che si sono allontanati ancora ulteriormente dal modello liberl-democratico; i giuristi hanno discettato sulla ricorrenza e necessità di proclamare la quarantena e lo stato di emergenza; gli studiosi di relazioni internazionali hanno definiti i prossimi scenari geopolitici e paventato la crisi dell’Unione Europea; i sociologi hanno sottolineato l’aumento delle diseguagianze sociali a cui conduce la crisi; gli storici e gli economisti hanno avuto occasione di ricordare e comparare le risposte dei sistemi di welfare e dei sistemi politici alle crisi; gli psicologi hanno approfondito le conseguenze del distanziamento sociale e hanno prefigurato i nuovi modelli di vita dopo la pandemia; gli ecologisti hanno rievocato i loro studi e le previsioni circa il rischio ecologico. Sono emerse, come in ogni crisi, le differenze fra le risposte politiche alla crisi pandemica: è diventato chiaro come non mai che le risposte che i vari paesi hanno dato alla pandemia non sono solo adeguate alle loro risorse – mediche, economiche, politiche – ma anche alla loro cultura politica, al loro modo di intendere la politica e la socialità. Sembra che tutte queste linee divergano, conducano a una dispersione che ci mostra uno spettro di questioni, problemi, spunti e anche opportunità.
Fra le molte strade aperte, sembra sempre più agevole prendere quella che si pensa di conoscere meglio, per poi forse immaginare – sbagliando – di poter tenere il sentiero e controllare la direzione per arrivare a riflettere sullo “scandalo” della pandemia. Pertanto la strada che mi sembra più affine è quella della riflessione sulla politica, e sulla politica della vita – biopolitica – non in senso foucaultiano e tantomeno agambeniano, ma in senso quasi letterale banalmente storico. La mia prospettiva è pertanto sulla biopolitica intesa tuttavia in senso storico, senza ipostatizzare una costante e un rapporto essenziale tra homo sacer e politica, indicando la chiave di volta della politica, ma banalmente ricostruendo quello che insegno e che mi è stato insegnato sulla politica, come prodotto storico dell’agire umano e dei rapporti, delle credenze e delle mentalità.
La politica moderna emerge dal bisogno di trovare una riposta alla domanda dell’ordine e della preservazione della vita e del corpo del popolo che è corpo del sovrano. Ricordo il sovrano di Hobbes, ma anche il re taumaturgo di Kantorowitz che è corpo mortale e immortale, mai consumato e sempre rinnovato per la salvezza del popolo. Il corpo, la materialità del corpo e insieme la sua salute, la sua vita e la sua persistenza oltre la vita sono allora una delle chiavi per entrare nell’universo del primo pensiero moderno sullo Stato.
Da allora in poi la politica assume modi e linguaggi diversi – tanti che cercarne le derivazioni e i congiungimenti sembra un’impresa grandiosa e sfuggente. Tuttavia, quando molti filosofi discutono della biopolitica si riferiscono a Michel Foucault e alla sua ricostruzione dello Stato come insieme di pratiche e istituzioni che hanno come loro fine la cura, il sostegno e la vita della popolazione tra il XVII e XVIII secolo. Attraverso un salto, difficilmente spiegabile – ma che Foucault non può spiegare per il suo metodo di ricerca – dalla biopolitica gestita dallo Stato che si prende cura della popolazione emerge nei secoli successivi la biopolitica basata sul modello politico liberale, che non si prende più cura della popolazione attraverso programmi di organizzazione della popolazione, ma che lascia agli individui o gruppi il compito di autoregolarsi. Come in un orologio, in cui ogni meccanismo si armonizza autonomamente con gli altri ricevendo stimoli e resistenze, così la società liberale si autogoverna, si forma come una costellazione di frammenti che, senza alcun centro propulsore, si regolano e danno l’impulso agli altri per l’autoregolazione – fin quando questo meccanismo non si inceppa, non “inciampa” in un imprevisto.
Il sogno della società neoliberale, quella in cui noi viviamo, è in fondo la realizzazione del sogno della governamentalità foucaultiana: la autonomizzazione degli individui e dei gruppi, che si autoregolano in un mercato immaginato come perfettamente armonioso – o comunque come l’unica possibile forma di armonica convivenza. Lo stato del neoliberalismo è uno stato che si allontana dal suo ruolo di cura della vita, e anche dal suo significato di regolatore della salute della popolazione: è uno stato che delega al privato le sue funzioni e che instilla nei suoi cittadini il sentimento della responsalbilità individuale e dell’individuale solitudine di fronte al fallimento. Contrariando l’idea sociale di responsabilità collettiva dello Stato, dello stato che governa il sociale col sociale (Di Palma) e che rintraccia nel problema di ogni individuo quello strutturale di una società.
L’orologio funziona finché il meccanismo si inceppa. Il coronavirus è questo ostacolo al funzionamento del grande orologio dello Stato neoliberale: se dura molto forse l’orologio dovrà smettere di funzionare. Sennò ricomincerà daccapo, dopo aver perso qualche pezzo.
Ma se l’orologio del neoliberalismo smetterà, a che cosa torneremo?
Le diverse risposte dei governi al coronavirus lasciano perplessi e anche incuriositi. Le discussioni politiche si sono incentrate su un binomio, su una dicotomia insormontabile: economia o salute della popolazione. Per la prima volta il contrasto è stato così evidente e ha interessato intere popolazioni – e non solo casi estremi come l?Ilva di Taranto,. Che fare se la quarantena dura troppo? L’economia non si riprenderà! Dove mandare i bambini per lavorare e produrre -e magari distrarsi – se non c’è scuola? Che cosa succede a chi lavora in nero? Chi morirà? E che età ha?
Una triste scommessa era quella che si poteva fare sugli stati che avrebbero chiuso più tardi le attività: gli stati più vicini al neoliberalismo – una strana eccezione è stata la Svezia. Potremmo banalmente ipotizzare che in questi stati la salute dell’economia fosse valutata più economicamente proficua della salute della popolazione. O si potrebbe dire che la cultura politica neoliberista, a cui non spaventa la logica del darwinismo sociale, non aveva timore né vergogna di ipotizzare “l’immunità del gregge” per cui sarebbero fatalmente morti tanti – ma deboli. In fondo l’economia doveva andare avanti – ricordo un articolo americano in cui si paragonava il coronavirus agli incidenti stradali dovuti al lavoro: se per necessità economica bisogna sopportare il rischio di incidenti di lavoro sarebbe stato giusto per il giornalista prendere in conto anche il rischio della morte per coronavirus. Fra parentesi: è un virus, questo, che tanto si adatta al neoliberismo: un virus che coplisce i più deboli e lascia vivere i più forti e quelli che hanno un futuro più lungo.
Se il virus ha una nazionalità perché non un’idea politica?
La realtà però è diversa da quello che immaginiamo e proprio nei paesi di cultura politica neoliberale in cui il sistema sanitario è più a rischio – alcuni di questi con sistemi sanitari privatizzati – sono stati più evidenti gli effetti catastrofici della pandemia. In tutti gli Stati il virus ha riportato la politica a un tema da cui si era “staccata”, astratta: la vita. É come se il virus abbia riportato la politica alla sua prima funzione, la salvezza della vita. O forse non è proprio così.
Sarebbe meglio dire che la pandemia ha riportato alla ribalta la politica come il momento decisivo, come decisione su quali compiti darsi, quali scelte fare. Nessuno se non la politica può scegliere oggi se seguire la strada della sostegno dell’economia o della cura della popolazione, nessuno se non essa può scegliere tra immunità del gregge o quarantena. Lo Stato viene reinvestito della sua responsabilità primaria, della scelta che è stata sempre iscritta nei suoi compiti: vita dei molti o produttività di alcuni? Sua è la scelta di estendere il rischio della morte alle categorie più deboli – che comunque moriranno – o a tutta la società – e a coloro che non riescono a piangere i loro morti. Il rischio può ridiventare rischio comune – siamo tutti contro il virus – o rischio dei più deboli – soli contro il virus, abbandonati dal tessuto sociale e politico, mandati a morire senza poter essere compianti. Solo lo Stato può scegliere quale sarà la strada.
Lo stato o gli stati? Anche in questo caso il rischio può diventare il rischio condiviso condiviso – come il debito – fra vari stati o il rischio individuale, di uno Stato contro tutti. Il grande legislatore sceglierà, la politica sceglierà. L’Europa potrebbe ritornare a condividere, a riaffermare la sua utopia socialdemocratica – come sperava Tony Judt – ritornare – con buona pace di chi ha paura della torsione “biopolitica” dello Stato – a curare il corpo dello Stato, come corpo collettivo.
Ma, mi chiedo: che cosa c’è di più biopolitico di uno stato neoliberale, dei meccanismo social-darwinisti di competizione che lasciano cadere i deboli e trionfare i forti? Che cosa significa “abbracciare i lebbrosi” come auspica Agamben, quando si rischia di contagiare tanti altri? Non significa forse arrendersi alle regole della natura e assicurare al più forte, e solo a lui, la sopravvivenza? Non è forse l’apoteosi della forza come tale, della salute a tutti i costi – e il dispregio della vecchiaia, della debolezza – misurare la politica con quello che si accorda alla materialità, alla forza, alla violenza? Non è invece, come afferma Maria Pia Paternò, la cura uno slancio al di fuori della legge della natura che ci spinge a lasciare i più deboli dietro di noi e a andare avanti, facendo trionfare la vita?
La pandemia ci ha fatto materialmente fare un passo indietro, a tutti: alcuni sono arretrati, altri sono sprofondati in una serie di problemi infiniti, in appartamenti piccoli, senza internet e sovraffollati, senza sapere come guardare al domani. Tutti però ci siamo dovuti fermare: abbiamo decelerato. Forse, allora, invece di riguardare alle differenze, al fatto che alcuni hanno decelerato meno di altri, dovremmo guardare alla differenza fra il prima e il poi della pandemia. Decelerare potrebbe essere in fondo un esercizio per sfrondare la vita di quel ritmo che ci rende affannati e competitivi per essere pronti a scattare in avanti rispetto agli altri. Decelerare in politica potrebbe darci l’opportunità di darci il tempo di riconsiderare le basi del nostro patto sociale e politico e di dar risposta a problemi – come quello ecologico – che necessita risposte lente. Decelerare potrebbe significare considerare l’importanza dei funerali e dei festeggiamenti, l’importanza di una società in cui i morti debbano essere contati tutti, dai novantenni ai ventenni, dai medici al personale addetto alle pulizie negli ospedali – di cui, ironia della sorte, non ci sono classifiche. Decelerare significa dar tempo all’orologio della politica di contare il tempo con più lentezza, lasciare che l’orologio si inceppi e non aver paura del tempo che perdiamo.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo