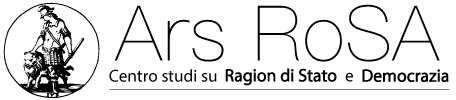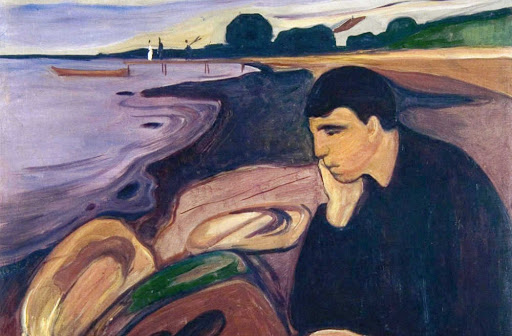
Pubblichiamo l’introduzione di Barbara De Rosa a volume, da lei curato, dal titolo Forme del malessere nell’orizzonte contemporaneo (Alpes, 2021). Il volume raccoglie i contributi di studiosi nel nostro centro di Studi.
non siate più angosciati davanti a questo / incompiuto, esso è già avvenuto (…) / è questo incompiuto che vi ha fatto umani, / non abbiate vergogna dunque di non / essere stati fabbricati! (Gori, 2016)
È particolarmente difficile introdurre un volume che si presenta al pubblico nello spartiacque di un evento mondiale estremo, ma che è stato pensato, costruito e lavorato prima di esso[1]. E non solo perché ci si trova, un po’ inebetiti, nel bel mezzo di un’aporia: da un lato, dover tenere dentro questo evento, non poterlo non includere nello sforzo di pensiero che tenta di tessere un filo introduttivo a contributi pluridisciplinari che, nel pre-pandemia, si sono cimentati con l’oggetto complesso ed insaturo ‘forme del malessere contemporaneo’; dall’altro lato, dover introdurre questo oggetto con la consapevolezza che esso è ormai profondamente influenzato dall’evento, i cui contorni, implicazioni e conseguenze sono, però, al momento insondabili. Occorrerebbe attendere, con pazienza, il terzo tempo del trauma per poterlo davvero lavorare, il tempo dell’après coup: «preziosa e spesso sconvolgente ripresa che dà senso a ciò che fino ad allora, di fronte al reale dell’evento, era fuori pensiero» (Kaës, 2020, p. 188), ed invece siamo nel primo tempo, quello a caldo, dove prevale la «turbolenza degli affetti, dei processi primari, delle organizzazioni difensive» (ib.).
Eppure, anche se i contributi qui presentati precedono l’evento pandemico che inaspettatamente sarebbe occorso di lì a sei mesi, mi sembra che la loro ‘attualità’ risalti proprio in virtù di un effetto che la situazione estrema esercita rispetto alla realtà – economica, politica, sociale, culturale, relazionale – su cui essa va ad incidere. L’attuale pandemia che, nonostante il caldo del primo tempo, possiamo certamente considerare come un altro dei traumi storici con cui la nostra specie dovrà fare i conti, mi sembra avere avuto la funzione di rendere estremamente visibile ciò che, nel cantuccio sempre più ristretto del nostro benessere occidentale, veniva facilmente occultato, negato, nella maniacalità onnipotente della nostra ipermodernità. È come se la situazione estrema – un po’ come tutte le situazioni estreme che la storia dell’uomo ha conosciuto (De Rosa, 2020a) – fungesse da lente di ingrandimento sull’umano e sul mondo che, attivamente e passivamente, abbiamo contribuito a costruire, facendo emergere dalla complessità del reale, e rendendo perciò palese, quei bisogni, quei valori, quei compiti di Kulturarbeit cruciali per la nostra sopravvivenza fisica e psichica, individuale e collettiva.
Devo, però, specificare che questa lente di ingrandimento mi sembra sia stata attiva piuttosto nei primi mesi di lockdown quando, per molte categorie di studenti e di lavoratori[2], la vita forzatamente rallentata dalle limitazioni imposte, ma protetta tra le mura domestiche, ha aperto uno spazio-tempo potenziale di pensiero fino ad allora aggredito dalla velocità mortifera in cui vortica la nostra contemporaneità, da quella cultura dell’eccesso e dell’urgenza (Kaës, 2012) che, come novella strategia di asservimento, azzera il tempo lento di cui ha bisogno il il pensiero critico su noi stessi, sulle nostre scelte quotidiane, sul mondo che ci circonda e la possibilità di vita activa (Arendt, 1958) che ne consegue. Ed è il binomio virtuoso ‘lentezza-protezione’ che credo abbia favorito questo spazio potenziale, nella misura in cui solo in un contenitore protetto e riparato dall’eccesso di angoscia possiamo provare ad affrontare la fatica e la sofferenza psichiche che il fare i conti con la complessità del reale richiede, cercando di fronteggiare le sfide ed i compiti aporetici di Kulturarbeit che la storia ed il nostro presente ci assegnano (De Rosa, 2018a). Ma è durato poco.
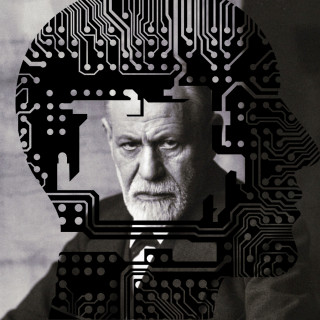
Già l’estate 2020, quella da troppi interpretata come un liberitutti, con il suo portato di diniego dilagante in collusione con le ciniche esigenze del mercato, ha fatto sbiadire questo spazio potenziale, che si è ancor più ristretto nella seconda ondata pandemica dell’autunno successivo in cui, pagata a caro prezzo quella collusione, ci siamo trovati a fronteggiare l’angoscia della disillusione proprio mentre le esigenze non più rimandabili della macchina produttiva statale ci imponevano una complessa ed ansiogena ripresa della vita lavorativa in presenza, ma nel bel mezzo di una ripresa esponenziale della curva dei contagiati e dei morti.
E così, pian piano si sono re-inabissati, perdendosi come «lacrime nella pioggia», quel senso quasi eroico di stare contribuendo, attraverso le limitazioni cui ci siamo sottoposti, al bene della comunità e non solo al proprio; quel riaffiorare di un senso di comunità, fagocitato dall’alienazione delle nostre ipermetropoli e nel lockdown nutrito della ritrovata, preziosa, fiducia di poter incidere, ognuno nel suo piccolo, su un système in cui chiaramente tout se tient; quel valore della solidarietà verso i nostri simili più fragili e più svantaggiati fatto di spese sospese e panari solidali; quel bisogno estremo di condivisione e di supporto reciproco nei flashmob, nei canti collettivi dai balconi, nell’esposizione di striscioni dai buoni auspici; quel bisogno di legame a qualunque costo e con qualunque mezzo pur di preservare il bene prezioso dell’altro, un bisogno rivelatosi primario ed inalienabile proprio nel momento in cui ci veniva precluso.
E, invece, la mistura angosciante tra disillusione e ripresa della vita nel suo esclusivo versante del dovere[3], nonostante e all’interno della seconda ondata pandemica, mi sembra ci abbia velocemente riportati dal ‘non ci si salva da soli’ al tristo e pericoloso ‘si salvi chi può’.
Eppure abbiamo visto. Con l’evidenza dirompente di una lente di ingrandimento abbiamo visto come la globalizzazione, figlia prodigio della tecnica che titilla la nostra onnipotenza illudendoci che ‘tutto è possibile’, si paga al caro prezzo della globalizzazione anche delle malattie; non possiamo più rigettare al di fuori del nostro cantuccio di benessere le conseguenze inevitabili della nostra hybris, come effetti collaterali che toccano solo i reietti delle nostre città e del nostro mondo, esse sono qui ed ora, con ciascuno di noi. Abbiamo visto che laddove le politiche predatorie neoliberali hanno maggiormente devastato il bene primario di una sanità pubblica e della medicina territoriale di base, là la pandemia ha colpito più duramente. Abbiamo goduto dei nostri cieli acquietati dal rumore assordante degli aerei, di un’aria cittadina ripulita da un drastico abbassamento dei livelli di inquinamento a livello globale, con il crollo del prezzo di quel petrolio che è all’origine di tanti conflitti sanguinosi e di una devastazione ambientale che ormai, probabilmente, è fuori controllo. Abbiamo visto la natura e i suoi abitanti riprendersi lo spazio cittadino usurpato arbitrariamente da una specie, la nostra, che non sembra aver mai assunto fino in fondo il decentramento imposto dalla rivoluzione darwiniana. Costretti a relazioni virtuali, già ampiamente dilaganti nel nostro mondo relazionale, la loro forzata esclusività ce ne ha fatto constatare la povertà, accrescendo a dismisura il bisogno di contatto fisico ed evidenziando l’imprescindibilità della sensorialità per la ricchezza dell’incontro con l’altro. Per non parlare delle relazioni di cura, incardinate sulla responsabilità etica del soggetto maior nell’asimmetria necessaria al loro svolgimento, e della consapevolezza impotente che le ha accompagnate e le accompagna di uno svilimento, fino alla vanificazione, dell’incontro filtrato da un oggetto disumanizzante come lo schermo. Abbiamo visto quanto è povera una vita senza cultura, con teatri, musei e cinema chiusi, forse abbiamo visto addirittura che non è la corsa all’accaparramento di oggetti a poterci arricchire, ma quei legami che fino a questo momento davamo per scontati. Abbiamo potuto riflettere su quanto il disinvestimento sulla scuola delle politiche scellerate degli ultimi decenni, con classi-pollaio e strutture fatiscenti, abbia costretto l’ossatura portante del futuro di un paese a barcamenarsi dietro uno schermo, perdendo impotenti schiere e schiere di giovani; lo pagheremo caro e non sappiamo ancora quanto. In una società che ha perso il senso dell’importanza dei riti per la tenuta della collettività (Kaës, ib.), ne abbiamo avuto dolorosa contezza, con la preclusione del rito di accompagnamento dei defunti che ci ha spinti ad un’involuzione ferina: «Dal dì che nozze e tribunali ed are/Dier alle umane belve esser pietose/Di sé stesse e d’altrui (…) Ahi! sugli estinti/non sorge fiore ove non sia d’umane/lodi onorato e d’amoroso pianto» (Foscolo, 1807, vv. 91 e 88).
Considerazioni, queste, inevitabilmente superficiali e drammaticamente non esaustive per l’entità e la complessità dello sconvolgimento che il nostro mondo sta subendo e subirà a seguito di questa pandemia, il loro scopo è solo ribadire un’evidenza che, al contempo, contiene un compito di Kulturarbeit inevaso e cruciale. Ciò che l’ipermodernità ha tentato onnipotentemente di cancellare con la collusione individuale e collettiva, oggi ci ritorna addosso con la violenza del reale: la mancanza, i limiti, la fragilità e l’incompiutezza dell’umano, temi quanto mai centrali nei contributi qui presentati. Negli ultimi decenni, tantissime ed autorevoli sono le voci levatesi a denunciare l’insostenibilità di questa nostra contemporaneità, che paghiamo ad un prezzo troppo elevato in forme del malessere. E se, finora, esse potevano apparire come un altro monito inascoltato di Cassandra, adesso s’impongono piuttosto come un: cosa credevate? Ecce homo.

Così, alla luce del nostro presente, appare felice la decisione pre-pandemica di proporre in apertura di questo volume il lavoro di Roland Gori[4] che, con ardore, muove ai suoi lettori l’invito a «prendere la misura di una dimensione antropologica essenziale»: l’incompiutezza dell’umano con cui i mestieri impossibili di freudiana memoria – educare, governare, analizzare – devono fare i conti, pena il trasformarsi in pratiche di cura totalitarie.
Se l’incompiuto, il mancante, il limitato è dell’ordine dell’umano – alle cui radici vi è il fil rouge freudiano dell’Hilflosigkeit[5], tratto specie-specifico fonte di fragilità psichica, ma anche delle più alte conquiste spirituali, nella misura in cui la mancanza diviene fonte dinamica per lo sviluppo e la creatività – la sua assunzione nella relazione di cura dei mestieri impossibili li iscrive nel paradigma del dono (Caillé, 2013) e nella sorgente dell’etica (Schneider, 2011). Non può non venire in mente il paragone che Winnicott utilizza per descrivere la conditio sine qua non di un esito sufficientemente sano della relazione asimmetrica, il cui emblema è quella primaria, inscritta nel necessario paradosso impotenza/onnipotenza, ma di cui la vita umana è, in diversi gradi, costellata e nel cui tratto asimmetrico è racchiuso il potenziale maturativo, formativo, curativo ed emancipativo offerto al soggetto minus: «una madre e un padre non fabbricano un neonato come un vasaio fa un vaso», offrono le basi perché un potenziale diventi atto, ma se le cose vanno sufficientemente bene ciò che il figlio «diventerà è fuori dal controllo di tutti» (1963, p. 222). Non, dunque, ‘il fallimento’, come sottolinea Gori, è la «regione antropologica, ontologica»dei mestieri impossibili, bensì quella dell’insufficienza eticamente consustanziale dei loro esiti. Laddove il ‘fallimento’ mette in primo piano la delusione, svelando l’anelito onnipotente delle pretese soggiacenti, grazie al lavoro del lutto l’‘insufficienza’ apre alla dimensione artistica, artigianale dei mestieri impossibili, incentrata sull’inedito, la contingenza, la pluralità, interna ed esterna, condizioni della facoltà di pensare, la più politica tra le facoltà umane. Sono in gioco gli imprevisti di sapere che auspica Chicchi attraverso i movimenti ‘non lineari’ e ‘non consecutivi’ del suo contributo, o l’emersione di quel soggetto imprevisto che Arienzo pone come occasione cui apre l’esperienza dello smarrimento.O, ancora, l’accesso alla possibilità di «sperimentare di essere indifesi», raccontata da Gaillard nell’evoluzione di una dinamica gruppale che, dalla turgidità difensiva fallica, conduce al ritrovamento della solidarietà e della capacità di fronteggiare la difficoltà attraverso «l’enunciazione pacificatrice di un limite».
«È la parola condivisa nella pluralità degli esseri e delle culture che permette la creazione di un mondo comune senza il quale s’installa il ‘deserto’», scrive Gori convocando Hannah Arendt, laddove – tragedia del nostro presente – «la modernità impatta su questi ‘mestieri impossibili’ inclinandoli incessantemente verso la tecnica», seducendoli e degradandoli ad una dimensione di fabbricazione allo scopo di adattare l’essere umano a questo deserto. Il vasaio prevale, ed il governo tecnico sull’umano, illudendosi di annullare onnipotentemente l’angoscia dell’incertezza, ha come esito una disumanizzazione pervasiva.
Come mai prima d’ora la pandemia mette questa nostra società di Narciso di fronte al compito cruciale di fare i conti con il limite, fornendoci l’occasione di iniziare quel lavoro di lutto necessario a ritrovare la dimensione artistica, artigianale della nostra esistenza; e, come mai, di fronte a ciò risalta l’asservimento cui ci ha condotti questa contemporaneità tutta votata all’eccesso, dietro cui c’è l’affermazione economica, politica, culturale e psicologica del neoliberismo, con la sua logica disumanizzante. Dialogando ampiamente con la psicoanalisi, ce ne parlano, in questo volume, i filosofi politici Arienzo e Sebastianelli e il sociologo Chicchi. La dismisura, ci dicono, è la cifra di quella che va considerata una burnout society,in cui è crollato ogni confine «tra lavoro e non lavoro, tra produzione e vita», tra pubblico e privato, cancellando quel principio ordinativo, la separazione funzionale tra società e Stato di cui, dal Leviatano di Hobbes, il sovrano si faceva garante (Arienzo). «L’impresa neoliberale è riuscita nel capolavoro di realizzare soggetti i cui desideri coincidono con gli obiettivi aziendali» (Sebastianelli), la logica dell’impresa definisce ormai la soggettività stessa e la dimensione di ipercompetitività, distruttrice del legame sociale e di solidarietà, pervade lo spazio inter ed intrapsichico. Siamo passati dalla società della disciplina alla società della prestazione (Chicchi, Simone, 2017), in cui il soggetto neoliberale ha interiorizzato il controllo e l’autosfruttamento di sé: «il ‘negativo’ non rappresenta più l’alterità della norma sociale, che impone dall’esterno una dialettica di repressione/rimozione; esso è stato soppiantato da una norma sociale positiva e immanente che impone un ‘poter-fare’ in ogni contesto e ambito di vita» (Sebastianelli). E la società della ‘positività’ ha generato una violenza sistemica dai tratti autodistruttivi, una ‘violenza neuronale’, l’ha definita Han, che genera ‘infarti psichici’, risultando «ben più fatale perché la vittima di questa violenza si crede libera» (2010, p. 97).

In una società Io-cratica dove il Super-io è stato soppiantato dal perverso Io ideale, la prestazione diventa «il luogo di scrittura privilegiata del fare Io», l’ultrasoggetto del neoliberismo, sedotto, violentato e spinto dall’interiorizzazione della logica di impresa a ‘superare i propri limiti’, si identifica potentemente «con la prova economica della sua performance, trasformando ogni cosa in oggetto, quantità, algoritmo, posta in gioco» (Chicchi). L’alterità interna ed esterna scompare ed il diniego della castrazione la fa da padrone, ovvero diniego del limite, della mancanza che ci rendono umani. La soggettività intossicata dall’illusione della perfezione, spinta oltre i suoi limiti estremi dal diktat dell’empowerment, supportata dall’ipertrofia dello psicofarmaco o ri-adattata dalle forme di coaching che pervadono le relazioni di cura, ha perso il valore cruciale per la crescita del fallimento, dell’inciampo evolutivo, dell’errore di fronte ai quali, per il soggetto, si apre solo il baratro della vergogna. L’imperativo dell’auto accelerazione che mette in scacco la possibilità di «sostare» e, dunque, lo spazio del pensiero, ci rende burattini nelle mani del pasoliniano potere senza volto, facendoci perdere il senso della nostra esistenza. Così reificati, in un processo disumanizzante che, per sua natura, procede nelle due direzioni (De Rosa, 2020b, 2021) anche l’altro diviene cosa, mero oggetto di consumo, nella modalità privilegiata di relazione che, nel suo lavoro, Gaillard definisce predazione cannibalica «una delle figure-chiave attraverso cui la barbarie si dispiega nel nostro mondo contemporaneo (…) fonte di slegame mortifero (…) godimento cannibalico che (…) rifiuta all’altro il suo statuto di simile nella differenza [e che], al tempo stesso, distrugge l’alterità interna al soggetto (…) il discredito, l’arroganza, il disprezzo, la crudeltà partecipano di tale movimento (…) non estraneo alla violenza radicale che conduce a gettare l’altro fuori dal mondo» delle pagine più oscure della nostra storia.
Legittimato dallo sfondo ideologico-politico dell’ultraliberalismo, assistiamo alla distruzione mirata e progressiva «del bene pubblico, a favore esclusivo del bene privato», che mette a repentaglio la base stessa del vivere insieme, fragilizzando profondamente «soggetti, gruppi, istituzioni» (Gaillard). Siamo confrontati ad un rischio di de-istituzionalizzazione che, nel suo contributo, Sommantico spinge oltre ricordando il contributo profetico di Green agli inizi degli anni ’90, il rischio di una de-civilizzazione. E a fenomeni inquietanti di de-civilizzazione abbiamo iniziato ad assistere a quasi un anno dall’inizio di questa pandemia, che non a caso riguardano i nostri giovanissimi. Frotte di preadolescenti ed adolescenti che, attraverso i social media, si danno appuntamento in presenza con l’unico scopo di darsela di santa ragione, miscela nefasta tra iperesposizione narcisistica mediatica ed ormai ingestibile costrizione coattiva della loro vita, i cui sintomi di slatentizzazione della violenza sociale non sono contenuti da quella capacità, che si acquisisce con la crescita grazie al modello fornito dall’adulto, di modulare l’aggressività, indirizzandola, impastata, verso mete costruttive. Non può non tornare in mente il processo di imbarbarimento[6] di un gruppo di ragazzini naufraghi e privi di riferimenti adulti raccontato da Golding (1980) nel suo romanzo distopico. Accenno, così, ad un altro fil rouge di questo volume su cui tornerò più avanti, la profonda crisi della relazione asimmetrica di cui siamo responsabili noi adulti contemporanei.
Se nella nostra ipermodernità l’imperativo categorico del «godi!», a prescindere[7], orienta la costruzione della soggettività e dei legami sociali, in un paradosso solo apparente esso ha prodotto la fragilizzazione progressiva del desiderio, questione cruciale qui lavorata, con diverse prospettive disciplinari, da Thanopulos, Chicchi, Arienzo e Sebastianelli. Vien da riprendere il monito goethiano citato da un Freud osservatore disincantato dei primi baluginii scintillanti della ‘perfetta’ società della tecnica: «niente è più difficile da sopportare di una serie di belle giornate» (1929, p. 568, n.). Mettendo l’accento sulla funzione propulsiva del limite, la nota in questione accompagna parole sagge e, dalla nostra visuale dell’oggi, profetiche: «Quel che nell’accezione più stretta ha nome felicità, scaturisce dal soddisfacimento, perlopiù improvviso, di bisogni fortemente compressi (…) siam così fatti da poter godere intensamente soltanto dei contrasti» (ivi). Se tutto è possibile, niente è godibile.
La perfezione, scrive Thanopulos, uccide il piacere in una noia senza limiti: «L’agire performante (…) ha come suo modello inconsapevole l’efficienza perfetta di una macchina che riproduce instancabilmente il proprio funzionamento (…) un meccanismo che trasforma la profondità in superficialità, il sentire in anestesia, la differenza in uniformità, in-differenza». Già, l’indifferenza[8], male pervicace dei nostri giorni, effetto di una profonda disoggettualizzazione (Green, 2000), una tendenza che ci riporta allo stadio precedente la nascita del soggetto, l’incontro con l’altro e, dunque, con l’odio (Freud, 1915) e che partecipa della tendenza allo zero dell’apparato psichico, ovvero della pulsione di morte (Cupa, 2012).

In un assetto psichico irrigidito, continua Thanopulos, che ricorda l’apparato psichico post-traumatico descritto da Freud (1920), il piacere si riduce alla scarica immediata della tensione e ritorno; gli fa eco Chicchi suggerendo l’immagine di un «movimento ventricolare (di cattura e rilascio, di apertura e chiusura come uno sfintere anale) che agisce più sul segno dei processi che sul loro contenuto». Piacere, desiderio e creatività necessitano di quell’imprevedibilità cui apre la dimensione artistica, artigianale dell’esistenza che Sommantico, riprendendo la distinzione winnicottiana tra game e play, ricorda consente il gioco, quell’area transizionale che a tutte le età della vita ne supporta la fatica psichica rendendola degna di essere vissuta.
Il meccanismo perfetto, prevedibile ed autoreferenziale, che non può concedersi il lusso di inciampare nutrendosi dei suoi errori, produce inerzia e la ribellione contro questa reificazione ad ingranaggio di una macchina assume oggi l’inquietante forma dell’astensione dalla vita (Thanopulos). La clinica contemporanea è una clinica della pulsione di morte (Recalcati, 2010). Queste «chiusure identitarie» (Arienzo), di cui è emblema la sindrome di Hikikomori che colpisce con sempre maggior virulenza la nostra gioventù; l’astensione da un «coinvolgimento vero, profondo, nelle relazioni con gli altri e con il mondo [che si accompagna] ad un diffuso senso di povertà erotica, etica e affettiva», generano un sentimento di orfanilità, scriveThanopulos; ci sentiamo orfani «della solidità di valori democratici fondamentali, (…) dell’affidabilità delle istituzioni (…), dei legami solidali (…) di relazioni di scambio sufficientemente regolate e garantite» ed è un sentimento che «mette in crisi l’introiezione della qualità genitoriale dell’esistenza: la capacità di gestire la propria vita assumendone pienamente la responsabilità e fidandosi della propria creatività, in continuità e, al tempo stesso, in discontinuità con la propria tradizione». Oggi assistiamo, dunque, allo scacco di quella possibilità, fondante la costituzione del soggetto, descritta nell’adagio goethiano tanto caro a Freud: «ciò che hai ereditato dai padri/Riconquistalo se vuoi possederlo davvero» (Freud, 1912-13, p. 161).
Thanopulos collega la crisi delle relazioni affettive, l’eclissi del desiderio ed il conseguente sentimento di orfanilità alla crisi del rapporto erotico tra madre e padre, supporto ineludibile della funzione genitoriale. Oltre l’evaporazione del padre di lacaniana memoria, è in gioco «la rottura del patto coniugale» da cui discende «il patto tra genitori e figli (…) patto di trasmissione e di reciproco riconoscimento». Tenderei ad estendere ulteriormente la questione alla crisi generalizzata delle relazioni asimmetriche, ovvero di quella cruciale funzione adulta (De Rosa, 2012, 2014a) che si esercita nei mestieri impossibili. Mi sembra, perciò, che a giusto titolo Sommantico colleghi all’ipotesi di Thanopulos quella di Kaës (2005, 2012) sul crollo dei garanti metasociali e metapsichici che strutturano individuo e società, ricordandone la connessione con la crisi della famiglia nel suo «ruolo di crogiuolo identificatorio, di contenitore identitario e di involucro genealogico». La questione viene ripresa da Parrello che, nel suo lavoro, rilegge il romanzo di Coe dal vertice delle alleanze inconsce e della trasmissione intergenerazionale, rintracciando la riduzione dell’individuo a homo oeconomicus e l’esordio di quei processi senza soggetto di cui parla Kaës, nell’avvento neoliberale thatcheriano della fine degli anni ’80.
Il processo di crescita individuale ed il processo di incivilimento, che procedono in parallelo, sono resi possibili dalla progressiva assunzione del limite, da quella rinuncia, ambivalente e mai definitiva, alla logica del tutto e subito che connota il nostro ingresso di neotenici nel mondo; questo compito faticoso, doloroso ed incessante di Kulturarbeit è reso possibile dall’incontro con i modelli adulti che via via incontriamo sulla strada vita e che, assumendosi la responsabilità di soggetti maior,si fanno garanti e custodi della funzione strutturante e nutritiva che, in tutte le sue declinazioni, svolge la differenza, altra declinazione del limite. Ma vi è sempre una quota di assoggettamento alla direzione, cosciente ed inconscia, che il soggetto maior fornisce nell’esercizio della sua funzione, una quota di violenza «necessaria per far accedere il soggetto all’ordine dell’umano» (Aulagnier, 1975, p. 161) che, nelle sue derive patologiche individuali e collettive, può trasformare la potenzialità virtuosa dell’asimmetria in dominio sull’altro (Dorey, 1981; Bonnet, 2002; Clit, 2002, Bettelheim, 1943; e cfr. De Rosa, 2018b).
Oggi assistiamo ad una profonda crisi del legame intergenerazionale nella famiglia (Sommantico, 2012), nelle istituzioni formative (Parrello, 2018), nel governo del bene comune (Arienzo, 2015), ovvero delle funzioni e delle strutture di contenimento che reggono individuo e comunità (Bauman, 2000; Kaës, 2012). Il processo di orizzontalizzazione del legame che seduce verso ‘soluzioni’ utopiche omogeneizzanti (Kaës, 2008; Sommantico, 2012); il diniego del carattere asimmetrico della relazione e la tendenza all’inversione dei ruoli; l’affievolimento della funzione normativa e dell’assunzione di responsabilità nell’adulto contemporaneo, che rinuncia a porsi come modello di valori etici condivisi e trasmissibili e di una gestione del conflitto sufficientemente sana in cui diventa possibile esprimere e lavorare la nostra distruttività, sono sintomi di un’estrema fragilità narcisistica del soggetto maior nell’esercizio delle sue funzioni. La ricerca di Iorio sulla crisi che investe gli insegnanti, presentata in Appendice, ce ne dà un assaggio.
Ed è nel lavoro proposto qui da Accati che troviamo un filo conduttore tra diniego onnipotente del limite, dunque di mancanza e differenza, crisi della relazione coniugale – intesa quale incontro contrattuale tra differenze che fonda la compagine sociale – ed il dispiegarsi di una cultura del dominio che segnala la difficoltà di lavorare l’aggressività interna al gruppo sociale, costituito nella sua strutturazione di base dalla famiglia in relazione con altre famiglie.
La ricerca quarantennale dell’autrice, di taglio storico-antropologico, è focalizzata sull’interpretazione dell’immaginario cattolico della sacra famiglia rappresentato nell’arte, immaginario che orienta le relazioni di parentela e la costruzione stessa della società. Accati ci spinge a rivolgere lo sguardo indietro nel tempo: la crisi del patto coniugale e dell’autorità paterna – di conseguenza quelle della funzione adulta e del legame intergenerazionale di cui tanto si parla oggi – appaiono effetti di un processo lento e ben più antico che affonda le sue radici nell’affermazione storico-religiosa del culto mariano nel 1600 e, ancor più indietro, nel passaggio dall’ebraismo al cattolicesimo quando, con l’affermarsi del Nuovo Testamento, la «coppia di filiazione figlio-madre (Cristo-Maria) [prende il] posto della coppia coniugale padre-madre (Adamo-Eva)». L’immaginario religioso, espresso nella straordinaria arte pittorica e scultorea dell’età moderna, reitera la rappresentazione di un clima incestuale in cui la potente relazione asimmetrica degli inizi viene invertita, «la madre diventa ancilla Domini e il Dominus è il figlio» ed in cui, pertanto, il figlio divinizzato viene privato di un modello maschile di riferimento; la conseguenza è che «il figlio resta in balìa della madre e la madre del figlio», in una relazione apparentemente idilliaca che nasconde un lato oscuro di profonda ostilità per l’impossibilità della separazione. Espungendo la coppia coniugale come base strutturante della compagine sociale e, così, smantellato l’ordine del paterno, il culto mariano dell’immacolata concezione serve una Chiesa-Madre identificata con il materno arcaico, ed una politica del dominio basata sulla dipendenza e l’assoggettamento dell’altro, che vede nell’assimilazione cannibalica la modalità privilegiata di rapporto con l’altro, ovvero quella logica predatoria, pervasiva ai nostri giorni, di cui ci parla Gaillard. Dunque non v’è posto per l’incontro, confronto e scontro tra differenze, né per l’attraversamento del conflitto e sua risoluzione in un’ottica contrattuale, nessuna possibilità di riconoscere e lavorare l’aggressività interna alla compagine sociale, ma una reiterazione coattiva di capri espiatori da assoggettare in cui si incarna (e proietta) la differenza. Così, la cultura e la politica della Chiesa cattolica si inserisce armoniosamente nel progetto sociale di dominio di quell’Impero Romano con cui ai suoi albori deve fare i conti: «Il dominio nella cultura occidentale d’ispirazione cristiana ha sempre avuto esattamente questo tipo di dinamica: mortificare cioè eliminare o fisicamente o moralmente gli uomini usando il materno». Ma lascio ai lettori il piacere di scoprire questa prospettiva[9] che, in questo volume, parte dall’analisi della trasformazione del significato simbolico del rituale di espiazione nel passaggio dall’ebraismo al cattolicesimo dove, con la centralità assunta dalla Passione di Cristo simbolizzata dal crocifisso, si sposta l’asse del governo dell’aggressività dall’interno all’esterno.

È tempo di chiudere questa introduzione impossibile,che si è sforzata di indicare nel fil rouge che unisce i contributi qui presentati una possibile chiave di lettura cui il trauma pandemico in cui siamo immersi ci confronta, ovvero l’incontro con il limite e la mancanza, un incontro di certo problematico, aporetico, irresolubile, ma il cui sforzo costituisce un onere etico, uno strumento essenziale per la preservazione dell’umano e un’arma contro quel narcisismo di morte (Green, 1983) in cui da troppo tempo la nostra civiltà occidentale masochisticamente si crogiola.
Vado dunque a concludere richiamando ciò che incarna questo incontro e su cui i lavori di Gaillard e Gori si soffermano con particolare cura: il femminile e ciò che ad esso è consustanziale, il suo rifiuto[10]. A beneficio dei non addetti ai lavori va esplicitato che in psicoanalisi il femminile, ben al di là del genere sessuale, designa una configurazione psichica che, in Freud, tende a divenire il paradigma stesso del funzionamento dell’apparato psichico, nella misura in cui esso è in grado di «accogliere l’estraneità (dell’altro e di sé come altro), svolgendo una funzione di legame, di simbolizzazione e di trasformazione», ce lo ricorda Gaillard richiamando l’importante lavoro di Monique Schneider (2011). In questa configurazione psichica si produce «l’accettazione dell’incompletezza, del vuoto, della perdita e, di conseguenza, di un’alterità possibile» (Gaillard). Il femminile, «nella psiche e nel sociale, sollecita il soggetto ad emergere da una chiusura narcisistica (…) l’affermazione di uno svuotamento, di una rinuncia, di una mancanza e la condivisione di un limite al godimento sono alla base del lavoro di civiltà e di umanizzazione» (Gaillard). Ma è proprio nella sua connotazione di accoglienza, nella tolleranza all’esser alterati, disfatti nel e dall’incontro con l’alterità che il femminile può facilmente essere associato ad un «vissuto di passivizzazione (…) sminuito al registro di un’insopportabile castrazione immaginaria» che ne genera il rifiuto. Si può, così, «aprire la strada ad un disprezzo pieno d’odio, alla messa in atto della violenza più estrema» (Gaillard); la ricerca di Osorio-Guzmàn in appendice ci ricorda l’attualità del problema.
Se il femminile «non è monopolio delle donne» (Gori), il rifiuto del femminile non lo è degli uomini; che sia donna, uomo, omosessuale, transgender, asessuale o qualunque altra variegata declinazione dispiegata nel nostro contemporaneo, l’essere umano è implicato nella condizione antropologica del rapporto con la mancanza e, di conseguenza, nel suo ‘rifiuto’ nel quale Gori intravede, oltre la ‘roccia biologica’ su cui si infrange l’analizzabilità (Freud, 1937), «una ribellione contro l’incompiuto».
Ma l’incontro con il limite è consustanzialmente aporetico, lo sottolineano in maniera diversa entrambi gli autori: «Il femminile ci confronta con la sua impossibilità di afferrarlo. Non appena si prova a coglierlo come qualcosa dentro di sé, non appena si ha l’illusione di padroneggiarne il movimento, esso si sottrae[11], si fortifica e ci si ritrova nuovamente di fronte ad un oggetto eretto al posto della cavità indispensabile al lavoro di trasformazione» (Gaillard). Se nel femminile è in gioco la «posizione soggettiva» di ciascuno verso la mancanza che, secondo Gori, chiarisce la formula lacaniana l’amore della verità è l’amore della castrazione, e se il rifiuto del femminile limita questo anelito alla verità, «una verità assoluta (…) una realtà evidente» costituiscono un’altrettanta «pericolosa illusione» (Gori). Decenni addietro Chasseguet-Smirgel (1975) evidenziava lo stesso paradosso, ricordandoci che la realtà, veramente guardata in faccia, avrebbe probabilmente lo splendore accecante della morte. Altrove mi sono soffermata su questo paradosso e sull’aporia cui esso ci confronta (2016, 2020b), ma anche sulla fecondità delle aporie (De Rosa, 2014b) come luogo di tensione in cui, se riusciamo a sostarvi almeno un po’, può dispiegarsi la possibilità di cogliere la complessità del reale ed anche una direzione possibile cui indirizzare lo sforzo di Kulturarbeit, a patto – però – di prendere in carico la nostra fragilità ed il bisogno di contenitori solidi per poterci fare i conti.
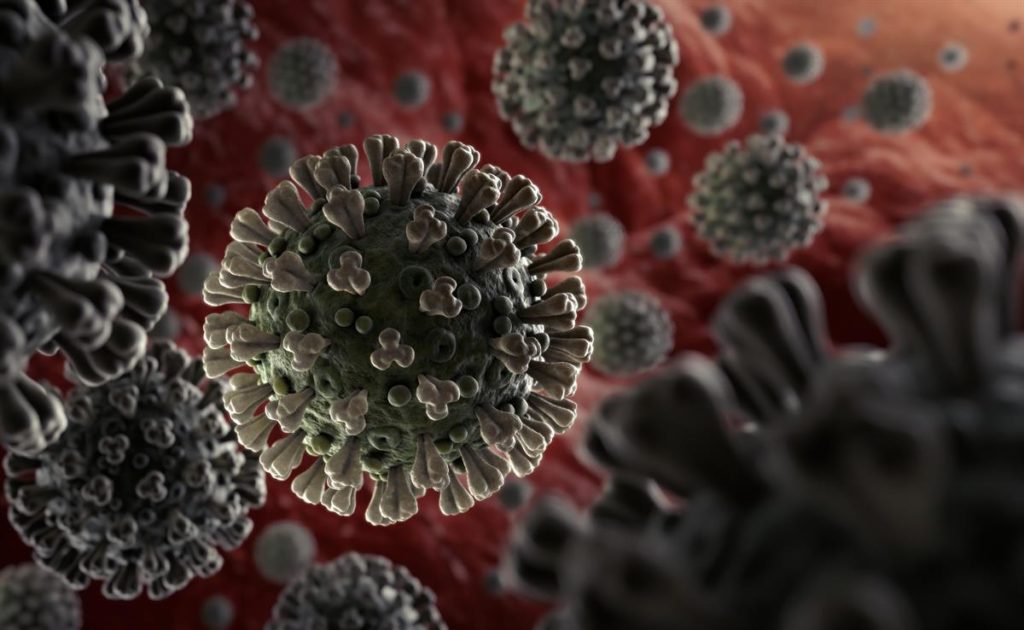
Il trauma pandemico – che di fase in fase mostra volti sempre nuovi[12] – è un’occasione straordinaria per soffermarci su ciò che affiora all’evidenza in virtù del contesto estremo, per lavorarlo e, attraverso le piccole scelte quotidiane della vita di ognuno, sforzarci di trovare un modo diverso di stare a questo mondo e di averne cura. In altri termini è un’occasione di Kulturarbeit ma, come tutte le occasioni, può essere sprecata.
Nella direzione opposta, mi sembra di intravedere l’avvenire di una distopia, di cui le voci profetiche dell’arte ci parlano da tempo e tra cui vorrei ricordare il recente Candido (Brera, 2021), per l’effetto decisamente perturbante in virtù della sua prossimità.
Contro le derive de-civilizzanti che, nello scintillio di tutte le declinazioni dell’iper, il nostro violento ed autodistruttivo contemporaneo alimenta surrettiziamente, attraverso dinamiche primitive disgreganti e di reificazione reciproca, «abbiamo bisogno di istanze che garantiscano un ordine umanizzante, e possiamo sperarle fondate su valori altri rispetto alla dominazione e alla servitù» (Kaës, 2012, p. 54).
Riferimenti bibliografici
A.A.V.V. (2016), l’indifferenza, notes per la psicoanalisi, 7, Roma, Alpes editore.
A.A.V.V. (2018), rifiuto del femminile, notes per la psicoanalisi, 11, Roma, Alpes editore.
Accati L. (1998), Il mostro e la bella. Padre e madre nell’educazione cattolica dei sentimenti, Milano, Raffaello Cortina editore.
Accati L. (2007), Scacco al padre, Venezia, Marsilio.
Accati L. (2017), Apologia del padre, Milano, Meltemi.
Arendt H. (1958), Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1958.
Arienzo A. (2015), Il lavoro del comune, in Arienzo A., Borrelli G. (a cura di), Dalla rivoluzione alla democrazia del comune. Lavoro, singolarità, desiderio, Napoli, Cronopio.
Aulagnier P. (1975), La violenza dell’interpretazione, Roma, Borla, 2005.
Bauman Z. (2000), Modernità liquida, Bari, Laterza.
Bessoles P. (2011), Figure de l’emprise. Propagande et fanatisme, Topique, 114/1.
Bettelheim B. (1943), Comportamento individuale e di massa, in Sopravvivere, SE, Milano, 2005.
Brera G.M. e il collettivo I Diavoli(2021), Candido, Milano, La nave di Teseo.
Caillé A. (2013), Antiutilitarismo e paradigma del dono, Napoli, Diogene.
Chasseguet-Smirgel J. (1975), L’ideale dell’Io. Saggio psicoanalitico sulla ‘malattia d’idealità’, Milano, Raffaello Cortina editore, 1991.
Chicchi F., Simone A. (2017), La società della prestazione, Roma, Ediesse.
Clit R. (2002), La terreur comme passivation, Topique, 81/4.
Cupa D. (2012), L’indifférence: l’«au-de-là» de la haine, Revue française de psychanalyse, 76/4.
Cuzzocrea A. (2021), Che fine hanno fatto i bambini ? Cronache di un paese che non guarda al futuro, Milano, Mondadori.
De Rosa B. (2012), Società postmoderna, legami familiari e bisogni individuali: la funzione adulta in crisi, in B. De Rosa, M. Osorio Guzmàn, S. Parrello, M. Sommantico (a cura di), Famiglie e coppie nell’orizzonte post-moderno. Note teoriche, cliniche e di ricerca, Roma, Aracne, pp. 45-60.
De Rosa B. (2014a), La crisi della funzione adulta: prospettive contemporanee nella relazione asimmetrica, in C. Moreno, I. Iorio, S. Parrello, La mappa e il territorio, Palermo, Sellerio, pp.182-189.
De Rosa B. (2014b), Lo spirito anarchico, in B. De Rosa (a cura di), Il male dal prisma del Kulturarbeit. Sull’opera di Nathalie Zaltzman, Milano, Franco Angeli.
De Rosa B. (2016), La resistenza dell’umano: situazione-limite, testimonianza ed ascolto. Una lettura psicoanalitica, Iride. Filosofia e discussione pubblica, 79/XXIX, pp. 531-550.
De Rosa B. (2018a), La Kulturarbeit et ses défaillances : passé et présent’, in R. Hamon, Y. Trichet (sous la direction de), Les fanatismes, aujourd’hui. Enjeux cliniques des nouvelles radicalités, Rennes, PUR (France), pp- 163-182.
De Rosa B. (2018b), Le mal extrême, arcanum imperii, arcanum humani. Un regard intégré sur la notion d’emprise, Cliniques Méditerranéennes, 2/98, pp. 179-191, doi : 10.3917/cm.098.0179.
De Rosa B. (2020a), Nathalie Zaltzman et l’enjeu du Kulturarbeit dans la rencontre entre témoignage et écoute», in J.-F. Chiantaretto, G. Gaillard (sous dir. de), Psychanalyse et culture : l’œuvre de Nathalie Zaltzman, Paris, Ithaque, pp. 215-225. accenno a convegno centro psicoanal roma?
De Rosa B. (2020b), Le mal, la Kulturarbeit : en revenant sur L’esprit du mal de Nathalie Zaltzman, Connexions, 113, pp. 197-210.
Dorey R. (1981), La relation d’emprise, Nouvelle Revue de Psychanalyse, 24.
Foscolo U. (1807), Dei Sepolcri, Milano, Il Muro di Tessa, 2010.
Freud S. (1912-13) Totem e tabù, OSF, 7, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
Freud S. (1915), Pulsioni e loro destini, OSF, 8, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
Freud S. (1920), Al di là del principio di piacere, OSF, 9, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
Freud S. (1929), Il disagio della civiltà, OSF, 10, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
Freud S. (1937), Analisi terminabile e interminabile, OSF, 11, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
Golding W. (1966), Il signore delle mosche, Milano, Mondadori, 1980.
Gori R. (2016), Governare, educare, analizzare: tre mestieri impossibili?, in B. De Rosa (a cura di), Forme del malessere contemporaneo. Un dialogo interdisciplinare, Roma, Alpes, 2021.
Green A. (1983), Narcisismo di vita, narcisismo di morte, Roma, Borla, 1992.
Green A. (2000), La mort dans la vie, in J. Guillaumin (sous la dir. de), L’invention de la pulsion de mort, Dunod, Paris.
Han B.-C. (2010), La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2012.
Kaës R. (2005), Il disagio del mondo moderno e la sofferenza del nostro tempo. Saggio sui garanti metapsichici, Psiche, 2.
Kaës R., (2008), Le complexe fraternel, Paris, Dunod.
Kaës R. (2012), Il malessere, Roma, Borla, 2013.
Kaës R., (2020), Notes sur les espaces de la réalité psychique et le malêtre en temps de pandémie, Revue Belge de Psychanalyse, 77, pp. 187-218.
Recalcati M. (2010), L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina, Milano.
Parrello S. (2018), Scene dal futuro. Adolescenza, educazione e distopia, Franco Angeli, Milano.
Schiappoli L. (2016), Editoriale, in notes per la psicoanalisi, 7.
Schneider M. (2011), La détresse aux sources de l’éthique, Paris, Seuil.
Sommantico M., (2012), Il fraterno. Teoria, clinica ed esplorazioni culturali, Roma, Borla.
Winnicott D.W. (1963). Lo sviluppo dell’individuo dalla dipendenza all’indipendenza, in: Sviluppo affettivo e ambiente, Roma, Armando, 1970.
[1] Il volume è frutto del Convegno omonimo che ho organizzato il 24 maggio 2019 presso la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli grazie al patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici e dell’Ateneo Federico II di Napoli.
[2] Esclusi, naturalmente, gli operatori sanitari che, come soldati in prima linea di questa nuova guerra, hanno dovuto fronteggiare quasi a mani nude la violenza dell’impatto pandemico pagando personalmente un prezzo elevatissimo sul piano fisico e psichico.
[3] Troppo spesso, a mio parere, si sottovaluta quanto la modalità di lavoro in smartworking sia solo apparentemente più facile ed efficace, essa implica un notevole surplus di fatica psichica nella misura in cui il ‘dovere’ non viene compensato dal ‘piacere’ che deriva dal lavoro in comune, dalla condivisione di sensorialità impercettibile ma cruciale, delle occasioni di confronto ed anche di scontro, delle pause, e di quell’inatteso che solo in presenza ha modo di dispiegarsi. Ciò vale ancor più drammaticamente per le giovani generazioni, private dell’ossigeno rappresentato dalla socialità e, nel momento in cui hanno potuto recuperarla con la riapertura delle scuole, costretti dalle necessarie misure di sicurezza a tenersi lontani dai coetanei, privandosi di quell’insieme di piccoli piaceri che compensano la fatica del lavoro scolastico e la rendono produttiva.
[4] Presentato nel gennaio 2016 al Convegno internazionale ed interdisciplinare da me organizzato presso l’Ateneo federiciano insieme a Mariella Ciambelli, Santa Parrello e Massimiliano Sommantico.
[5] Sulla cui crucialità si troverà, nel contributo del filosofo Sebastianelli, una voce dissonante.
[6] Zaltzman (2007) rilegge il romanzo interpretando questo processo piuttosto come la nascita di una neorealtà.
[7] Mi perdoneranno i lettori non partenopei per questa citazione di un grande osservatore dell’umana miseria e fragilità, Antonio de Curtis in arte Totò, che dietro l’arte della comicità ci ha donato uno specchio propriamente ‘tragico’ e profondamente umano di noi stessi. ‘A prescindere’ è stato il titolo dell’ultima rivista portata in scena alla fine degli anni ’50 ed una delle locuzioni più celebri i cui titoli di nobiltà affondano le radici nel teatro di Petrolini.
[8] Nel 2016 la rivista notes per la psicoanalisi ha dedicato un numero al tema dell’indifferenza, «grado zero dell’affettività (…) antitetica al dolore [che] chiama in causa il narcisismo (…) l’indifferenza all’umano che ci atterrisce nella de-soggettualizzazione di individui e popolazioni» (Schiappoli, p. 5).
[9] Il contributo presentato in questo volume è solo un assaggio che certamente non rende onore all’originalità e complessità della ricerca di Accati, per un approfondimento cfr. 1998, 2007, 2017.
[10] Anche a questo tema la rivista notes per la psicoanalisi ha dedicato molto spazio, nel 2018 esce il numero 11, rifiuto del femminile, nel lutto della perdita improvvisa della sua Direttrice, Lucia Schiappoli.
[11] Sembra comportarsi allo stesso modo lo sforzo di Kulturarbeit di cogliere la dimensione del male nell’uomo di cui Zaltzman ci parla nel suo ultimo libro (2007).
[12] Al momento risalta agli occhi l’indecente ed irresponsabile battage con cui si sta gestendo la comunicazione relativa ai vaccini, come se la scienza non avesse sempre proceduto per prove ed errori; come anche, ancor più preoccupante per la mia sensibilità, l’invisibilità in cui sono stati immersi, e continuano ad esserlo, i bisogni e le estreme difficoltà in cui versano i nostri bambini e giovani, lo testimonia il recente lavoro di Cuzzocrea (2021).
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo