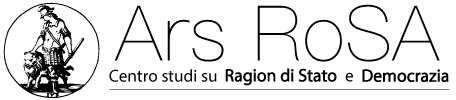Osservazioni su alcuni particolari dei Praecepta gerendae reipublicae e del Non posse suaviter vivi secundum Epicurum di Plutarco di Paolo Cosenza (pubblicato nel numero 6, 1998 del Bollettino Ars).
I Praecepta gerendae reipublicae di Plutarco sono una sorta di lettera aperta rivolta agli uomini politici greci del suo tempo. Il senso del messaggio è che la classe dirigente greca non deve lasciarsi sfuggire la possibilità di gestire, nei modi e nelle occasioni più favorevoli, quel tanto di libertà politica concessa da Roma sul piano dell’amministrazione locale alle singole poleis, ma senza mai fomentare atti di ribellione contro il domino romano, che Plutarco ritiene incontrastabile[1].
Per quanto concerne la gestione del potere, uno dei concetti principali del messaggio è che, poiché la classe dirigente locale ha bisogno del consenso popolare per poter governare, chi raccoglierà i consigli contenuti nel testo dell’operetta non deve trascurare la grazia e la potenza della parola oratoria, in quanto strumento utile per il conseguimento del favore popolare. Ora il popolo (δῆμος) a cui l’uomo politico dovrà indirizzare la sua azione oratoria è concepito come un soggetto collettivo totalmente incapace di autogoverno, turbolento e sospettoso. L’eloquenza politica di cui l’uomo politico dovrà avvalersi nella sua opera di governo può perciò richiedere, secondo Plutarco, in ragione del mediocre livello della massa popolare, particolari accorgimenti strumentali che siano atti in determinati casi a conseguire, anche indipendentemente dall’intrinseca giustezza dei progetti proposti, quegli speciali effetti persuasivi che le circostanze richiedano[2].
Tra i suggerimenti consigliati v’è un certo stratagemma oratorio da seguire nel caso che il popolo sospetti che qualche provvedimento importante e salutare sia proposto invece per favorire qualche privato interesse di gruppo[3]. Premesso che per Plutarco l’attività politica deve avere come principio direttivo la superiorità di tutto ciò che è comune e pubblico (τα κοινά και δημόσια)[4] su tutto ciò che attiene all’interesse privato, conviene brevemente esporre quanto previsto in questo stratagemma, perché c’è in esso qualche particolare che può aiutare a correggere un’inesatta interpretazione che della funzione dell’eloquenza politica nei Praecepta gerendae reipublicae potrebbe essere suggerita dall’accentuato moralismo che contraddistingue la concezione politica plutarchea. Quando ricorra il caso sopra indicato, coloro che vogliono fare adottare in assemblea il provvedimento dovranno concertare i loro interventi in modo che inizialmente non tutti prendano a perorarne l’approvazione, affinché non sembri che essi si siano precedentemente messi d’accordo. Dovranno piuttosto gli amici distribuirsi i compiti in modo che due o tre di essi, prima, esprimano un parere contrario e, poi, come se venissero convinti dalle argomentazioni degli altri, recedano dallo loro opposizione. Il fatto che lo stratagemma preveda che alcuni politici fingano di essere contrari alla proposta durante una certa fase del dibattimento, sta a mostrare come, nella concezione politica plutarchea, l’interesse del bene pubblico può ben giustificare che in determinate circostanze sia dato anche spazio a quanto, essendo in se stesso un disvalore, non meriterebbe di essere ammesso a far parte della condotta di un buon uomo di stato, ove non fosse finalizzato al superiore interesse generale[5].
Questo dello stratagemma assembleare non è l’unico caso che nella produzione plutarchea sia riconducibile sotto la categoria di ciò che oggi comunemente si intende per “Ragion di Stato”.
Particolarmente significativo è anche quanto Plutarco dice, nel Non posse suaviter vivi secundum Epicurum, circa le ragioni per cui è socialmente utile la presenza della superstizione (δεισιδαιμονία) in una certa categoria di uomini.
Il proposito principale che Plutarco persegue in questa operetta è dimostrare che non può essere affatto felice la vita di chi segua i dettami dell’edonismo epicureo. Ai piaceri ammessi dall’epicureismo Plutarco contrappone nella sezione finale (20, 1100 E -31,1107 C) la gioia dell’esperienza religiosa, a cui gli epicurei, per la particolare concezione della natura degli dèi propugnata da Epicuro, non possono mai accedere. Al fine di mostrare che la fede nella potenza degli dèi e del loro ruolo nell’ordinamento cosmico si accompagna effettivamente a sentimenti di altissima contentezza, Plutarco svolge alcune considerazioni con cui tende a mostrare che la religione correttamente intesa e praticata è cosa totalmente diversa dalla superstizione. La divinità, che non può fare né patire nulla di male, è incline soltanto a far del bene e non compie mai illeciti favori. Poiché è su questo altissimo concetto della divinità che va fondato il sentimento e il culto religioso, la superstizione, in quanto è una paura degli dèi che promana da un diverso ed errato concetto della natura del divino, è un male e perciò il filosofo la deve sempre respingere da sé con orrore[6]. Ciò però non comporta che, senza alcuna distinzione, si debbano tenere tutti gli uomini lontani da un siffatto male. L’umanità si divide in tre categorie: quella degli ingiusti e malvagi (τò tϖν αδίκων και ποηρϖν), quella degli ignoranti e quella dei buoni e intelligenti. In quest’ultima categoria non vi potrà essere mai della superstizione; può invece essa di fatto albergare nella categoria degli ingiusti e malvagi e in quella degli ignoranti. Ora Plutarco sostiene che negli ingiusti e malvagi si deve inspirare almeno un poco di superstizione (προσεμ ϕορητέον … τησ δεισιμονίας), affinché all’idea delle punizioni dell’Ade essi se ne stiano più buoni e quieti (έπιεικέστερον έχειν χαΐ πραότερον)[7]. Ciò significa che, se già non c’era della superstizione, bisogna, limitatamente a questa delle tre categorie etico-sociali in cui Plutarco suddivide l’intera umanità, favorirne almeno una qualche presenza. E’ chiaro dunque che in questa operetta plutarchea la superstizione è vista come un possibile strumento di dominio [8], finalizzato al mantenimento dell’ordine sociale[9].
[1] Cfr. Th. Renoirte, Les « Conseils politiques» de Plutarque. Une lettre ouverte aux Grecs a l’ époque de Trajan, Louvain, 1951, pp. 65-88.
[2] Cfr. P. Cosenza, L’eloquenza politica e l’arma del ridicolo secondi i Praecepta gerendae reipublicae di Plutarco, Istituto Universitario Orientale – Dipartimento di filosofia e politica, “Studi filosofici” XX, 1997, pp. 7-3O.
[3] Cfr. Praecepta gerendae reipublicae ( ed. A. Caiazza, Corpus Plutarchi Moralium, Napoli ) 16, 813 B. Cfr. inoltre al riguardo J.Cl. Carrière, in Plutarque, Oeuvres morales, XI, Deux. partie, Paris 1984, Notice, pp. 47-48.
[4] Cfr. Praecepta gerendae reipublicae ( ed. cit. ), 13, 8O7 B.
[5] Platone, in Respublica ( ed. I. Burnet, Oxford ) III 389 b-c, aveva sostenuto che nello stato ideale, mentre ai privati non è mai consentito dire il falso, d’altra parte, in vista dell’interesse della città, ai governanti conviene mentire a causa dei cittadini. Come è ovvio, ciò è ammesso da Platone solo per quei casi in cui la menzogna sia strettamente necessaria al bene della città. Cfr. inoltre Respublica (ed. cit.) II 382 c; III 414 b-415 d.
[6] Cfr. Plutarco, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum ( ed. B. Einarson-Ph.H. Lacy, Cambridge, Mass. ), 21, 1101 C-1102 A. Cfr. inoltre id., De superstitione.
[7] Cfr. Plutarco, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum ( ed. cit. ), 25, 11O4 A – B.
[8] Plutarco, che in Vitae parallelae, Numa ( ed. R. Flacelière, Paris ) capp. 4, 8 mostra di dubitare che Numa avesse sposato la ninfa Egeria ed avesse avuto con lei degli incontri segreti, fa rilevare, in questa stessa Vita ( cfr. id., 8 ) che Numa, annunziando strane apparizioni demoniache e voci minacciose, cercava di soggiogare e umiliare con il timore della divinità l’animo altero e feroce degli abitanti della Roma antica.
[9] Per quanto concerne la religione popolare, un’analoga valutazione si trova, già prima di Plutarco, presso Crizia ( Diels-Kranz, 88, fr. 25 ). Cfr. inoltre Polibio, XVI 12.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo