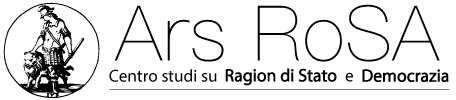di Giovanni Della Peruta. Questo saggio è stato pubblicato sul numero 7 (1999-2000) del Bollettino del Archivio della ragion di Stato. Era il primo, ma importante, contributo scientifico di un giovane studioso sulla ratio status nella Vicereame spagnolo a Napoli.
Introduzione
Il presente articolo ha come obiettivo l’analisi di particolari aspetti della produzione politica teorica e delle pratiche di governo nella Napoli spagnola dei primi decenni del XVII secolo. Mentre nel Novecento, generazioni di storici, a partire da Croce per giungere fino ai più recenti contributi di studiosi di storia sociale, economica e del diritto, hanno dato vita ad una vasta produzione storiografica, si riscontra un interesse solo secondario per quanto riguarda le scritture politiche meridionali del Cinque-Seicento, in particolare per gli autori meno conosciuti, ma non per questo meno significativi, del panorama politico napoletano[1]. Al contempo è possibile segnalare la sostanziale assenza, per quanto riguarda l’Italia, di studi specifici e monografie dedicate ai viceré che, nel volgere di due secoli di dominazione spagnola, hanno governato il Regno di Napoli[2].
Una delle finalità di questo lavoro, consiste nell’accostare a quanto già è stato scritto sulla storia del Regno di Napoli, non un’ulteriore ricostruzione di fatti ed eventi, ma una lettura, in una prospettiva di storia del pensiero politico, dell’opera di governo di uno dei più interessanti, quanto controversi, viceré spagnoli, il III duca d’Ossuna. L’analisi di alcune questioni emerse durante il suo viceregno, si propone di far risaltare momenti significativi delle modalità di produzione di potere politico nel contesto napoletano. Il tentativo sarà quello di relazionare documenti relativi al governo ossuniano (1616-1620), con alcune scritture politiche contemporanee e con documenti di governo prodotti dai consigli di Stato e d’Italia e da altri vicerè napoletani. L’intreccio tra scritture e pratiche di governo, il relazionamento tra produzione teorica e dispositivi politici indirizzati alla produzione di obbedienza, esplicitano momenti distinti e relativamente autonomi, ma certamente chiamati entrambi a costituire il campo dell’intervento politico finalizzato alla conservazione dello Stato. La frequenza con la quale ricorrono alcune tematiche relative alla gestione del territorio, al governo dei ceti, al rapporto tra potere sovrano delegato e poteri locali, la loro circolazione in ambiti diversi quali quelli della corte madrilena e il contesto napoletano, segnalano infatti, nuclei concettuali e pratiche operative intorno a cui si svilupparono i discorsi e le dinamiche di potere nella Napoli spagnola. Occorre però, prima di addentrarsi nell’analisi dei documenti, specificare alcune linee-guida relative ai dibattiti in corso nella corte spagnola e in ambito napoletano, al fine di collocare storicamente e politicamente il governo dell’Ossuna e far emergere relazioni e discontinuità, dipendenza e autonomia, della politica e della produzione teorica napoletana nel più ampio contesto dell’impero spagnolo.

Le acquisizioni della produzione storiografica sottolineano, per quanto riguarda il Regno di Napoli, un deciso cambiamento della élite politica, avvenuto intorno alla metà del Cinquecento, durante il viceregno di Don Pedro de Toledo. In corrispondenza con quanto stava avvenendo in Spagna, con la sostituzione degli esponenti dell’alta aristocrazia con i letrados nelle cariche burocratiche ed amministrative, a Napoli il gruppo dei togati,nell’arco di pochi decenni, occupò stabilmente le più alte magistrature politico-amministrative e finanziarie, ovvero il Collaterale e la Camera della Sommaria[3]. I nobili, dunque, già a partire dagli ultimi anni di Carlo V, vennero sostanzialmente estromessi dal controllo delle magistrature napoletane, processo che fu amplificato durante i quarant’anni di regno di Filippo II, con il quale si fece più chiaro l’indirizzo politico della monarchia, sia all’interno della Castiglia che nelle province europee. Il processo di “burocratizzazione” delle strutture di governo napoletane portò all’affermazione di un gruppo, quello togato, politicamente abbastanza omogeneo ma difficile da decifrare per quanto riguarda l’estrazione sociale dei singoli componenti. Certamente i togati appartenevano a quel ceto mezzano, sulla cui funzione essenziale per il mantenimento dell’ordine sociale si stavano pronunciando i teorici della Ragion di Stato, ma per molti di essi, in particolar modo per coloro che occupavano le posizioni di maggiore prestigio, la carriera nelle magistrature apriva le porte al processo di arricchimento attraverso la rendita, di anoblissement o all’acquisto di feudi nelle province del regno. Il fatto che coloro che erano chiamati alla conduzione degli affari di governo avessero degli interessi non in tutto dissimili, anzi a volte coincidenti, con la nobiltà di antico regime, fu probabilmente uno degli elementi che determinarono un certo immobilismo nella struttura sociale napoletana, non essendoci, secondo quanto afferma la più moderna storiografia, dei reali interessi da contrapporre a quelli dominanti, né proposte innovative da negoziare con il potere centrale. Giovanni Muto sottolinea, a proposito dei togati, che «la mancanza di un solido retroterra economico distinto, come fonte di arricchimento, dalla rendita urbana e le contraddizioni interne a queste stesse forze, impedirono loro di tradursi in un blocco sufficientemente omogeneo che contrattasse con il centro politico le condizioni di un assetto e di un equilibrio nuovi»[4]. In effetti, un elemento che divenne strutturale nel Regno di Napoli, a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo, fu rappresentato dall’assenza di dinamiche sociali ed economiche volte ad incrementare la produzione ed il commercio, testimoniato proprio dalla distanza delle scelte politiche, che procedevano in ben altra direzione. L’esigenza sempre più pressante da parte di Madrid di ottenere finanziamenti dalla provincia napoletana, l’elevata pressione fiscale sulla produzione e sui consumi, non trovarono a Napoli una forte opposizione, che riuscisse a coinvolgere anche i gruppi dirigenti, invischiati anch’essi nel processo di progressiva dipendenza dell’economia napoletana dalla finanza estera[5]. Va dunque sottolineato, che mentre il gruppo togato emerge ed acquista una sua specificità e visibilità all’interno del ceto mezzano, non trovano invece adeguato riconoscimento pubblico e rappresentanza politica, quegli interessi fondati sulla produzione e sullo scambio. La “repubblica dei togati[6]“, vuoi per limiti interni e strutturali, vuoi per una precisa volontà politica della corte madrilena, non riuscì a costituire un valido supporto per la costituzione di quella “repubblica dei mercanti”, auspicata e teorizzata da Vittorio Lunetti[7].
In tale contesto la ragione giuridica ed il sapere giurisprundenziale giocano un ruolo decisivo nei processi di conservazione politica e nell’articolazione dei poteri all’interno della Città e nei rapporti tra Napoli e Madrid. Il diritto, inteso come produzione giuridica e nei suoi canali di scorrimento istituzionali, diventa un luogo privilegiato nella determinazione dei rapporti di forza, funzionando di volta in volta da strumento o da obiezione all’assolutismo monarchico[8]. Un assolutismo che a Napoli non presenta come dato costitutivo la contrapposizione tra accentramento delle funzioni amministrative e finanziarie, in particolar modo di quelle fiscali, nelle mani del sovrano e resistenza dei poteri locali, poiché la linea perseguita dai vari sovrani spagnoli fu quella di appoggiarsi ai gruppi locali, per quanto riguarda il controllo sociale, e ad un gruppo di mercanti-banchieri, in gran parte forestieri, per assicurarsi la copertura finanziaria per le operazioni belliche. Nel clima di incertezza che caratterizzò la monarchia castigliana già durante il regno di Filippo II, sembra possibile affermare che il dibattito presente nella corte, condizionò largamente le modalità di governo e le stesse teorie e pratiche dell’assolutismo nelle province dell’impero e dunque anche nel regno napoletano. Già intorno al 1560, nel Consejo de Estado si fronteggiavano due fazioni, una facente capo al duca d’Alba, l’altra al principe di Eboli, intorno alla maniera migliore di risolvere il conflitto nei Paesi Bassi. Gli esponenti che condividevano le posizioni del duca d’Alba erano per la linea dura: soffocare la ribellione, cancellare le libertà provinciali ed imporre strutture di governo e uomini castigliani al potere. Al contrario gli uomini del principe di Eboli erano per una conclusione pacifica del contenzioso e per la conservazione delle libertà e dei privilegi locali, soluzione auspicata per il complesso dei domini europei, sul piano distinto della produzione teorica, dal catalano Furiò Ceriol[9]. Analoga situazione si verificò intorno agli anni Ottanta, questa volta però durante il processo di annessione del Portogallo alla Corona; il cardinale Granvelle pensava che l’annessione avrebbe portato dei significativi vantaggi alla Castiglia, solo qualora Filippo avesse deciso di ridurre drasticamente le libertà portoghesi. Tuttavia la decisione di Filippo II contravvenne ai consigli del Granvelle ed il monarca invece, optò per la conservazione degli statuti e delle strutture tradizionali. Ritroviamo ancora le due distinte posizioni durante la rivolta aragonese del 1591-92[10]; vi sono dunque buone ragioni per affermare che una delle principali preoccupazioni che la monarchia dovette affrontare fu proprio quella relativa al governo delle province, questione su cui trasparivano profonde diversità di vedute.
La questione del costituirsi delle fazioni all’interno della corte castigliana e la lotta che si sviluppò in essa, sia per accaparrarsi le ricchezze messe a disposizione dal tesoro regio, che per imporre una linea politica piuttosto che un’altra, si acuì profondamente con l’introduzione del valimiento ad opera di Filippo III[11]; proprio la lotta politica all’interno della corte, può rappresentare una delle possibili chiavi di lettura dei quattro anni di governo napoletano del III duca d’Ossuna. La storiografia, soprattutto quella spagnola, ha messo l’accento sulla situazione che si creò dopo la morte di Filippo II e l’ascesa al trono del figlio; ad una corte sterile, politicamente inetta e corrotta, si contrapporrebbe, secondo tali storici, il cosiddetto “partito cattolico”, i cui esponenti di spicco furono il marchese di Bedmar, ambasciatore spagnolo a Venezia, il conte di Fuentes, il governatore di Milano, Pedro Alvarez de Toledo e lo stesso duca d’Ossuna, considerato il capo della fazione[12]. Se può considerarsi eccessivamente drastico il giudizio di questa parte della storiografia spagnola, è senz’altro vero che tra Filippo III ed il suo valido, il duca di Lerma, ed i rappresentanti regi nella provincia italiana, vi erano grosse divergenze quanto meno su una delle questioni centrali per uno stato moderno, quella della guerra. Ma non fu solo la guerra l’unico motivo di attrito; per quanto riguarda il duca d’Ossuna in particolare, i consigli centrali si trovarono spesso a dover moderare l’attivismo del viceré, che attraverso lo scavalcamento delle normali procedure “costituzionali”, portava continui attacchi alle strutture di governo locali e a molti rappresentanti della élite politica napoletana. Lo stesso può dirsi dell’organizzazione della milizia di stanza nel regno, per la quale l’Ossuna sconsigliava di porre al comando «naturali del regno», proponendo invece una drastica centralizzazione del comando a guida castigliana[13]. In tutto ciò è possibile intravedere una preferenza dell’Ossuna -che evidentemente era la preferenza di una parte della corte spagnola-, per una soluzione autoritaria del governo delle province, quella, per intenderci, che all’epoca di Filippo II era propria della fazione del duca d’Alba. Certamente, queste soluzioni dovevano andarsi ad innestare in uno scenario, come quello napoletano, attraversato da contraddizioni e conflitti, terreno tradizionalmente ostico per quei viceré che tentavano di sminuire il valore e la portata politica dei privilegi locali. La sconfitta del progetto ossuniano, seppur compresa all’interno di un cambio di potere nella corte di Madrid, se testimonia della scelta della monarchia di portare avanti l’opera di governo lasciando comunque intatte, almeno formalmente, le strutture di governo napoletane e le garanzie dei ceti privilegiati, segnala anche una difficoltà interna al percorso conservativo: l’Ossuna, nel suo tentativo di rendere più flessibile il governo napoletano alle esigenze della monarchia, si era imbattuto nell’opposizione di parte del gruppo togato, su cui la corte faceva affidamento per tenere sotto controllo gli umori dell’alta aristocrazia. Tale gruppo, secondo il viceré, se non vincolato strettamente alla volontà vicerale, rischiava di costituire un blocco di potere comunque pregiudizievole nei confronti del potere sovrano.
Nelle vicende che caratterizzarono il regno di Napoli tra Cinquecento e Seicento dunque, vi sono poteri diversi che si intrecciano e che finiscono con il costituire la specificità del contesto napoletano. Da una parte il viceré, rappresentante del potere regio, impegnato nel tentativo di applicare le direttive di Madrid, mediandole attraverso pratiche soggettive di comando. Dall’altra, la dinamica cetuale cittadina, con i vari gruppi che si contendono la guida del governo e con l’emergere di un sapere specificatamente giuridico-politico, utilizzato come strumento di lotta cetuale e come difesa dell’autonomia del regno dagli attacchi di una certa pratica dell’assolutismo che mirava a restringere i margini delle libertà e dei privilegi locali[14]. Il diritto, codificato o consuetudinario, dunque, si configura come elemento di conservazione dello status quo, ma anche come possibilità di apportare delle innovazioni all’interno dell’apparato di governo napoletano. In tal senso infatti, si esprimevano le scritture politiche di parte popolare, tra le quali vanno segnalate, in particolar modo, le opere di Giovanni Antonio Summonte e di Francesco Imperato e la scrittura -pochi anni prima della rivoluzione del 1647- di Camillo Tutini[15]. Mentre dunque, da un punto di vista storico-politico, le vicende dell’Ossuna si svolgono sullo sfondo di due questioni politiche essenziali, i rapporti dinamici tra centro e periferia dell’impero e l’aperta conflittualità tra poteri cittadini diversi, in particolare tra Piazze nobili e Piazza popolare, il macrocontesto teorico-politico è rappresentato dalle teorie e pratiche di conservazione politica elaborate e sperimentate in varie parti d’Europa tra la fine del ‘500 e la prima metà del secolo successivo, che vanno sotto il nome di Ragion di Stato. Il viceregno dell’Ossuna allora, sarà considerato alla luce di tali emergenze di conflittualità, alle quali il vicerè tentò di dare uno sbocco positivo attraverso l’elaborazione di una politica pratica fondata sull’accentramento dei poteri nelle mani del vicerè con l’appoggio dalla Piazza popolare. Per portare a termine tale opera occorreva neutralizzare politicamente la potente nobiltà di piazza e subordinare al potere viceregio quel ceto togato nelle cui mani era concentrato il governo politico, amministrativo e giudiziario.

Discorsi e pratiche di conservazione politica a Napoli: il governo del III duca d’Ossuna
Le vicende dell’Ossuna sono conosciute innanzitutto alla luce del vero o presunto tentativo di costituire a Napoli un regno indipendente con l’appoggio di Francia, Venezia e Savoia, e sul piano interno contando sulla plebe e sul suo capo Giulio Genoino[16]; tale progetto, tuttavia, non risulta dai documenti di accuse dei nemici del viceré, i quali invece puntano l’accento sul progetto di separazione violenta tra la nobiltà e il popolo, interpretato come «publica revolutione e seditione tentata»[17], ma con esclusivo riferimento ad uno sconvolgimento dell’assetto dei poteri locali. D’altra parte la richiesta di separazione amministrativa e giurisdizionale formava parte delle rivendicazioni della Piazza popolare e, seppur inserito all’interno di un possibile assetto giuridico-formale, era il concetto fondante il Discorso politico di Francesco Imperato[18]. E’ possibile che il progetto dell’Ossuna fosse, almeno in parte, in consonanza con le scritture popolari, come testimonia l’ambasciata a corte dell’Eletto del Popolo Carlo Grimaldi. Il mancato riconoscimento da parte del re di un nuovo assetto dei poteri, potrebbe aver spinto l’Ossuna e Genoino, messi alle corde dall’offensiva nobiliare, ad agire autonomamente, provocando un’accelerazione decisiva in tale direzione. Tuttavia, obbiettivo del presente articolo non è discutere o chiarire se l’Ossuna si fosse o meno macchiato del reato di “fellonia” (questione già brillantemente analizzata dallo Schipa[19]), quanto piuttosto cercare di ricavare dal materiale documentario a disposizione, alcune teorie e tecniche di governo utilizzate dall’Ossuna in chiave di conservazione del comando. Solo impicitamente, dunque, si farà riferimento all’epilogo della vicenda ossuniana, che certamente testimonia della volontà della corte di Madrid di non introdurre novità nell’assetto politico del regno.
I viceré ricevevano insieme a tale carica anche quella militare di Capitano generale, in virtù della quale potevano operare liberamente come capi della milizia. E mentre la carica militare conferiva un potere assai ampio di deliberazione ed esecuzione, la carica di viceré implicava una serie di mediazioni, consistenti nel rispetto delle costituzioni del regno e delle normali procedure di comando in accordo con il Collaterale e nel rispetto degli organi rappresentativi cittadini riuniti intorno ai Seggi. Ed effettivamente, uno dei motivi ricorrenti l’intero arco della dominazione spagnola a Napoli, riguarda il rapporto tra potere e giustizia, inteso come accettazione da parte dei gruppi locali del potere sovrano esercitato per delega dal viceré e rispetto da parte di quest’ultimo, di quell’apparato giuridico-politico che va sotto il nome di “costituzioni del regno”. Ebbene, il viceregno dell’Ossuna non fu certo il primo caso nella storia del regno di Napoli, ma forse il più clamoroso, in cui tale rapporto, spesso conflittuale, si converte in antagonismo tra il rappresentante della volontà sovrana e i gruppi che gestivano il potere locale. Ciò che tali gruppi, nobiltà di Piazza e parte del ceto ministeriale, mettevano in discussione, non era né il potere sovrano né le funzioni detenute dalla figura del viceré, quanto piuttosto l’esercizio arbitrario di tali funzioni da parte dell’Ossuna, noncurante di costituzioni e privilegi locali. Le caratteristiche del governo dell’Ossuna, si rivelarono già durante il primo anno del suo viceregno. Uno dei suoi primi atti fu quello di concedere l’ambasceria delle Piazze nobili contro il conte di Lemos che aveva governato il regno prima dell’Ossuna. La posizione del viceré fu piuttosto ambigua: mentre da una parte concedeva l’autorizzazione alle Piazze, in virtù dell’appartenenza alla fazione contraria al Lemos, dall’altra criticava duramente la pretesa nobiliare di voler esercitare, attraverso l’ambasciata, un forte controllo sull’operato del viceré, presentandosi come interlocutori privilegiati del sovrano. Nella lettera in cui concede l’autorizzazione, l’Ossuna segnala «tres modos de gentes» presenti nelle Piazze di Napoli: coloro che desiderano il bene pubblico, quelli che attraverso il pretesto del bene comune muovono le loro passioni contro l’autorità vicereale e infine quelli che secondo il proprio utile si legano ai primi o ai secondi. Bisogna porre, secondo l’Ossuna, particolare attenzione a questi ultimi due casi, in quanto il fine a cui mirano le Piazze nobili, è quello di «sindicar a un virrey», ovvero aumentare attraverso la pressione politica il loro potere contrattuale a scapito del viceré e quindi, secondo l’Ossuna, indirettamente contro lo stesso potere sovrano:
«Conviene à su real servicio, sustento desta monarquia y reputacion della, asì en la presente era como en las porvenir, que ningunos vasallos entiendan ser poderosos à mover el animo de V.M. contra ministros tan superiores, aun con razon, siendo tan larga la mano de V.M. que por muchos caminos puede poner en todo el remedio necesario sin tocar ni à la reputacion de personas semejantes, ni que estas demandas las hayan de hacer juntas y congregaciones»[20].
La logica che sorregge l’argomentazione ossuniana, si fonda sul riconoscimento delle gerarchie e sulla necessaria reputazione di cui deve godere il rappresentante regio, elementi della politica pratica a cui deve essere sacrificato a volte anche il riferimento alla giustizia. Infatti, l’Ossuna sottolinea che tale gerarchia deve essere mantenuta anche qualora l’appello al potere sovrano sia fatto «con razon». Ciò che propone il duca al sovrano è l’interruzione della comunicazione diretta tra nobiltà locale e potere sovrano, prerogativa che, secondo l’Ossuna, spetta al solo rappresentante della volontà reale, che diventa così l’interprete principale delle esigenze e degli interessi locali:
«Pues a V.M. toca el cuidado desto [il giudizio sull’operato del viceré], sin que ellos los procuren, y à los que gobiernan los reinos informar a V.M. de la necesidad que sintieren en ellos, pues V.M. los escoje para esto, fiando dellos su defensa y gobierno»[21]
A questo riguardo, particolare interesse riveste la consulta del Consejo de Estado, residente a Madrid, perché permette di inserire la posizione dell’Ossuna nel quadro generale delle teorie e tecniche di governo che riguardano direttamente la corte di Madrid, non rinchiudendola esclusivamente nell’orizzonte, seppur presente anche nella sua valenza di orientamento politico, della gestione personale e clientelare dei poteri. La consulta è datata 17 settembre 1616 e tra i vari pareri espressi dai consiglieri, due in particolare vanno nella direzione indicata dal viceré, quello del marchese della Laguna e soprattutto, per l’importanza politica che riveste, quello del confessore del re. Il primo propone che l’ambasciatore Geronimo de Guevara si allontani dalla corte e al tempo stesso che le Piazze abbiano la possibilità di ricorrere all’autorità regia, ma non certamente nella forma dell’ambasceria. Questa forma di protesta infatti, lede uno dei fondamenti dell’autorità politica, ovvero la reputazione del rappresentante regio; collegandosi idealmente alla lettera dell’Ossuna al re, il marchese della Laguna, afferma la necessità che sia esclusivamente il re a sindacare ed eventualmente punire l’operato del viceré, senza però che l’opera di controllo e di sanzione sia affidata a «las pasiones y opiniones de los vasallos»[22]. Anche il confessore del re si allinea sulle posizioni dell’Ossuna; nella dichiarazione, si sofferma sui punti della lettera in cui il duca mette in guardia il sovrano dai pericoli che rappresenta la pratica delle ambascerie dei poteri locali a corte e sulle ripercussioni che queste possono avere nello squilibrare la gerarchia dei poteri costituiti. In particolar modo mette l’accento sulla volontà dell’Ossuna riguardo la necessità che il re favorisca l’azione vicereale a scapito delle élites periferiche: negare le ambascerie a corte va certamente nella direzione di frenare le passioni dei sudditi, legando il loro destino alla necessaria obbedienza al re, mediante il suo rappresentante.
La questione dell’ambasceria, collegata alle altre forme di ricorso al potere sovrano da parte dei sudditi, risulta essere una questione ricorrente nelle lettere e nei documenti dell’epoca; nella misura in cui rappresentava una pratica di pressione rispetto al potere viceregio, andava controllata e regolata, affinché non diventasse una messa in questione della reputazione del detentore del comando. Il vescovo di Gaeta don Pedro de Oña, in una appassionata lettera in difesa del duca scritta dopo il suo forzoso ritorno in Spagna[23], si sofferma a lungo sui rappoti tra sudditi, viceré e sovrano, qualificando come «buona ragion di Stato», la protezione del re al suo rappresentante contro le pretese di controllo e di freno che si arrogano i poteri locali. Questi devono rimanere subordinati alla necessità politica di garantire l’ordine dei poteri, considerata condizione necessaria e obbiettivo indifferibile di una politica conservativa:
«fue linda razon de estado de aquel Principe no sufrir que sus vasallos pensasen que podian quitar o poner virreyes en sus tierras quando el estaba dando reynos y señorios proprietarios a las demas partes del mundo. Los Virreyes gobernadores han de tener guardadas las espaldas por su Rey y señor, que la honra dellos sea cosa sagrada desvaneciendo en primer lugar su Magestad y sus ministros quantas querellas llegaren descaradamente a su noticia y aun castigando a quien viene con ellas, no dexando por esso de informarse de la verdad y con disimulacion y encubrimiento dan castigo al virrey que lo merece, pero no de manera que los calumniadores puedan gloriarse de haberlo conseguido. Porqué destos se siguen dos gravisimos inconvenientes: uno que el Rey con actos positivos muestra al mundo que yerra y que puede herrar cada dia en las elecciones y aunque sea asì, siempre ha que encubrirse porqué no se habituen los subditos a desestimar el Gobernador que tuvieren y aun el Rey que elije. El segundo inconveniente es que los que sindican los Virreyes hallan lugar y acoxida publica; en ninguna parte podrà administrarse justicia pues siempre destos hay malcontentos que por honras iran a la corte inquietando los mismos gobiernos. Y aunque en todo tiempo como se ha dicho ha de quedar puerta para oyr quexas de los que estan en ellos siempre ha de ser poniendoles primero en salvo la reputacion por no incurrir en los dos inconvenientes (…)»[24].
La lettera risulta oltremodo interessante in quanto collega dinamiche e pratiche di potere con i concetti propri della Ratio Status, in particolar modo con alcuni dei concetti fondanti un’efficace politica di conservazione. Reputazione e necessaria dissimulazione, vengono fatte coincidere e convergere nella produzione di obbedienza, attraverso la quale i sudditi devono riconoscere un unico ordine gerarchico. Il viceré e lo stesso sovrano sono soggetti all’errore, e qualora si verificassero degli errori o il viceré attuasse contrariamente agli ordini sovrani, deve intervenire la dissimulazione: il re punirà il suo rappresentante, ma lo farà con segreto, evitando che siano pubblicamente riconosciute le colpe del ministro e le accuse dei sudditi, in modo che non si incrinino i rapporti di comando-obbedienza. Al contempo, attraverso pratiche secretive, il re dovrà dissimulare la propria possibilità di errore nella scelta dei ministri, perche «el Rey con actos positivos muestra al mundo que yerra y que puede herrar cada dia en las elecciones», cosa che qualora fosse pubblicamente conosciuta e riconosciuta, sarebbe causa di perdita di reputazione e genererebbe disistima e passioni di comando nell’animo dei sudditi. Il vescovo conclude questa parte della lettera, indicando come pericolosa introduzione, fatta salva la necessaria informazione sugli eventi, l’accoglienza da parte del sovrano delle accuse dei sudditi rivolte ai ministri regi:
«tanto ha de procurar la conservacion del credito de ministros grandes particularmente en Italia donde se da principio y consecuencia a estas remociones, dentro de brebes (…) puede S.M. hacer quenta de ser poco obedecido si ya no lo pierde todo en esta introduccion»[25].
Tuttavia, la pratica delle ambascerie era difficilmente evitabile, anche perché codificata nei privilegi del regno; per questa ragione i consigli rivolti al re, erano indirizzati alla sua utilizazione in chiave di informazione, notizia, su quanto accadeva nei propri domini, affidando alla prudenza del re la neutralizzazione delle possibili conseguenze politiche, attraverso la dissimulazione ed il segreto. Gli stessi sovrani intervennero più volte a favore delle Piazze cittadine, ogniqualvolta un viceré tentava di evitare l’invio di ambasciatori a corte, come successe nel 1618, quando l’Ossuna cercò di opporsi all’ambasceria organizzata dalle Piazze nobili nella persona del francescano Lorenzo Brindisi. Allora le contromesse del viceré, nell’impossibilità di vietare il ricorso al sovrano, si concretizzarono nel favorire una contro-ambasceria della Piazza popolare, vicina alle istanze vicereali, che informasse il re dell’alterigia nobiliare e concedesse maggiore giurisdizione alla parte popolare.

Dunque, nonostante che le forme di ricorso al sovrano rappresentassero un pericolo per la reputazione del ministro regio, anche se non venivano favorite, erano sicuramente concesse dal re, sia con riferimento specifico al tradizionale concetto di giustizia, secondo il quale il sovrano doveva ascoltare e ricevere i propri sudditi, sia in quanto costituivano quella necessaria notizia su quanto avveniva in luoghi lontani dagli occhi del re. Tali ricorsi evidentemente, erano anche parte di quella continua contrattazione tra potere centrale e gruppi provinciali, finalizzata al riconoscimento, da parte del sovrano, dei diritti e delle necessità di coloro che erano chiamati a collaborare con i ministri regi per la retta amministrazione ed un efficace controllo sociale. E se da una parte, il ricorso al diritto era utilizzato dai poteri locali con funzione di freno dell’autorità vicereale, esso conteneva un indubbio vantaggio anche per il sovrano e i consigli centrali, che attraverso tali ricorsi potevano meglio controllare l’operato del ministro regio. Questo è ciò che si evince dal materiale documentario relativo all’arresto, decretato dall’Ossuna, di alcuni importanti ministri napoletani, Fulvio di Costanzo, decano del Collaterale, Bernardino Montalvo, marchese di Sangiuliano e luogotenente della Sommaria e Diego Lopez Suarez, consigliere e proreggente del Collaterale. Al Consiglio di Stato pervenne una lettera scritta da Geronimo di Costanzo, figlio del marchese di Corleto, il quale individuava nella politica autoritaria e anticostituzionale dell’Ossuna, la vera causa dell’arresto del padre, colpevole di aver rivelato al re il modus operandi del duca. La causa dei magistrati napoletani è rivelatrice di malesseri profondi di quella parte del gruppo dirigente del regno, che non si piegava ai disegni del duca e che il viceré cercava di neutralizzare attraverso un uso spregiudicato della giustizia.
La consulta del Consejo de Estado[26] sull’arresto e la successiva liberazione dei reggenti, si muove nella direzione di un rafforzamento delle posizioni della corona nella provincia napoletana, ponendo particolare attenzione alla neutralizzazione di quelle condotte da parte dei poteri regnicoli o del viceré, che comportavano turbamenti politico-costituzionali non controllabili o non promossi direttamente da Madrid, forieri di novità di difficile interpretazione e di incerti sviluppi. Il Consiglio, in quanto massimo organo consiliare dell’impero, opera in questo caso in fuzione di mediazione tra gli interessi dei ceti locali e l’operato del viceré, ritenuto eccessivamente spregiudicato e in contrasto con le direttive centrali. In effetti, le deliberazioni del Consiglio di Stato del 28 settembre e del 20 dicembre del 1617 e quella definitiva del 12 gennaio dell’anno successivo, sono indirizzate contro le decisioni del viceré e a favore dei ministri del regno. La base del contenzioso dunque, era di natura costituzionale e investiva prerogative e privilegi del regno e dei suoi ministri, il cui esito avrebbe potuto avere importanti ripercussioni politiche specificando i rapporti tra potere centrale, viceré e le élites provinciali che si esprimevano attraverso i vari organi di governo locale e le Piazze cittadine. Tuttavia, dietro il paravento costituzionale, si nascondevano questioni che riguardavano il progetto ossuniano, che si proponeva di marginalizzare il ruolo politico della nobiltà cittadina e del ceto ministeriale, per accentrare nelle mani del viceré ulteriori prerogative e allargare la base del “consenso” ai ceti popolari.
Per tornare ai documenti, il Consiglio di Stato giudicò ingiustificato l’arresto del Montalvo e pena eccessiva quella degli altri due ministri e si pronunciò anche contro la loro sospensione dagli uffici decisa dal viceré. Il Consiglio, rivolse particolare attenzione all’importanza dei personaggi e soprattutto al luogotenente della Sommaria, sottolineando che la carica esercitata dal Montalvo è una magistratura delicata, verso la quale, sia da un punto di vista tattico che costituzionale, non si può agire indiscriminatamente e con la forza con cui il viceré ha attuato:
«Juzga el Consejo que V. M. mande advertir al duque de Osuna que no tuvo razon de hacer lo que hizo contra el dicho regente Montalvo, tanto mas siendo ministro que ocupa tan gran lugar, y que ha servido a V. M. con tanta satisfaccion y aprobacion de los virreyes que han gobernado aquel reino y que asì le restituya luego a la administracion de su oficio, y no se proceda mas contra él»[27].
Uguale considerazione viene espressa dal Consiglio per quanto riguarda gli altri due ministri, aggiungendo al fatto che l’Ossuna non aveva motivi per arrestarli, l’annotazione:
«no tuvo jurisdiccion para mandarlos ausentar y suspender de sus oficios (…) y siendo ministros que ocupan el mayor lugar en aquel reino, paresce que conviene escribir al virrey que no lo pudo hacer, prohibendo que él ni sus sucesores lo hagan por convenir asì a la recta administracion de la justicia de aquel reino, y que luego los haga volver a sus oficios»[28].
Le preoccupazioni espresse da Geronimo di Costanzo riguardo l’amministrazione della giustizia, vengono fatte proprie dal Consiglio di Stato, intenzionato a non incrinare gli equilibri politico-costituzionali del Regno e al tempo stesso a non perdere le posizioni acquisite dalla corona. Da questo punto di vista è possibile comprendere il tentativo spagnolo di amministrazione del conflitto istituzionale, attraverso il rispetto delle procedure costituzionali, poste a fondamento della sicurezza del Regno e della sua conservazione. Innanzitutto, il viceré non ha comunicato al Consiglio la sua decisione, «no ha dado cuenta dellas a V. M. por este Consejo, como siempre se ha acostumbrado», poi, nella misura in cui il viceré ha scavalcato l’autorità reale, l’arresto dei tre ministri rischia di sconvolgere l’amministrazione della giustizia, accentrando il potere decisionale nelle mani del viceré, in grado di sfuggire in questo modo al controllo del sovrano; infine il Consiglio di Stato identifica il pericolo di mutazione degli equilibri, che si manifesta quando all’indipendenza del rappresentante reale rispetto al potere centrale si unisce la dipendenza dei ministri del Regno dal viceré. Queste preoccupazioni sono comuni alle Piazze cittadine e alla corte madrilena, e la definizione delle prerogative vicereali e di quelle regnicole rappresenta uno dei punti centrali del governo del regno, nonché uno degli snodi teorici su cui ruotano e si articolano i complessi rapporti tra centro e periferia dell’impero. Nella lettura dei documenti è possibile leggere questa affinità di vedute, tesa alla limitazione del potere vicereale; Geronimo di Costanzo, esponente della nobiltà di seggio si esprime al riguardo, con queste parole:
«Que considere V. M. el inconveniente que tiene el virrey de tal potestad, que está solo reservada á la soberanía de V. M., y que sola puede sustentar la justicia en aquel reino, pues si no se pone remedio tan eficaz como lo requiere el caso, de aquí adelante ningun ministro se treverá de administrar la justicia, sino acudir al gusto del virey, ni advertirle, ni volver por el servicio de V. M. , pués está en su mano no solo el descomponerlos, mas tambien quitarles la vida y la honra, moriendo como ruínes ministros, presos como facinorosos y viles hombres»[29].
Con espressioni del tutto simili si pronuncia il Consiglio di Stato contro l’Ossuna:
«si no se acude con presto remedio, teme que puede suceder con esto y otros ejemplos, que se llegue á herir el fundamento de la seguridad del reino, y que por esta via se vaya quitando de las reales manos de V. M. la rienda de la justicia, que es con lo que se va templando la suprema autoridad que necesariamente concede V. M. a los vireyes en las cosas de las armas, oponiéndosele la autoridad de los ministros de justicia que tan solamente han de depender de V. M., sin que el virey pueda poner mano en ellos, a fin que tengan animo de resistir a tan grande autoridad cuando el servicio de V. M. lo pidiere. Demas que se impediria la noticia que conviene que tenga V. M. por medio de los mismos ministros de las cosas que allì pasan, pues para esto bastaria la opinion, aunque no fuese verdadera, de que las prisiones hayan sido por haber avisado dello, como en la relacion se apunta, especialmente teniendo, como tienen obligacion de hacerlo, y ningun virey debe ni puede quejarse dello, pues siendo verdad lo que escriben, es justo que V. M. lo sepa; y cuando no lo fuese, habian de recibir el castigo de su real mano, demas que se destruiria de todo punto la libre administracion de la justicia que V. M. tiene obligacion de mantener a sus subditos, reduciendose todo por el miedo destos rigores al libre albedrio del virey, sin que persona ninguna se atreva a pensar ni hablar otra cosa que lo que podran imaginar que sea de su gusto»[30].
A cosa si deve attribuire tali identità di vedute e di giudizio tra corona e poteri periferici? Forse ad un’alleanza politica di lungo periodo tesa a marginalizzare la funzione e il ruolo politico del viceré? Oppure, nel riferimento del documento nobiliare alla giustizia che appartiene al re, bisogna leggere una rinuncia ad esercitarla da parte delle élites locali? Per quanto riguarda quest’ultimo punto si può immediatamente rilevare, come non si tratti di un neutro riferimento alla tradizione o una pura dichiarazione di fedeltà, politicamente ingenua, ma come questa fosse in realtà un patto per il quale la fedeltà politica della nobiltà e della città di Napoli alla corona di Spagna veniva scambiata con l’attribuzione di privilegi e prerogative politiche, attraverso cui ha preso forma l’assetto giuridico-costituzionale del Regno, regolando i rapporti tra i poteri centrali e locali e fornendo in questo modo una copertura anche giuridica ai gruppi dominanti[31]. Questo riferimento, allora, non solo non è in contraddizione con una giustizia esercitata a livello locale dai regnicoli, ma ne costituisce il fondamento e la condizione, soprattutto dopo la “svolta” operata da don Pedro de Toledo negli anni ‘40 del secolo precedente. L’opera toledana aveva coniugato una politica autoritaria e centralizzatrice con l’alleanza con la “borghesia degli uffici”, ovvero con quel ceto togato che aveva iniziato un lungo processo di occupazione di posti degli apparati burocratici, amministrativi e giudiziari del Regno, scalzandovi gran parte della nobiltà e della feudalità e che erano diventati duro terreno di scontro tra i ceti. Da allora i viceré, spesso in accordo con la corte, avevano favorito l’ascesa dei gruppi popolari, per cui la nobiltà retrocedeva progressivamente dalle posizioni acquisite, perdendo tutta una serie di protezioni e coperture politiche. Contro questo tentativo di esclusione, prende senso il riferimento alle costituzioni e alle usanze del Regno, che potevano costituire una difesa e una garanzia della propria persona e del proprio ceto. Era evidentemente presente nelle dinamiche di potere locali, una preoccupazione comune alla corte e alla nobiltà cittadina, ovvero la perdita della possibilità di esercitare un controllo sull’operato del viceré. Da qui la preoccupazione, nelle parole di Geronimo di Costanzo, che «de aqui adelante ningun ministro se treverà de administrar la justicia, sino acudir al gusto del virey»; avendo poi il viceré, un potere non soggetto a freno, i ministri disobbedienti non avranno nessuna difesa «muriendo como ruines ministros, presos como facinorosos y viles hombres»[32].
Il Consiglio di Stato accoglie questa istanza, temendo la dipendenza dei ministri del Regno dal viceré; in tal senso allora, è possibile parlare di una convergenza tattica tra corona e gruppi provinciali, nel tentativo di tenere a freno le passioni e i progetti di Ossuna; questo tipo di convergenza dà luogo ad una autonomia funzionale delle Piazze e dei ministri locali rispetto al viceré. I termini messi in gioco dalla consulta del Consiglio di Stato sono: garanzia della sicurezza del Regno, giustizia che risiede nel potere sovrano, divisione dei compiti all’interno della provincia, per cui al viceré è concesso potere quasi illimitato nelle questioni militari, mentre i ministri di giustizia devono poter agire con una certa autonomia e dipendere solo dal re. Indurre la divisione tra i poteri e tra i soggetti e i gruppi che lo esercitavano, era notizia dettagliatamente codificata dalle scritture politiche e pratica di governo ampiamente sperimentata dai sovrani del tempo; essa risponde all’esigenza di dividere le forze in campo in modo tale da portare ad una neutralizzazione reciproca attraverso la competizione. E’ ovvio che in questo caso, però, diversamente da quanto accade nella competizione tra ceti, non si tratta di neutralizzare la capacità di produzione di potere da parte del viceré, quanto piuttosto di armonizzare tale potere con le direttive centrali e di renderlo atto a governare un contesto specifico. Il Consiglio d’Italia, in quanto organo centrale e i viceré, in quanto rappresentanti locali della corona, hanno il compito di scegliere di volta in volta la tattica migliore per il governo del Regno; può però succedere che le passioni e le ambizioni politiche e individuali del viceré si scontrino con le esigenze e le direttive del potere centrale o che che questi operi in maniera eccessivamente autonoma attizzando pericolosi conflitti cetuali. In questo caso il compito di mediazione, è affidato, come afferma la consulta citata, oltre che agli organismi centrali quali il Consiglio di Stato e quello d’Italia, ai gruppi dominanti, che richiamando il viceré al rispetto delle costituzioni, assolvono una funzione di freno nei confronti del rappresentante reale. Tuttavia -viene specificato nel documento-, questo compito viene affidato ai regnicoli solo «quando el servicio de V. M. lo pidiere»; ciò significa che una certa resistenza al potere vicereale si rende necessaria esclusivamente quando il viceré scavalca o sfugge al controllo del sovrano e degli organi centrali, ovvero quando si manifesta un interesse politico per la corona. Per questo motivo, è necessario che i ministri del regno possano godere di un margine di indipendenza rispetto al vicerè e che invece le loro cariche dipendano totalmente dal monarca al quale si rivolgono attraverso le informazioni sullo stato della giustizia nel Regno. Le informazioni che i regnicoli inviano al re e al Consiglio di Stato, sono allora anch’esse parte di quell’opera di continuo controllo che devono esercitare i poteri centrali nei confronti del viceré.
Questi temi sono presenti anche in un’altra serie di documenti che riguardano il procedimento contro il conte di Mola e arrendatore di origine portoghese, Miguel Vaez, avviato quasi contemporaneamente all’arresto dei suddetti ministri. Ai fini della ricerca non è essenziale segnalare le motivazioni del processo, quanto piuttosto è interessante l’atteggiamento assunto dal Consiglio d’Italia, il quale si pronunciò contro la volontà dell’Ossuna di sottoporre a processo il conte di Mola attraverso giudici nominati dallo stesso Ossuna. La motivazione è ancora una volta di tipo giuridico-costituzionale, mentre l’esigenza è di carattere politico; la consulta afferma innanzitutto che i giudici nominati dall’Ossuna sono «mal afectos» al conte e che l’ostilità al Vaez risale ai tempi in cui l’Ossuna era viceré in Sicilia. Ma ciò che è più rilevante, è che il viceré non ha la facoltà e il diritto di nominare i giudici per il processo in quanto tale prerogativa spetta al re attraverso il Consiglio d’Italia. Ancora una volta la questione riguarda la dipendenza dei ministri dal viceré e la consulta mette in evidenza il pericolo derivante dall’accentrare tutto il potere nelle sue mani, cosa che può compromettere l’amministrazione della giustizia e latu sensu squilibrare l’assetto politico-giuridico del regno. Lo stesso Ossuna aveva denunciato che nella causa del duca di Nocera, sua hechura, i giudici non vollero fare giustizia ma solo «hacian gusto en ello al conde de Lemos», così come immaginarono di accontentarlo quando lo rilasciarono. Per cui afferma la consulta:
«aquellos jueces penden, no solo de lo que el virrey quiere, pero de lo que adivinan que quiere; y habiendose él declarado tanto contra el conde de Mola, claro està que no se han de apartar dello, y que no se han de atrever a votar contra lo que el duque tiene ya publicado del negocio»[33].
E’ necessario dunque, secondo il Consiglio, preservare la libertà di voto dei ministri di giustizia e l’unica condizione che lo rende possibile è spezzare il collegamento tra chi gestisce il comando politico e militare e chi amministra la giustizia, onde evitare che si ripetano per il futuro gli inconvenienti verificatisi:
«en ocasiones que se han ofrecido, si algunos han querido mantener en su voto la liberad, que por toda razon y ley divina se les debe guardar, han sido maltratados por ello [dal viceré] y padecido grandes inconvenientes»[34]
Finora sono emerse alcune ambivalenze nella determinazione dei rapporti tra potere centrale, viceré e gruppi locali. Le forme di ricorso al sovrano da parte di questi ultimi, in particolar modo le ambascerie, se potevano rappresentare un pericolo oggettivo per il viceré, costituivano anche un elemento di equilibrio, finalizzato ad una più comoda gestione del potere nelle province dell’impero. Al tempo stesso e come conseguenza di tale finalità, la necessaria soggezione dei sudditi al viceré, doveva essere moderata attraverso il riconoscimento giuridico dello ius proprium e il rispetto di una serie di garanzie e privilegi di cui godevano i gruppi dominanti. Nel momento in cui si producevano frizioni tra viceré e gruppi locali, i consigli centrali intervenivano spesso a favore di questi, con la doppia finalità di prevenire antagonismi e controllare l’operato del ministro regio. L’esigenza da parte della corte di Madrid, era sia di carattere politico che economico-fiscale; infatti se da un punto di vista di gestione del territorio, risultava utile tenere a freno gli umori della nobiltà locale, l’attribuzione e il riconoscimento di diritti e garanzie aveva anche la funzione di spezzare il collegamento, sempre possibile, tra nobiltà e plebe, che aveva avuto modo di manifestarsi tragicamente, nel 1585, sotto il governo del I duca di Ossuna, con l’uccisione dell’eletto del Popolo, Starace[35]. Parallelamente, se la necessità di ottenere finanziamenti dal regno per finanziare le attività belliche, aveva portato ad un compromesso tra baronaggio e corona nelle province del regno -anche in vista dell’approvazione del donativo biennale-, nella capitale tale compromesso si manifestava attraverso il mantenimento delle garanzie di quelle strutture di governo, Collaterale, ma soprattutto la Camera della Sommaria, attraverso le quali passavano le decisioni sulle politiche economiche e fiscali. La strategia complessiva, dunque, andava tradotta in dispositivi giuridici e prudenziali in grado di funzionare da elementi di collegamento tra varie istanze e interessi, finalizzate alla conservazione del regno. Tuttavia tale rapporto era assai più complesso nelle pratiche quotidiane di gestione del potere, che nella definizione teorico-formale delle strategie di governo. Alla linea-guida che secondo la corona doveva svolgersi nel senso su indicato, si contrapponevano le contraddizioni e specificità del contesto napoletano. In effetti non mancano le relazioni di viceré o di altri soggetti coinvolti nell’amministrazione, che sottolineano le difficoltà di far convergere la necessaria soggezione dei sudditi, le garanzie giuridiche dei regnicoli e l’attribuzione di larghi poteri amministrativi nelle mani dei ministri locali.
Sul finire del Cinquecento, il conte di Miranda, al momento di lasciare il viceregno napoletano all’Olivares, in una relazione al nuovo viceré, segnala la difficoltà di una retta amministrazione in una città in cui gli amministratori locali possono permettersi, in virtù dei propri privilegi, di sfuggire al controllo del viceré compromettendo l’amministrazione della giustizia. In un settore strategico, quale l’approvigionamento di pane per la città, si tratta di ricreare le condizioni affinche il viceré:
«pueda tratar del remedio que sin ninguna duda es tan necesario que del dependen otros muchos que no podrian fundarse sin que preceda este vergonzoso caso es que en una ciudad tan rica, tan noble y tan poblada Cabeza del Reyno y assiento de los Virreyes hayan passado tantos años sin haver pedido cuenta a los que han administrado las rentas della y que se entienda por cierto que muchos que han tenido la mano en ellas poseen largo tiempo gruessas sumas de dinero gozando el beneficio dellos al parecer con segura confianza de no restituyrlo jamas parescendoles que por ser administrada la ciudad de solos ellos y sin obligacion de dar segun los privilegios della las quenta sin intervencion de orden particular del Virrey o de Ministros señalados por el, viven seguros del castigo de su mala administracion y la pobre ciudad siempre necesitada sufriendo en el grano y en el pan que es el sustento comun de sus hijos mil imposiciones con que siempre lo comen malo y caro y sabido de buena parte y tratando los meses passados de hacer partido de grano por la ciudad y queriendole poner un precio alto se levantò una voz comun en el vulgo pidendo que se viessen las quentas de la ciudad»[36].
Senza mezzi termini, il Miranda individua nei privilegi del regno la causa prima dei disordini a cui è soggetta l’amministrazione, e nella necessità che il viceré recuperi autorità e prerogative, la condizione affinché sia ristabilita la giustizia nel regno. Con termini del tutto simili si esprimeva la lettera del vescovo di Gaeta, con riferimento all’uso della giustizia da parte del duca nei confronti dei ministri locali e di molti rappresentanti della nobiltà. In essa viene affermato che in realtà il duca non agì contro la giustizia ma semplicemente si limitò a punire coloro, che coperti dai privilegi derivanti dalla propria posizione sociale e funzione politica, operavano indisturbati e commettevano abusi. In realtà l’operato del duca si caratterizza, secondo i suoi difensori, per porre termine a tale stato di ingiustizia, avallato dall’accondiscendenza dei suoi predecessori:
«Eran en esto [alla deposizione dell’Ossuna] interesados todos los consejeros del Collateral, los castellanos, el maestre de Campo, los electos de la nobleza, gran parte de los ministros, el duque de Vietri y el principe de Sansivier y sus deudos y confidentes que son muchos y poderosos; estos por haver hecho el duque procesos de causas muy feas contra los dos (…). Pocos o ningunos de los ministros de justicia, govierno o guerra dexan de estar castigados de su mano por excesos graves tolerados en otros tiempos y arraigados por esso como costumbre (…). Esta es una raiz de las persecuciones que ha padecido y padece el Duque porqué biendose generalmente estos ministros reformados de exempcion y libertad que goçavan, aviendolo introducido en costumbre por absuso suyo y tolerancia de otros virreyes»[37].
Allora le pratiche di governo dell’Ossuna si collocano da una parte, all’interno di un dibattito intorno alla giustizia e sulle forme in cui doveva essere esercitata, dibattito che coinvolgeva sia lo specifico contesto napoletano, sia la corte madrilena. Dall’altra, l’Ossuna, cercava di volgere a proprio favore la conflittualità presente tra nobiltà e popolo, attribuendo le responsabilità dei mali del regno ai potenti gruppi locali. E se la corte cercava di mediare i conflitti tra viceré e gruppi dominanti, il governo del duca, invece, prese una direzione che spingeva verso un’accelerazione delle normali procedure di governo, sia attraverso l’utilizzazione della giustizia in chiave di accentramento del potere, sia, nella stessa ottica, rafforzando l’alleanza tra potere vicereale e Piazza popolare in detrimento delle prerogative nobiliari.

Tale progetto cercò di trovare concreta attuazione durante gli ultimi mesi del suo governo, ma sia alcuni documenti, che certi dispositivi di governo messi in atto dall’Ossuna -come le lettere del 3 aprile e del 6 settembre 1619 e la riforma della milizia-, permettono di affermare che la separazione amministrativa tra nobiltà e popolo fosse presente nella mente dell’Ossuna almeno a partire dai primi mesi 1619. Per quanto il progetto ossuniano si muovesse in una direzione autonoma, non mancavano documenti di parte popolare e scritture politiche che spingevano verso un’innovazione dell’assetto politico cittadino. Francesco Imperato, quindici anni prima, aveva cercato di dare una sistematizzazione teorica al concetto di separazione, in modo tale che un maggior potere del ceto mezzano potesse arrecare beneficio agli sforzi conservativi della corona. Tuttavia il Discorso Politico, faceva riferimento al ceto togato come trait-d’union tra istanze conservative della monarchia e interessi locali, pur non rinunciando a segnalare le contraddizioni interne al ceto mezzano. La politica dell’Ossuna, invece, pur tenendo presente molte delle sollecitazioni di Imperato, mira alla divisione tra le varie parti del corpo sociale e dei ceti al proprio interno, non escluso quello togato. D’altra parte, il progetto di accentramento di prerogative in mano del viceré richiedeva la subordinazione del ceto ministeriale all’autorità e volontà vicereale, la qual cosa toglieva autonomia ai percorsi del gruppo togato. E se Imperato conferiva la funzione di “rappresentanza” della Piazza popolare agli stessi togati, l’Ossuna sembra propendere per l’autonomia della prima nei confronti dei secondi, vincolandoli però entrambi alla volontà vicereale. In effetti, sia una lettura incrociata della corrispondenza di avversari e partidari dell’Ossuna, sia le firme apposte alle Accuse della Città contro il duca, permettono di affermare che l’operazione di divisione del corpo sociale fosse realmente riuscita, indipendentemente dall’esito negativo in chiave di conservazione del comando. A tal fine e per avere un apparato di governo subordinato alle proprie istanze, l’Ossuna si servì, secondo i propri avversari, di «diversi medicamenti o veleni», allontanado alcuni avversari attraverso una «simulata benevolenza», altri con «una certa severità militare», altri ancora «sotto specie di honore», inviandoli come luogotenenti nelle province a custodia delle coste del regno. Al contempo, li sostituì con uomini di sua fiducia ai quali facilitava l’accesso negli uffici: «si posero all’incanto gli officij, i benefici, le nomine de’ Ministri, gli avvenimenti delle liti, s’accrebbe il numero de’ Magistrati in tutti li suoi tribunali»[38].
Per di più, come tale progetto di divisione rappresentasse per l’Ossuna lo strumento principale di un’efficace politica conservativa, lo esplicita chiaramente una lettera inviata dal proprio viceré al duca di Uceda, il suo più potente protettore all’interno della corte, datata 6 settembre 1619[39]. Fino ad allora la politica dell’Ossuna, si era fondata sulla deroga alle costituzioni del regno e sullo scavalcamento delle magistrature politiche e finanziarie napoletane. La sua azione, in effetti, non riguardò solo l’utilizzazione della giustizia in chiave accentratrice, ma anche un’accentuata autonomia sulla politica fiscale. In una lettera del 3 aprile dello stesso anno, l’Ossuna spiegò i motivi per i quali, con una decisione del tutto autonoma e contro il parere della Sommaria, eliminò alcune imposte sul grano e sulla frutta da lui stesso imposte all’inizio del suo mandato. Secondo il viceré, le due gabelle non servirono ad ottenere il risultato per il quale erano state introdotte, poiché si rivelarono quasi esclusivamente una cospicua fonte di guadagno per gli arrendatori che non avevano nessun riguardo per il beneficio pubblico. L’Ossuna, allora, si collega direttamente alle istanze presentate dal Miranda nelle sue istruzioni all’Olivares e a quanti denunciavano collusioni tra coloro che erano chiamati a gestire le finanze pubbliche:
«el intento que llevaban era querer distribuyrse este dinero entre los que traen a cargo esta hacienda (…) sin sacar el beneficio que se pretendia de estas dos gabelas»[40].
Con questo atto, l’Ossuna dimostrò di aver intrapreso una politica “populista” che ottenne un doppio effetto: da una parte, il duca dichiarò che attraverso questa misura «el pueblo todo està satisfecho», dall’altra, l’eliminazione delle gabelle imposta dal viceré contro il normale processo decisionale, provocò un’ulteriore frattura con nobili e magistrati locali.
In questo contesto, la lettera del 6 settembre, costituisce una specie di spartiacque nel progetto amministrativo dell’Ossuna; la lettera fa riferimento alla contro-ambasceria della Piazza popolare nella persona dell’Eletto del Popolo Carlo Grimaldi. Questi veniva inviato a corte, con l’appoggio del duca, per riportare all’attenzione del re due vecchie rivendicazioni della Piazza popolare, la possibilità di inviare propri ambasciatori e l’equiparazione del voto popolare con quello delle Piazze nobili, come elemento di spinta verso la separazione amministrativa tra i due ceti. L’Ossuna, nella lettera, sottolinea al re l’importanza delle rivendicazioni della Piazza popolare, collegandole direttamente con i percorsi conservativi della corona:
«Verdaderamente importa al servicio de V.M. que el electo Grimaldi vuelva honrado a ojos de su pueblo y aun a la reputaciòn de V.M. que se entendiese procedia de V.M. qualquier resolucion que con él se tomase y que V.M. por si solo obraba en estas materias superiores sin mas consulta que su confesor y el duque de Uzeda a quien V.M. ha dado tanta parte en su Real Servicio, y es sin duda que algunas vezes importaria salir inopinadamente asì algunas provisiones, y daria a V.M. gran aquisto de valor y opinion a los de quien vee el mundo ha escogido V.M. para tan cerca de su persona»[41].
Le provisioni in questione riguardano, come si è detto, il diritto della Piazza popolare di inviare propri ambasciatori a corte, insieme con la richiesta di autonomia amministrativa del popolo. L’Ossuna, mentre a Napoli operava già in tal senso, chiese al re di sancire queste richieste attraverso lo strumento giuridico e la ridefinizione dell’assetto del governo politico. E’ questo il senso della richiesta da parte dell’Ossuna al re di accettare le richieste popolari e di «asentallo para adelante»[42]. Una tale decisione avrebbe avuto come effetto immediato la legittimazione dell’operato del viceré ed un riconoscimento esplicito della necessità di produrre un’innovazione interna al governo politico, intesa come adattamento conservativo nel presente e con il valore di pro-visione per il futuro. Vale a dire, che il riconoscimento regio delle istanze popolari, sarebbe stato uno strumento formidabile nelle mani del viceré per stroncare l’opposizione nobiliare e avrebbe permesso di trasformare la deroga in normale produzione di potere politico e di obbedienza al sovrano e ai suoi rappresentanti. Infatti affinché potesse prodursi una novità nell’ assetto giuridico-politico, utilizzata come dispositivo di governo, era necessario che fosse sentenziata da un potere superiore e insindacabile quale quello del re e che non risultasse semplicemente come effetto di pratiche di governo messe in atto dal viceré in deroga ai privilegi del regno. Implicitamente, invece, l’Ossuna mette in campo la questione relativa alla produzione di obbedienza che deve attraversare verticalmente il corpo sociale; a tal fine, il duca utilizza la categoria di reputazione che deve rendere intellegibili i gradi della gerarchia politica. Per questo, la decisione su un’innovazione in chiave conservativa che si muova sul piano giuridico-politico e che implichi importanti ripercussioni sull’ordine sociale, deve essere presa dal sovrano e applicata dal viceré secondo i tempi e le forme da lui ritenute opportune.
Proprio nella lettera del 6 settembre, l’Ossuna presenta come già avvenuta nei fatti la divisione tra nobiltà e popolo, rivendicando l’efficacia di tale tecnica ai fini della conservazione del regno e di una sua retta amministrazione e spingendo il re e la corte ad approvare formalmente il suo progetto. Il regno di Napoli viene considerato dall’Ossuna come uno dei più difficili da governare, sia per la «inconstancia de los naturales», sia perché i suoi sudditi sono «inquietos y poderosos». Questa condizione naturale dei napoletani rende assai complessa l’opera di governo e l’esperienza dei goveni precedenti al suo, ha mostrato quanto facilmente si inclinino al malcontento. Oltre al dato naturale, però, l’Ossuna individua una causa specificatamente politica delle difficoltà che incontra chi governa il regno, rappresentata dal collegamento delle varie parti del corpo sociale. Il duca sostiene non esserci strumento migliore nelle mani del detentore del comando che «la desunion entre sus vasallos»; verso questo obbiettivo deve indirizzarsi l’azione politica per assicurarsi la conservazione del regno altrimenti destinato a mutazione. Infatti l’esistenza di un collegamento tra nobiltà e popolo, la percezione di una dipendenza del ceto popolare dagli interessi e dalle ambizioni dei nobili, rendono possibile l’utilizzazione della plebe come ‘braccio armato’, contro le istanze monarchiche rappresentate dal viceré.
Contrariamente, la nobiltà di Piazza, aveva intuito come il progetto di separazione tra nobiltà e popolo passasse «per lo camino dell’interesse»[43]: per fare presa sugli interessi della plebe, l’Ossuna non solo eliminò le gabelle sul grano e sulla frutta, ma decretò anche, senza alcuna consultazione con Collaterale e Sommaria, l’aumento del peso del pane, con il fine di soddisfare il popolo con il pane a buon mercato. Inoltre cercò di far presa sugli umori della plebe andando di persona a Piazza mercato gettando monete, e secondo le accuse della città, facendo «buttare a terra sin da’ fondamenti à viva forza dalla plebe la casa de’ gabelloti, col farsi acclamare Duca più volte».[44]
L’Ossuna volle così rivolgersi alla plebe con l’obiettivo di indicare quei soggetti, i «gabelloti» e indirettamente gli arrendatori, verso i quali il popolo doveva indirizzare la propria ira per le misere condizioni di vita. Poco importava, che per far fronte alle ingenti e continue richieste di denaro che provenivano dalla corte, l’Ossuna portasse avanti una politica finanziaria di aumento del debito pubblico, soprattutto a causa degli arrendamenti e dei prestiti, e che durante il suo viceregno furono vendute ai baroni un gran numero di città demaniali. Ciò che realmente importava era rassicurare il popolo attraverso l’intervento diretto e munifico del viceré nella vita quotidiana e che agli occhi della plebe apparissero chiaramente i nemici del bene pubblico, veri o presunti che fossero. In effetti, nella lettera del 6 settembre, la causa dei disordini veniva addossata sulle spalle della nobiltà cittadina, che sicura dei propri poteri e privilegi, intimoriva i viceré organizzando tumulti e utilizzando la plebe per raggiungere i propri fini. L’Ossuna, in uno dei passi dai toni più accesi contro i nobili, sottolinea come questi tentino di apparire i custodi dell’ordine cittadino, mentre in realtà sono i veri sobillatori del popolo:
«siendo ellos [i nobili di Piazza] los promobedores de todas las desordenes, echa al pueblo la culpa y quedarse ellos libres del castigo, antes pretendiendo obligar a V.M. y a los virreyes con un cauteloso nombre de patricios y sosegadores de la patria, para mantener los virreyes temerosos del pueblo y a V.M. cuydadosos, y darle a entender de secreto que heran sus protectores y con cavilosos artes como aquì usan»[45].
Già nel dicembre 1618, l’Ossuna accusava il duca di Vietri e il Principe di Sansevero, due dei suoi più accaniti e potenti nemici nonché capi della fazione anti-ossuniana, di promuovere adunanze segrete nella chiesa di San Domenico e di elaborare una precisa strategia d’attacco al viceré, fondata sulla voce che l’Ossuna avrebbe fatto alloggiare tutta l’infanteria dentro la città e vi avrebbe introdotto l’Inquisizione; tali riunioni e la scelta delle due questioni da diffondere in città servivano «a tener el pueblo a su devocion y por mano de la plebe perturbar mi gobierno»[46].
A fronte di questa situazione, l’Ossuna crede di aver trovato una soluzione definitiva, tanto da affermare che il regno finalmente si trovava nella condizione migliore per rimanere saldamente sotto il controllo della monarchia. Lo strumento adottato consiste proprio nell’aver indotto la disunione fra i sudditi, giudicata come la condizione necessaria per l’opera di conservazione politica:
«nada le està tan bien a un principe como la desunion entre sus vasallos para conservarse en el dominio dellos (…). Hoy tiene V.M. esto [il regno di Napoli] en mejor estado que nunca para asegurarlo perpetuo, pues el pueblo totalmente se ha separado de la nobleza de coraçon y salido del engaño en que le mantenian teniendole male afecto a V.M. y a los Virreyes, para usar del por su mano»[47].
Evidentemente, tale strategia passava attraverso precisi dispositivi di governo i cui effetti avrebbero determinato l’interruzione della comunicazione non solo tra ceti ed interessi diversi, ma anche all’interno del singolo ceto. Per quanto riguarda il primo caso, l’Ossuna oltre a compiere atti munifici nei confronti della plebe, dispose una riforma militare che interessava da vicino la parte popolare. Zazzara, nei suoi Giornali, narra dello scioglimento del Battaglione napoletano, composto per lo più da contadini a cui fu concesso di far ritorno al lavoro dei campi e alla vendemmia ed il loro posto fu occupato da una nuova milizia formata in gran parte da artigiani e cittadini[48]. La Piazza popolare in questo modo, si vedeva coinvolta nell’organizzazione della milizia ed ebbe il compito di interessarsi alla formazione e direzione delle compagnie di soldati. A ragione, Schipa, afferma che a questa riforma non fu dato il giusto valore, né inserita nel complessivo progetto di governo, e si sofferma sulla modalità di composizione della milizia e dei suoi comandanti:
«Quando si trattava di formare nuove compagnie, l’ordine ne veniva dato dall’Eletto del popolo, che consultata la Piazza, più propriamente i consultori della Piazza e i Capitani di strada o d’ottina, proponeva al viceré le persone da nominare Capitani di compagnia. Questi procedevano al reclutamento, ciascuno nella propria ottina; e il viceré poi, sempre su proposta dell’Eletto, nominava i quattro sergenti maggiori e il Maestro di Campo generale»[49].

Attraverso la riforma militare, l’intera organizzazione popolare, a tutti i suoi livelli amministrativi, dall’Eletto ai consultori, fino ai ventinove Capitani delle ottine, era coinvolta a fianco del viceré nelle decisioni relative alla milizia e alla sua composizione. E mentre venivano rafforzati i legami tra organizzazione popolare e viceré, i nobili di Piazza ostili al viceré erano esclusi dalla direzione delle compagnie, essendo nominati per questo compito o cittadini appartenenti al “popolo crasso” o nobili vicini alle istanze popolari, dipendendo le loro cariche dal viceré e dall’Eletto.
La nobiltà di Piazza, in effetti, intravedeva in questa riforma non solo pericoli di disordini, ma un chiaro progetto del viceré di servirsi dei suoi «adherenti» contro di loro e come strumento per realizzare la separazione dei ceti. Con un altro provvedimento, il duca estese il diritto di portare armi a tutti i soggetti che componevano la piazza popolare[50]; l’Ossuna si servì di costoro, secondo le accuse della città, principalmente il 18 maggio 1620, quando Genoino, insieme con i Capitani e Consultori della Piazza:
«huomini facinorosi, et inquisiti, armati di diverse armi prohibite, con infiniti altri bravi et inquisiti, guidati da lui (…), incontratisi per camino col Duca d’Ossuna nella Piazza di Forcella (…) disse al detto Genovino e suoi seguaci, che erano buona gente e che eseguissero quello che andavano a fare»[51].
In effetti, la separazione amministrativa tra nobiltà e popolo, subì un’accelerazione decisiva durante l’elettato di Giulio Genoino, la cui elezione fu fortemente voluta dall’Ossuna, che evidentemente riconosceva in lui, la persona che più era in grado di appoggiare e assecondare i suoi progetti. Fu proprio durante il suo elettato che si provvide all’elezione dei nuovi capitani di strada, soggetti ritenuti pericolosi dalla nobiltà, ovvero con le parole di Giuliano, «la maggior parte di costoro nuovamente eletti sono rissosi, inquieti, homicidiarij, delinquenti e professori di armi»[52]. Il Genoino, nel Ragionamento alla Piazza popolare, formalizza le motivazioni che spingevano il popolo ad autoproclamarsi soggetto autonomo rispetto alle Piazze nobili; la tirannia esercitata dalla nobiltà, che avvalendosi della maggioranza dei voti, obbligava il popolo a concorrere, costituiva uno stato di ingiustizia al quale bisognava porre temine, rivendicando il diritto della Piazza popolare a governarsi da se stessa. Il Genoino si collega con quanto scriveva l’Ossuna nella lettera del 6 settembre, quando affermava che la nobiltà cerca di tenere «male afecto» il popolo agli occhi del re e dei viceré e questi sospettosi nei confronti del popolo, in modo da poter governare la città essa sola e secondo i propri interessi:
«(…) questo non è altro, se non voler vilipendere il Popolo e mostrare in effetti farne poco, anzi nulla stima, e voler essi soli mostrarsi sempre grati et amorevoli a futuri Principi, che vengono in questo nostro Regno per fare acquistare da essi Signori mala volontà contro il mio fedelissimo Popolo, e contra me suo Eletto (…)»[53].
Le motivazioni della separazione vengono ulteriormente sviluppate dal Genoino nel Manifesto scritto in nome della Piazza popolare, portando alle estreme conseguenze la rivendicazione che proveniva dalle scritture di parte popolare in quanto alla parificazione del voto popolare a quelli delle Piazze nobili. Secondo il Genoino, la situazione creata dall’alterigia nobiliare non consentiva nessun tipo di mediazione giuridica che non passasse per l’autonomia della Piazza popolare:
«Perché s’è visto con lunga esperienza che questo fedelissimo Popolo di giorno in giorno viene ad essere annichilato e suppeditato dalle cinque Piazze de’ Seggi, in derogarle tutto quello, che con tanta notoria ragione è suo, e di ragione li spetta, e di giorno in giorno applicano a dette lor Piazze de’ Seggi, quello che è proprio del fedelissimo Popolo»[54].
Le responsabilità dei debiti del Regno, vengono addossate sulle spalle della nobiltà e della «inavveduta loro amministratione», e la condizione di possibilità di una cattiva e parziale amministrazione è identificata nel processo decisionale, per il quale è sufficiente il principio di maggioranza affinché una proposta diventi operante. La collusione di interessi, i legami familiari tra le differenti Piazze nobili, rendono possibile che la conclusione avvenga senza che venga coinvolta la Piazza popolare, anzi questa è costretta a concorrere senza che vengano ascoltate e accolte le proprie necessità.
E nel Manifesto del Genoino, convergono diverse delle istanze che provenivano sia da parte popolare, che da quanti, viceré e ministri regi, identificavano una cattiva amministrazione e un pericolo di mutazione, nei privilegi e prerogative di cui godevano le Piazze nobili nell’amminstrazione cittadina e che trovavano accoglienza a corte attraverso relazioni e ambascerie.
«Perché dette cinque Piazze de’ Seggi concorrendo con una di questo fedelissimo Popolo, facilmente quattro di quelle nobili per via di particolare intelligenza di nobiltà tra loro, alcuni d’essi interessati e odiosi del quieto vivere e d’esso fedelissimo Popolo, senza però intervento e consenso di persone gravi di dette loro Piazze fanno nascere conclusioni di quanto lor pare contro detto fedelissimo Popolo, per essere quattro di quelle unite, e così si applicano a loro stessi il governo e maneggio di questa città, e dispongono a loro bel modo del vivere come ad essi piace, et ancora nel fare provisioni di vettovaglie e annona, mirano più presto l’interesse proprio, che l’utile del publico perciò per necessità sempre si cumula debito sopra debito, e si sente il Popolo appressato con penuria e necessità. (…) Le Cinque Piazze di Seggio, o quattro di quelle unite non legittimamente, ma in diverse Chiese, case private, e particolari ridotti, fanno tra loro stessi Monopoli, Conventicole e seditioni, si contra questo fedelissimo Popolo, si anche contra l’eccellenze de’ viceré, che sono stati, sono e saranno in questo Regno, che quando non hanno quello che intendono da essi Eccellentissimi Signori a lor modo e per loro particolari interessi subito facilmente uniti li predetti come di sopra, scrivono e inviano messi alla Maestà del re mio Signore e sua Real Corte contra li Viceré e Popolo, acciò si levino dal governo di questo Regno (…)[55]».

Pochi anni prima, il conte di Lemos, segnalava gli inconvenienti che derivavano dalle prerogative detenute dalle Piazze nobili e dalla pretesa di non ammettere opposizione o ricorso contro le loro decisioni. Le conclusioni, secondo il Lemos, sono il frutto di interessi di parte e spesso contrarie al bene pubblico; quando il viceré vuole opporsi alle loro deliberazioni, la nobiltà di Piazza invia deputazioni a corte a lamentarsi dell’operato del Viceré:
«El mas dificil punto deste negocio procede de la autoridad, que estas plazas se pretenden arrogar, y los Electos y Deputados (…), assì metiendose en cosas que no les tocan, como presuponiendose, que los que quatro Plazas resuelven, se haya de executar sin replica (…). La mayor parte nombran por Electos los que negocian por intereses y fines proprios, y diputados los que quiere el, que por intereses o pasiones proprias o privadas, procura la Diputacion, sin que en la sustancia nunca y en el aparencia pocas vezes pretendan sino aquello que peor està al publico, y se descuida totalmente de lo que conviene (…)»[56].
Secondo il Lemos, è necessario innanzitutto che il re decreti che le Piazze non possano inviare deputazioni o lettere al sovrano senza l’autorizzazione del viceré, e dal punto di vista strategico, i viceré devono poter utilizzare positivamente ai fini di un più efficace governo politico, l’opposizione della Piazza popolare alle conclusioni della nobiltà di Piazza: «Era grande correptivo para el orgullo destas Plazas nobles, la del pueblo; (…) es menester usar del instrumento desta Plaza para la oposicion, que muchas vezes convendra hazer a las otras (…)»[57]. Nella stessa direzione si muoveva un documento di un altro viceré che, come da consuetudine, al momento di lasciare la carica, scriveva istruzioni al succcessore:
«La ciudad se divide en seys plazas, cinco de Nobles y una del Pueblo, aquella se gobiernan por mucho numero de votos y casi de ordinario venze la multitud a la razon, andan en manos de veynte o treynta hombres que para atribuyrse el nombre de Patricios se oponen siempre a todo lo que emprende el Virrey, en cuya oposicion està su imperio, porqué a ese titulo le dan obediencia los demas. Uno de los frenos que tiene es la Plaza del Pueblo, la qual en odio de los Nobles està siempre a devocion de los Virreyes, y ansì es bien traerla favorecida, honrando y haziendo mucha merced a su electo»[58].
Tuttavia, queste proposte si muovevano nella linea tradizionale perseguita dai viceré, di utilizzare il voto e l’opposizione della Piazza popolare ai fini di un rafforzamento delle prerogative viceregie, ma non implicava sostanziali mutamenti dell’assetto politico; afferma infatti il conte di Lemos, che tale strumento deve essere sganciato dalla pretesa di equiparazione del voto popolare a quello delle Piazze nobili. Ciò che invece conferisce specificità alla proposta Ossuna-Genoino e costituisce un elemento di conservazione dinamica, è rappresentato dalla consapevolezza che tale strumento risulta inefficace se non si coniuga con una riforma complessiva dell’ordinamento cittadino. Per questo, dopo aver elencato nel Ragionamento e nel Manifesto, le ragioni della separazione amministrativa, il Genoino, d’accordo con l’Ossuna, decise di convocare le deputazioni della nobiltà di Piazza nella Chiesa di Santa Chiara affinché si risolvesse in senso positivo la partecipazione popolare nell’amministrazione. La separazione, promessa dal Genoino una volta falliti gli otto giorni di incontri e trattative, se sganciava la Piazza popolare dall’egemonia nobiliare, rafforzava i legami con i viceré, inserendo a pieno titolo l’organizzazione politica popolare nella gestione del governo cittadino:
«Altrimente (…) essi Signori di Seggio non volessero concorrere a detta legittima conventione e capi di quella [che alla Piazza popolare sia conferito uguale potere nelle deliberazioni pubbliche], allora dechiara detto fedelissimo Popolo, così altre volte si è protestato di voler vivere separato da detta Nobiltà e non havere sopra di se, eccetto la cognitione di Sua Real Maestà, eccelenza dei Signori viceré pro tempore, e tutti li Reali Ministri, e governarsi da per se stesso, senza communità con detta Nobiltà e sopra di ciò impartirsi l’imposizione dell’auttorità regia, da finirsi e determinarsi dall’Eccellenza dell’Illustrissimo Signor Duca d’Ossuna, come informato del tutto»[59].
Tuttavia, se il progetto di separazione tra nobiltà e popolo, incontrava l’appoggio sostanziale della Piazza popolare, per l’Ossuna era inoltre necessario dividere i gruppi dominanti al proprio interno, in modo da prevenire o interrompere il costituirsi di legami di solidarietà tra gli appartenenti allo stesso gruppo sociale. Ancora nella lettera del 6 settembre, l’Ossuna proponeva al re, con riferimento alle Piazze nobili, di «purgar estas plaças de la gente sediciosa dellas»[60]. Per ottenere questo risultato, la proposta ossuniana si basava su una riforma dell’ordinamento cittadino, volta ad impedire che il potere si consolidi nelle mani di poche famiglie; bisognava evitare, secondo l’Ossuna, l’accesso si Seggi attraverso la successione ereditaria, poiche coloro che definisce sediziosi «han sido siempre estos mismos pocos mas o menos y que va de herencia de padres a hijos»[61]. Questa proposta doveva andare di pari passo con un’altra soluzione avanzata dall’Ossuna; la riforma, infatti, riguardava anche i detentori degli uffici «que no tienen otra cosa de que vivir sino de los oficios»[62]. Dunque, la proposta complessiva riguardava sia l’ingresso dei soggetti nelle Piazze cittadine, sia la scelta di coloro che dovevano far parte della macchina burocratica e amministrativa. L’indicazione offerta dall’Ossuna, si muove nella direzione di concedere la possibilità di accedere agli uffici solo «a los mejores y mas ricos (…) sin que en ellos pueda entrar quien no fuere feudatario»[63]. In questo modo l’Ossuna cerca di offrire un criterio di scelta che accentui la possibilità di un controllo del viceré sull’apparato burocratico; impedire la successione ereditaria, significava contrastare la formazione di un apparato burocratico forte ed autonomo, in grado di mediare il rapporto tra governante e governati ed attraverso quest’opera, appropriarsi del funzionamento dell’amministrazione e condizionare tempi e modalità di deliberazione ed esecuzione delle scelte politiche. Al contempo, tale soluzione collaborava all’opera di frammentazione del ceto ministeriale, in quanto chi volesse accedere agli uffici si sarebbe dovuto trovare in una situazione di dipendenza rispetto a chi, Consiglio d’Italia e viceré, doveva determinarne l’idoneità. Tuttavia, la politica dell’Ossuna, non si limitava ad individuare quei poteri cittadini che attraverso la funzione politica esercitata e il richiamo a costituzioni e privilegi tentavano di limitare le prerogative viceregie, ma comprendeva anche quel ceto feudale che deteneva il proprio potere fuori dalle mura cittadine, nelle province nel regno. Ed anche in questo caso l’Ossuna si servì degli strumenti a disposizione, individuando esattamente i mezzi attraverso i quali era possibile neutralizzare i suoi avversari, ovvero gli alloggiamenti militari. Attraverso gli alloggiamenti, l’Ossuna pensava di poter mettere a punto una serie di interventi appropriati, che privilegiavando i suoi adherenti, contribuissero a contenere ed abbassare la potenza e le ambizioni degli avversari; e di fatto, un capitolo specifico delle Accuse venne dedicato alla gestione degli alloggiamenti da parte del viceré.
Sia i dibattiti negli organi di governo cittadini che le scritture politiche dell’epoca che intendessero offrire un quadro della situazione, concordavano col fatto che gli alloggiamenti erano questione delicata, e che essi rappresentassero una delle principali cause della miseria delle province del regno. Ovunque alloggiassero, i soldati impoverivano e saccheggiavano le terre, e i loro abitanti non ricevevano nessuna protezione né dal barone, né dai governatori provinciali. Senza mezzi termini, un importante scrittore di Ragion di Stato come Girolamo Frachetta[64], traccia un panorama desolante e definisce gli alloggiamenti come «imposizione per via obliqua», che aggiunta a tante altre angherie sofferte, portando il popolo ad uno stato di disperazione, possono rappresentare una causa di «mutatione»:
«ad ogn’uno è noto, che questo Regno stà impoverito, et quasi destrutto per il soverchio peso di tante gabelle, et tributi, et altre angarie per li tanti commissarij, che sono sanguisughe de’ miseri popoli; et molto di più per gli alloggiamenti et transiti de soldati, li quali essendo per tanti anni continuati, hanno avuto forza, non solo d’impoverire i sudditi, ma anco di mettere molti di essi in estrema disperazione, et necessitarli ad abbandonare i villaggi, le terre et le proprie case, et i campi et andar ad habitare in altri stati, et sott’altri Prencipi; da che ne è in parte seguita la incoltura della campagna, et un estremo bisogno di mandare molte volte i denari fuori del Regno, per rimediare con i grani stranieri alla fame della città di Napoli, et quelli che sono rimasi, render nemici al nome spagnuolo, in guisa che se il Regno fosse assaltato, non che volessero difenderlo, ma si può credere che quasi tutti si porrebbono sotto le bandiere de’ nemici, quali che si fossero, senza altra considerazione che di procurare mutamenti et novità»[65].
E’ altrettanto significativo che anche Fabio Frezza scriva nel 1623, vale a dire a ridosso del viceregno Ossuna e nel pieno di una congiuntura economica recessiva, un libro intorno ai rimedi necessari per risollevare le sorti del regno e che il primo ed il secondo discorso ruotino proprio intorno alla questione degli alloggiamenti militari, accostata per importanza all’approvvigionamento cittadino. La scarsezza di pane e le compagnie di soldati che alloggiano nel regno rappresentano per Frezza le due maggiori «infermità» di cui soffre il regno; addittura, secondo l’autore, non vi è cosa:
«più calamitosa (…) che questi alloggi (…); i miseri popoli in mezzo a una sicurissima pace, sono dilaniati come se fossero in guerra; (..) ordinariamente l’insolenza e l’avaritia militare eccede ogni termine ed ogni misura »[66].
Conclude infine Frezza, in consonanza con quanto affermato da Frachetta, che il ricorso agli alloggiamenti «è insopportabile, atto a mettere in disperazione ogni più mansueto popolo (…); è cosa pernitiosissima, non solo à i popoli, ma anco all’istesso Principe»[67]. Tuttavia l’Ossuna, forse non troppo interessato a quanto avveniva tra i popoli della provincia e contando sul potere di controllo e repressione esercitato dai baroni, utilizzò in maniera massiccia il ricorso agli alloggiamenti, e lo fece proprio in funzione antifeudale, o meglio, contro quella parte del ceto feudale a lui avversa. Le Accuse sottolineano questo punto e da esse si evince che i beneficiari di queste operazioni erano proprio quei feudatari vicini all’Ossuna. Ancora una volta il viceré viene accusato di non aver rispettato gli ambiti giurisdizionali e i privilegi dei baroni, avvalendosi di un ampio potere discrezionale:
«Non osservando i priviliegi ed essentioni, che sono Camere riservate dei Baroni, comandò ch’alloggiassero indifferentemente tutte, ancorché fussero libere da simili pesi, eccettuando solamente le terre de’ suoi adherenti»[68].
L’Ossuna poi inviò nelle province, come vicario e luogotenente, il principe di Conca e il marchese di Campolataro, entrambi feudatari suoi adherenti, ritenuti dai redattori delle Accuse inesperti e inadatti e tuttavia spediti dal viceré per desolare le province e abbassare i baroni che ne avevano la giurisdizione. Verso il duca di Vietri e il principe di Sansevero, ma anche verso il principe di Caserta e quello di Stigliano, il viceré agiva adoperando il massimo della forza, mettendoli in carcere, e nell’impossibilità di farlo:
«procurava dannificarli nella robba, come particolarmente avvenne col Principe di San Siviero, con haver mandato cinquecento francesi per distruggere lo stato di San Siviero»[69].
Quando la polemica sugli alloggiamenti militari raggiunse il suo culmine, sul finire del 1618, l’Ossuna rispose energicamente a quanti contestavano la sua politica militare, avvalendosi in particolar modo della sua carica di Capitano generale e di ciò che, secondo il duca, bisognava fare secondo una retta “ragion di guerra”. Però il discorso verte innanzitutto sulla questione delle prerogative all’interno della città, per le quali le Piazze non potevano contestare l’operato del viceré in materia di guerra, in quanto non era di loro competenza e non avevano sufficente notizia di quanto avveniva sul fronte delle operazioni militari:
«Al terzo punto che VV.SS. mi chiedono che comandi ritirare li battaglioni da pie e da cavallo, i luogotenenti generali e Capitani a guerra, non so io quando s’abbia potuto chiedere cosa tale per le Piazze al viceré, poiché né VV.SS. ponno sapere quando convenga levarli, né ritirarli, né lor tocca parlare in questo, non potendo essere informate degli andamenti delle armate nemiche, né tengono potestà dalle Piazze di parlare in questo»[70].
Secondo l’Ossuna, anche se il regno di Napoli non correva rischi di invasioni, non conveniva in alcun modo al re disarmare la provincia italiana, quanto piuttosto rafforzarla, onde prevenire qualsiasi possibile ripresa della guerra e a tal fine il viceré riteneva indispensabili gli alloggiamenti[71]. Però al di là della ragion di guerra e della strategia militare consistente nella disposizione di truppe nelle province del regno, in vista della vasta e complessa opera di prevenzione della guerra, risulta evidente che questi motivi trovano un interessante intreccio con quelle pratiche operative messe in atto dall’Ossuna per la conservazione del comando, a fronte degli attacchi che provenivano dai nemici interni. Infatti, la guerra o la minaccia della guerra, al di là della sua possibilità reale, presentava un indubbio vantaggio immediatamente spendibile dal viceré contro il baronaggio ostile, consentendogli di neutralizzare quei soggetti interni al ceto feudale che insieme alla nobiltà di Piazza, si opponevano alla politica di accentramento di prerogative nelle mani del viceré. Le pratiche di conservazione del comando, allora, passavano attraverso la frammentazione dei ceti al proprio interno; da qui la scelta da parte dell’Ossuna, di puntare sui propri adherenti per controbilanciare l’opposizione sostanziale della nobiltà di Piazza. Infatti, come si può notare dai documenti e soprattutto dalle firme delle lettere inviate al re in favore del duca, all’interno delle singole Piazze nobili non mancavano coloro che traevano un qualche beneficio dalla politica ossuniana, così come erano numerosi gli adherenti del duca sia all’interno del ceto feudale che di quello togato. L’Ossuna allora quando afferma che contro i sobillatori, il viceré si deve avvalere della «resta del Reyno»[72], fa innanzitutto riferimento alla Piazza popolare, in quanto organizzazione politica cittadina, la cui collaborazione era essenziale per controbilanciare il potere della nobiltà di Piazza. Ma al contempo, il riferimento è a tutti quei soggetti presenti all’interno dei singoli ceti, di cui il viceré doveva servirsi, coinvolgendoli nell’amministrazione o nel controllo sociale, per subordinare l’apparato di governo locale alle necessità politiche, militari e finanziarie della corona e legare il proprio destino all’obbedienza al potere vicereale.

L’analisi di documenti relativi al governo politico di Napoli e la lettura di aspetti particolari della produzione teorico-politica, hanno fatto emergere la complessità dei discorsi e delle pratiche conservative teorizzate e sperimentate nel contesto napoletano, in un arco di tempo che non si limita al quadriennio del governo Ossuna. Tali discorsi e pratiche si fondano essenzialmente sul sapere giuridico come fonte e legittimazione del potere; la pratica delle ambascerie, il rispetto delle costituzioni del regno e dei privilegi dei gruppi dominanti, sono elementi decisivi dei processi di conservazione politica. D’altra parte, le pratiche assolutiste e autoritarie dell’Ossuna, ovvero la possibilità che il viceré possa godere di un ampio potere discrezionale e agire al di là di tali costituzioni e privilegi quando la necessità politica lo richieda, tendono ad affiancare la funzione esercitata dal diritto e ad esercitarsi secondo tempi e modalità proprie. Da qui il ricorso da parte dell’Ossuna, ad una serie di saperi e dispositivi politici finalizzati al mantenimento dell’ordine sociale e della gerarchia politica. In particolar modo, il riferimento alla giustizia e al diritto da parte del viceré, concretizzato nella richiesta di traduzione giuridica della separazione tra nobiltà e popolo, viene utilizzato in funzione della necessità di produrre un’innovazione dell’assetto politico, che vada nella direzione di un rafforzamento delle prerogative detenute dal rappresentante regio. E al contempo, tale ricorso al sovrano, era effetto e conseguenza di pratiche di governo utilizzate dall’Ossuna, le quali avevano come obbiettivo politico la frammentazione del corpo sociale, il rafforzamento delle prerogative della Piazza popolare e la neutralizzazione dei poteri cittadini che ostacolavano l’operato del viceré. In tal senso va inteso il ricorso da parte dell’Ossuna, a quel sapere militare o “ragion di guerra”, utilizzata sia per portare a termine la riforma della milizia, che escludeva i nobili riottosi dai compiti militari, sia per allestire gli alloggiamenti dei soldati nelle province contro la feudalità avversa.
Si può dire insomma, che il diritto venne utilizzato dai poteri locali, in funzione di freno e di obiezione alla politica ossuniana e al tempo stesso, come difesa della propria posizione di privilegio nell’assetto politico napoletano. In virtù delle costituzioni, il viceré non poteva avvalersi di un ampio potere discrezionale nella normale pratica di governo, né poteva esistere un momento di necessità, nel quale il viceré sarebbe stato legittimato ad operare autonomamente, scavalcando il normale processo decisionale e sospendendo le garanzie giuridico-politiche dei gruppi dominanti. L’Ossuna, però, intravedeva un pericolo nella conservazione di prerogative e privilegi locali, non solo in quanto risultavano spesso dannosi per una retta amministrazione, ma soprattutto perché rappresentavano un forte condizionamento rispetto all’operato del viceré. A fronte di questa situazione e in chiave di conservazione del comando, l’Ossuna utilizzò innanzitutto la deroga e una serie di dispositivi prudenziali in grado di neutralizzare lo stesso ricorso al diritto, o meglio, quando possibile, di farlo funzionare e subordinarlo alla necessità di garantire che la produzione di obbedienza attraversasse l’intero corpo sociale. Il riconoscimento della gerarchia dei poteri e della preminenza del potere viceregio nei confronti dei gruppi dirigenti locali, passava attraverso il coinvolgimento della Piazza popolare nell’amministrazione cittadina, la cui opposizione alla nobiltà di Piazza e l’appoggio alle istanze viceregie, rappresentavano un elemento di equilibrio nel governo e un freno rispetto alle passioni di comando dell’aristocrazia cittadina.
Il complesso rapporto tra piano giuridico-formale e pratiche di governo era un elemento centrale nei rapporti che regolavano l’articolazione tra poteri diversi nella Napoli spagnola. La produzione politica teorica e le istruzioni del sovrano riguardanti il governo politico del regno, sottolineavano il necessario accordo che doveva regnare tra quanti -viceré, organi di governo, Piazze cittadine-, dovevano collaborare, ciascuno secondo le proprie prerogative, al mantenimento dell’ordine e alla retta amministrazione[73]. I Privilegi e le costituzioni del regno, delimitavano formalmente le prerogative del vicere e sottolineavano la funzione politica del Collaterale che doveva affiancare il rappresentante regio nella risoluzione delle materie di publico interesse. Una metafora spesso utilizzata per descrivere i rapporti tra viceré e apparato di governo locale, fa riferimento al corpo naturale, la cui salute dipende dalla giusta corrispondenza tra le varie parti del corpo -testa, membra e organi- che devono garantirne il funzionamento[74]. Il rispetto delle “costituzioni”, la centralità della legge, sono le caratteristiche essenziali della sovranità politica, condizione di riconoscimento del potere sovrano e garanzia di fedeltà del regno. Tuttavia, al rapporto comando-obbedienza fondato sulla legge, si giustappone l’esercizio di una pratica politica da parte dei viceré che ha come riferimento quei dispositivi di governo, quelle pratiche soggettive di comando, articolate intorno a tecniche ispirate alla prudenza politica. Queste possono efficacemente intervenire in tutte quelle occasioni «que no tienen regla cierta y ocurren algunas vezes, [queste] quedan siempre a la prudencia del Virrey y su indicacion se toma por la mayor parte de circunstancias que pidan secreto, prisa en el despacho, o el calor o authoridad del escritorio»[75]. Ovvero, si ammette che vi è un campo di intervento di esclusiva competenza del viceré, non codificato giuridicamente e dunque non definibile dalla forma della sovranità, che si fonda su una specifica temporalità politica e il cui principio di azione si inscrive non in un patto o in un “contratto”, ma nella sapiente lettura e utilizzazione dei tempi e delle opportunità politiche.
All’incrocio di
questi due momenti, della sovranità e dell’arte di governo, si colloca il viceregno
dell’Ossuna; vale a dire che la sua azione si dispiega tra la messa a punto di
una serie di dispositivi prudenziali e una riforma complessiva dell’ordinamento
politico cittadino, la cui novità, e forse la causa principale del suo
fallimento, consiste nella messa in discussione dell’efficacia della
tradizionale linea di governo della corona nella provincia napoletana.
L’alleanza tra Piazza popolare e potere viceregio, la separazione tra nobiltà e
popolo e il suo riconoscimento giuridico e politico rappresentano i punti
essenziali del governo ossuniano, nonché momento in cui precipitano e si
incrociano diverse istanze conservative e progettualità politiche. In effetti,
la Piazza popolare, intravedeva nel progetto ossuniano la possibilità di
recuperare posizioni all’interno del governo cittadino e nella gestione
amministrativa, e di sganciarsi dalla posizione subalterna in cui si trovava
rispetto alle Piazze nobili. La divisione di competenze e prerogative, frutto
della politica spagnola, aveva portato i togati ad assumerre la conduzione del
governo politico e la nobiltà di Piazza in una posizione di preminenza negli
organi rappresentativi cittadini, con la sostanziale esclusione della Piazza
popolare. La manifestazione delle conflittualità esistenti all’interno del
corpo sociale napoletano, accentuatesi durante il governo ossuniano, se sono
parte di un progetto di conservazione politica del Regno di Napoli sotto
l’impero spagnolo, rappresentano anche momenti di emergenza di bisogni e
rivendicazioni del ceto popolare -stretto tra la morsa delle pretese
finanziarie della corona e l’egemonia nobiliare- che avranno modo di rivelarsi
con tempi e modalità distinte e decisamente radicali nella rivoluzione del
1647.
[1] E’ tuttavia possibile utilizzare come base di partenza, i riferimenti ad autori e testi napoletani della fine del XVI secolo e della prima metà del XVII, presenti nelle opere di R. Villari, V. I. Comparato, G. Muto, G. Galasso, R. Ajello. Soprattutto a quest’ultimo, si deve l’importante rivalutazione storiografica, rispetto alla tradizionale concezione crociana, del ruolo e del contributo politico-culturale dell’aristocrazia napoletana dopo la lunga esperienza di governo di Don Pedro de Toledo, R. Ajello, Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi, ESI, 1996. Invece, per quanto riguarda la presenza e l’importanza dei movimenti e delle scritture politiche popolari, cfr. Rosario Villari, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647), Laterza, Bari, 1967 e Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo, Editori Riuniti, Roma, 1979.
[2] Oltre all’opera di G. Coniglio, Il viceregno di don Pietro di Toledo,Giannini, Napoli 1984, l’altra indagine sistematica, per quanto riguarda la storiografia italiana, su un vicerè di Napoli, è stata dedicata proprio al III duca d’Ossuna, l’ottima, seppur non recente, monografia di Michelangelo Schipa, La pretesa fellonia del duca d’Ossuna, tipografia Luigi Perno, Napoli, 1912. La storiografia spagnola, invece, si è concentrata soprattutto sui viceré delle colonie americane; tuttavia è utile segnalare le opere di C. J. Hernando Sanchez, Castilla y Napoles en el siglo XVI: el virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553), Junta de Castilla y Leon; dello stesso autore, Politica de Estado, clientelas y cultura en Napoles bajo el virrey Pedro de Toledo, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1993; Jose del Moral, El virrey de Napoles don Pedro de Toledo y la guerra contra el Turco, C.S.I.C., Madrid, 1966; M. de la Torre Vilar, El Cardenal Zapata, protector de España cerca de la Santa Sede y virrey de Napoles, Universidad de Madrid. Tesis ineditas, 1928. Al III duca d’Ossuna sono state dedicate altre tre opere, L. Barbe, Don Pedro Tellez Giron, duc d’Osuna, vice-roy de Sicile: 1610-1616. Contribution à l’étude du régne de Philippe III, Elleg, Grenoble, 1992; E. Beladiez, Osuna el Grande: el duque de las Empresas, Alhambra, Madrid, 1954; C. Fernandez Duro, El Gran duque de Osuna y su marina, Madrid, 1885.
[3] Per quanto riguarda la riforma del Collaterale avvenuta intorno al 1540 v. R. Ajello, Una società anomala…; una ricostruzione puntuale della composizione politica e sociale del Collaterale e della Sommaria, è presente nei lavori di G. Muto, in particolare «Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola», in Le città capitali a cura di C. De Seta, Bari, 1985, pp.xx-xx; Saggi sul governo dell’economia nel Mezzogiorno spagnolo, ESI, Napoli, 1992 e nelle ricerche di V. I. Comparato Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell’ideologia del magistrato nell’età moderna, Firenze 1974.
[4] G. Muto, «Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola», p.
[5] A questi elementi vanno aggiunti, come sottolineano Giuseppe Coniglio e Carlo M. Cipolla, il ruolo giocato dalla legislazione corporativa -che impedì qualsiasi modificazione del processo produttivo e l’abbassamento dei costi di produzione-, e l’aumento dei prezzi delle derrate agricole che favorì la concorrenza di inglesi, francesi e olandesi a spese dei produttori napoletani; G. Coniglio, Il viceregno di Napoli nel secolo XVII. Notizie sulla vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli, Roma, 1955, pag. 14; C. M. Cipolla, «The decline of Italy. The case of a fully matured economy», in The economic history review, II serie, vol. 5 (1952), pagg. 178-187.
[6] Pier Luigi Rovito, Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento, Jovene, Napoli, 1981.
[7] Vittorio Lunetti, Politica mercantile. Dell’espedienti, e arbitrij per publica utilità. Nelle quali con vere raggioni si mostrano le cause delli danni della Città, e regno di Napoli, e il vero modo di rimediarli, Napoli, Lazzaro Scoriggio, 1630.
[8] Per quanto riguarda i rapporti tra assolutismo e strutture amministrative nella prima età moderna, cfr. J. Vicens Vives, «Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII», in Comité International Des Sciences Historiques, XI Congrès international des Sciences historiques (Stockholm, 21-28 août 1960), Rapports, vol. IV, Histoire moderne, Goteborg-Stockholm, Uppsala, 1960.
[9] Fadrique Furiò Ceriol, El consejo y consejeros del principe, Amberes, Viuda de Martin Nucio, 1559.
[10] Sulla formazione e la composizione delle fazioni nella corte di Filippo II v. J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716, Londra, 1981, trad. it. , La Spagna imperiale 1469-1716, il Mulino 1982, pagg. 295-325; Fernando Bouza Alvarez, La corte de Felipe II, Alianza, 1994; José Martinez Millan (a cura di), Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquia catolica. Actas del congreso internacional Felipe II (1598-1998), Madrid, 1998; Alfredo Alvar Ezquerra, Felipe II: la corte y Madrid, CSIC, 1985; James M. Boyden, The courties and the King: Ruy Gomez da Silva, Philip II, and the court of Spain, Berkeley, 1995.
[11] Sul valimiento come novità istituzionale, v. Francisco Tomas y Valiente, Los validos en la monarquia española del siglo XVII (estudio institucional), Instituto de Estudios Politicos, 1963; più direttamente collegato al costituirsi delle fazioni nella corte, il più recente contributo di Francesco Benigno, L’ombra del re, Marsilio 1991 e l’importante lavoro diretto da J. H. Elliott e Laurence Brockliss, El mundo de los validos, Taurus, 1999.
[12] Al riguardo cfr. Menendez Pidal (a cura di), Historia de España, vol. XXIV, «La España de Felipe III», Espasa-Calpe, 1979 e relativa bibliografia.
[13]Ossuna al re, 16 dicembre 1616, Biblioteca Nacional de Madrid (d’ora in poi B.N.M.), ms. 1431, fol. 31r.
[14]In questo senso vanno lette, oltre ai testi storico-politici, le pubblicazioni riguardanti “Privilegi, capitoli e grazie” che venivano redatte dalle diverse parti del corpo sociale. Ognuna di queste, rivendicava una supremazia da far valere nei confronti dell’altra, mentre ricordavano al sovrano e al suo rappresentante, il viceré, di rispettare sempre e comunque le “costituzioni” del regno. In particolare, le “Grazie” erano la contropartita politica del donativo biennale di un milione e duecentomila ducati -stilate dall’apposita “Deputazione” durante le riunioni del Parlamento che ne doveva ratificare la donazione-, che il sovrano convertiva in “Privilegi e Capitoli”, fondamento delle “costituzioni del regno”. Per la Piazza popolare, una recopilazione fu messa a punto da Francesco Imperato, Privilegi, Capitoli e Gratie concesse al fedelissimo populo Napolitano e alla sua Piazza, Napoli, Gio. Domenico Roncagliolo, 1624.
[15] Gio. Antonio Summonte, Historia della Città e Regno di Napoli, libri quattro. I primi due volumi, stampati nel 1599, furono pubblicati nel 1601, mentre il terzo e il quarto, apparvero al publico solo quarant’anni dopo la morte dell’autore, tra il 1640 e il 1643; Francesco Imperato, Discorso politico intorno al Reggimento delle Piazze della Città di Napoli, Napoli, Felice Stigliola, 1604; dello stesso autore cfr. Privilegi Capituli e Gratie… e i Discorsi intorno all’origine, Regimento e Stato della Gran Casa della Santissima Annunziata di Napoli, Napoli, Tarquinio Longo, 1629;Camillo Tutini, Dell’origine e fondatione de’ Seggi di Napoli, Napoli, 1644.
[16] Per un’analisi dettagliata della questione e per l’interpretazione data dai diversi storici che l’hanno trattata, cfr. M. Schipa, La pretesa fellonia…
[17] Capi mandati alla Maestà del Re Nostro Signore per questa fedelissima città di Napoli contro il duca d’Ossuna, B.N.M., ms. 5972, fols. 215-228.
[18] Francesco Imperato, Discorso politico…
[19] M. Schipa, La pretesa fellonia…
[20] Coleccion de documentos ineditos para la historia de España (d’ora in poi DocIned), Viuda de Calero, 1864, vol. XLV, pag. 412.
[21] Ibidem, pag. 415.
[22] Consulta del Consejo de Estado, 17 settembre 1616, ibidem, pagg. 426-431.
[23] Copia de carta de Pedro de Oña, obispo de Gaeta para don Juan de la Sal obispo de Bona, sobre el gobierno del duque de Osuna en Napoles y competencia del Cardenal Borja, que le sucedia en el gobierno, 10 giugno 1620, B.N.M., ms.1222, fols. 77-116. La stessa lettera fu oggetto di risposta da parte degli avversari del duca ed inserita in Giuliano, Memorie de’successi tra li deputati della città di Napoli e Duca d’Ossuna, B.N.M., ms. 1817, tomo I, fols.100-117, seguita da alcune Considerationi, in cui vengono duramente criticate le posizioni del vescovo, giudicate eretiche e «contrari ad una vera ragion politica».
[24] Ibidem, fols. 101v-103r.
[25] Ibidem, fols. 104r.-105v.
[26] DocIned, vol. XLV, pagg. 236-246.
[27] ibidem, pag. 237. Sull’impedimento giuridico e l’inopportunità politica della pretesa dei viceré di sottoporre a processo i ministri del regno e sospenderli dagli uffici, cfr. il documento di difesa del reggente Alfonso Suarez, nota 72.
[28] ibidem, pag. 238.
[29] ibidem, pag. 241.
[30] ibidem, pagg. 242-243.
[31] In moltissime fonti dell’epoca troviamo l’espressione «fedelissima città di Napoli», soprattutto nei documenti indirizzati dalla città direttamente alla corte. Per quanto riguarda il concetto di fedeltà nel Regno di Napoli nel XVII secolo, v. Rosario Villari, Per il re o per la Patria. La fedeltà nel Seicento: con il “Cittadino Fedele” e altri scritti politici, Laterza, Bari, 1994.
[32] DocIned, vol. XLV, pagg. 245.
[33] DocIned, vol.XLV, pag. 115.
[34] Ibidem.
[35] Mi rifaccio, in questo caso, all’interpretazione data da Raffaele Colapietra, «Il governo spagnolo nell’Italia meridionale. Napoli dal 1580 al 1648», in Storia di Napoli, Napoli, vol V, 1972. Una diversa e suggestiva ipotesi, è stata elaborata da Rosario Villari, La rivolta antispagnola... Secondo il Villari, l’episodio dell’uccisione dell’Eletto del popolo, costituisce una prima, per quanto immatura, manifestazione di protagonismo del popolo napoletano, che si rivelerà pienamente, con contenuti apertamente antispagnoli, nel 1647 con la rivoluzione capeggiata da Masaniello.
[36] Advertimientos para el conde de Olivares (1595), B.N.M., ms. 6285, fol. 36r. La trascrizione di buona parte del documento è in appendice al testo di Rosario Villari, La rivolta antispagnola….
[37] Pedro de Oña a don Juan de la Sal, fol. 82v.
[38] Oratione di Fabio Caracciolo alla Maestà Cattolica del Re Filippo III per giustificazione del Popolo dato al Cardinal Borgia del Governo di Napoli, in Gio. B. Giuliano, Memorie de’ successi…, fols. 229v-229r.
[39] Carta del III duque de Osuna virrey de Napoles para el Rey Felipe III enviada al Duque de Uzeda acerca de las Plazas de la Ciudad de Napoles y haber desunido la nobleza della del pueblo, Archivo Historico Nacional (Madrid), sezione Ossuna (sezione distaccata presso l’Archivo de la Nobleza, Toledo), leg.14, n. 1 a, fols.60-64.
[40] Copia de carta del duque de Osuna para S.M., B.N.M., ms. 1431, fols.131-133.
[41] Ossuna a Uceda, 6 settembre 1619, fol. 61v.
[42] ibidem, fol. 63r.
[43] Capi mandati…, fol. 222.
[44] Ibidem.
[45] Ossuna a Uceda, 6 settembre 1619, fol. 60r.
[46] Ossuna al re, DocIned, XLVI, pagg. 69-70.
[47] Ossuna a Uceda, 6 settembre 1619, fol. 60r.
[48] Francesco Zazzara, Giornali di quello che accadde in Napoli nel governo fatto da D. Pietro Girone Duca di Ossuna dal 1616 al 1620, libri tre, Biblioteca Nazionale di Napoli., ms. I. C. 5.
[49] Schipa, M., La pretesa fellonia…, pag. 34.
[50] ibidem, pagg. 34-35.
[51] Capi mandati…, fol. 223.
[52] Giuliano, Memorie de’ Successi…, fol. 77. Sull’importanza e sui compiti dei Capitani di strada cfr. Francesco Imperato, «Reformatione di nuovo fatta per lo Reggimento delle Piazze Populari della Città di Napoli», in Privilegi, Capitoli e Gratie…; la prima edizione è del 1598. Il testo è importante perché rivela il carattere strategico di tali figure per l’amministrazione della Piazza popolare. I Capitani esercitavano i loro poteri sia in tempi di agitazioni e tumulti che in tempo di pace; dovevano provvedere all’arresto dei facinorosi affinché «con il castigo si smorzino et estinguino», custodire le porte delle città di cui detenevano le chiavi, tenendole chiuse di notte e «aperte e ben guardate di giorno», evitare speculazioni, punire gli incettatori e «numerar le persone dell’Ottine per dispensarli il pane», pagg. 86 e 90.
[53] Ibidem, fols. 78-79.
[54] Ibidem, fol. 82.
[55] Ibidem.
[56] Fernando Ruiz de Castro, conde de Lemos, Informe sobre el Reino y ciudad de Napoles, B.N.M., fols. 32r-33v. Non si tratta del più famoso Pedro Fernandez de Castro, conte di Lemos, che governò il regno prima dell’Ossuna; Fernando fu viceré dal 1599 al 1601, anno in cui una malattia che lo condusse alla morte lo costrinse a lasciare il governo del regno.
[57] Ibidem, fol. 34v.
[58] Advertencias politicas de un Virrey de Napoles para su sucesor en el gobierno, B.N.M., ms. 2445, fols. 270-293.
[59] Manifesto…, fols.83r.-84v.
[60] Ossuna a Uceda, 6 settembre 1619, fol. 63r.
[61] ibidem.
[62] ibidem, 64v.
[63] ibidem.
[64] Girolamo Frachetta, Discurso sobre cosas del Reyno de Napoles, B.N.M., ms. 6285, fols. 55r.-56v., 1609 (?).
[65] ibidem, fol. 56.
[66] Fabio Frezza, Discorso intorno ai rimedi d’alcuni mali ai quali soggiace la città e il Regno di Napoli. Con altre scritture concernenti il servitio e l’utile di Sua Maestà Cattolica, Napoli, Tarquinio Longo, 1623, pagg. 5-6.
[67] ibidem, pagg. 12-16.
[68] Capi mandati…, fol. 220.
[69] ibidem, fol. 217.
[70] Gio. Bernardino Giuliano, Memorie de’ successi tra li Deputati della Città di Napoli e duca d’Ossuna, t. I, B.N.M., ms. 1817.
[71] Ossuna al re, DocIned, XLVI, pagg. 298-299; XLVII, pagg. 44-46. Ossuna ai Seggi, XLVII, pagg.73-74.
[72] Ossuna a Uceda, 6 settembre 1619, fol. 63v.
[73] Una sistematizzazione giuridico-politica della teoria “contrattualista”, fu messa a punto da Carlo Tapia, Ius Regni Neapolitani, Napoli, ex typ. Carlini, 1605.
[74] «La forma del gobierno viene a consistir en unirse el Virrey con su Collateral, a imitacion de los cuerpos naturales donde siempre andan a una la cabeça y los otros miembros no obstante la distincion de sus officios», Advertencias politicas…, B.N.M., ms. 2445, fol. 70. La rivendicazione di una pari dignità politica tra viceré e ministri del Collaterale viene esplicitamente espressa anche da un documento in difesa del reggente Suarez quando fu processato e sospeso dagli uffici dal Lemos: «La potestad que tienen todos los Virreyes en los Reynos que goviernan es la misma que antiguamente tenian los Presides y Proconsules en las Provincias y se regula por las mismas leyes, que hablan en el derecho de los Romanos destos officios (…) y la jurisdiccion del Preside no se estiende si no a los hombres sujetos à su Provincia (..) y claro està que los Provinciales son los vasallos y no los Ministros y menos los que son a latere Principis, como son los Regentes (…) y tienen la misma jurisdiccion ordinaria suprema comunicada con el dicho Virrey de tal manera que se considera todo un cuerpo, una potestad y una jurisdiccion, administrada por el Consejo Collateral del qual es cabeza y Presidente el dicho Virrey, y tiene los dichos Regentes voto decisivo para todas las cosas de Justicia, Gobierno y hazienda de su Magestad (…). De donde es, que muerto el Virrey el Consejo Colateral representa la misma persona de S.M. y tiene la misma autoridad que tiene el proprio Virrey. Teniendo los Regentes igual potestad y una misma jurisdiccion ordinaria en la Canceleria que tiene el Virrey, no puede el Virrey ni tiene jurisdicion para procesarles (…), que el corregidor no tiene potestad para procesar a su teniente o Alcalde maior, cum Par in Parem no habet imperium, y trahe algunos enconvenientes, que en razon de buen gobierno se seguirian de lo contrario (…)», Representacion del regente Juan Alfonso Suarez contra el conde de Lemos, virrey de Napoles, B.N.M., ms. 6729, fols. 5v-8v.
[75] ibidem, fol. 71.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo