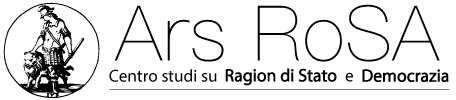Immaginario aumentato
Photoshop è uno dei programmi più conosciuti per modificare le immagini, talmente iconico che dal suo nome è derivato un verbo: photoshoppare, per indicare chiaramente che un’immagine digitale è stata modificata in qualcosa di diverso dall’originale. Una delle caratteristiche del programma è di poter intervenire e correggere perfino l’unità più piccola di ogni scatto digitale, il pixel; l’altra caratteristica è la possibilità di inserire dei livelli sotto o sopra la foto, così da aggiungere sfondi o particolari, prima non presenti. Quel che il software restituisce allo sguardo è quindi una visione di prospettiva.
Un tale strumento informatico è stato pienamente sfruttato dalle app social. La più famosa è Instagram, ma ne esistono altre come Facetune o Snapchat, che permettono agli utenti, per lo più adolescenti fino venti anni, di trasformare il proprio viso e il proprio corpo in qualcos’altro. Infatti, oltre a trasformare il proprio viso con stili fumettistici, è anche possibile di aggiungere delle parti anatomiche come orecchie di gatto o nasi di cani o di altri animali, che rendono il viso buffo o ridicolo. È bene ricordare che gli utenti partecipano attivamente nella scelta delle correzioni da apportare al proprio ritratto digitale, ma possono anche impostare degli effetti nuovi oppure crearne di propri, cioè decidere quali elementi fantastici inserire o quali sfondi o colori privilegiare, rispetto agli strumenti di augmented reality (AR) che sono forniti dalle applicazioni.
Questa tecnica di manipolazione delle immagini incide profondamente sul registro immaginario, perché comporta una doppia dissociazione: la prima nel soggetto che non si percepisce pienamente come sé; l’altra negli altri che non riconoscono le altre singolarità fuori dal contesto dei social media. L’immaginario digitale sconvolge il ruolo dell’Urbild dell’Io, perché mette nuovamente in discussione la valenza fondativa e formativa che l’immagine ha per il soggetto. Infatti, se «l’immagine del corpo offre al soggetto la prima forma che gli permette di situare ciò che è dell’io e ciò che non lo è»1, la strumentazione informatica incide sulla visione che le soggettività hanno di sé, anzi a dir meglio, la virtualità incita e sostiene una rimodulazione della propria corporeità.
Un’azione resa possibile dal progresso delle ICT, ma che poggia su un meccanismo psichico preciso:
le istanze psichiche fondamentali devono per lo più essere concepite come rappresentazioni di ciò che si verifica in un apparecchio fotografico, ovvero le immagini, sia virtuali sia reali, prodotte dal suo funzionamento. L’apparato organico rappresenta il meccanismo dell’apparecchio, e ciò che noi apprendiamo sono delle immagini2.

Il secondo narcisismo
La voglia di assomigliare alle immagini, che i filtri delle app restituiscono, è un atteggiamento molto diffuso, che è stato definito selfie dysmorphia e ha comportato anche un aumento nella richiesta di chirurgia plastica, tant’è che la rivista medica americana specializzata in chirurgia facciale ha affermato: «filtered images blurring the line of reality and fantasy could be triggering body dysmorphic disorder (BDD), a mental health condition where people became fixated on imagined defects in their appearance».3
Le nuove tecnologie informatiche, attraverso gli schermi degli smartphone, restituiscono ai soggetti un’immagine differente della propria corporeità, una modifica radicale dovuta al cambiamento nella relazione immaginaria. Il soggetto è ingannato da un riflesso che non riconosce come proprio, un senso di smarrimento che scardina la costruzione identitaria, in cui il ruolo della produzione di immagini svolge una funzione precisa. Infatti, se la prima forma di narcisismo è legata all’immagine e ha il compito di assicurare l’unità del soggetto, c’è poi una seconda forma il cui «pattern fondamentale è immediatamente la relazione con l’altro»4.
Nella seconda declinazione del narcisismo lo schermo immaginario si pone come un’apertura verso l’esterno e verso l’alterità, cioè l’immagine diviene visione e mostra che esiste qualcosa di diverso rispetto al proprio io e al proprio corpo. I soggetti comprendono così di essere in una relazione con l’altro(ve), un legame che si basa sul «rapporto immaginario e libidico con il mondo in generale»5. La seconda ipotesi narcisistica comporta il compimento, anzi la realizzazione, della identità del soggetto, ma perché ciò avvenga è necessario che tale processo si compia nell’altro: «per acquistare auto-identità, il soggetto deve identificarsi con l’altro immaginario, deve alienare se stesso, deve cioè porre la propria identità al di fuori di se stesso, per così dire, nell’immagine del suo doppio»6.
Nell’iper-modernità però le superfici dei dispositivi digitali favoriscono lo scivolamento e lo schiacciamento dell’io sull’altro, ovvero il soggetto non riesce a sganciarsi dal proprio riflesso e resta irretito nella proiezione virtuale del proprio corpo, trovando difficoltà a imbastire un rapporto corretto verso l’altro. Il tentativo di connessione con il proprio avatar è caratterizzato da un percorso non lineare ma curvo, che non sposta verso l’esterno, ma riporta verso se stesso, quindi verso un narcisismo 2.0, che ha degli effetti deleteri, giacché si avvita all’interno di una fascinazione che immobilizza. Il display ha per il soggetto una funzione cattivante, cioè una forma che lo affascina e lo blocca allo stesso tempo, tanto che non riesce a tirarsene fuori.
Sembra che la cifra fondamentale del nostro tempo sia proprio quella di esaltare la presenza come unica forma di vita possibile. La connessione perpetua e incestuosa con l’oggetto deve scongiurare ogni possibilità dell’assenza e formare lo spettro sempre presente della Cosa insieme al suo possibile annientamento simbolico7.
Il soggetto si guarda nella dimensione virtuale e avverte la mancanza di sé: l’immaginario tecnologico fatto di pixel e di filtri delle applicazioni ha trasformato le singolarità e le loro immagini manipolate in tanti piccoli oggetti a, di cui ognuno avverte emotivamente la mancanza. Il compimento della costruzione identitaria avviene nella funzione simbolica, quando da immagine le singolarità divengono sguardo, perché «non c’è niente che non sia visibile e non debba la sua esistenza allo sguardo che la vede»8; sembra invece che la dimensione virtuale/immaginaria stia consolidando un processo di soggettivazione che esalta invece la visione.
Quando la soggettivazione tende all’immagine e non alla parola, allora si è di fronte a un processo che ha completamente modificato i propri parametri. Un selfie non è un semplice scatto che ci ritrae, ma è la manifestazione chiara di una mutazione antropologica in atto, in cui le singolarità cercano di auto-fondarsi grazie al riflesso di un’immagine che però non le soddisfa pienamente e che provano continuamente a modificare con i filtri di Snapchat, tanto da incorrere nell’effetto di retroversione:
che si basa proprio su questo livello di immaginario; esso è sostenuto dall’illusione del sé come agente autonomo che è presente fin dal principio quale origine delle proprie azioni: questa esperienza immaginaria del sé è il modo in cui il soggetto misconosce la sua radicale dipendenza dal grande Altro, dall’ordine simbolico quale sua causa decentrata9.
La strutturazione simbolica di una soggettività non è la semplice acquisizione di un linguaggio e il relativo complesso di norme, ma è soprattutto la possibilità di discernere all’interno dell’enorme congerie di esperienze sensoriali che ci investono ed «è la parola, […] a definire il grado di maggiore o minore perfezione, completezza e approssimazione dell’immaginario»10.
Quando l’immagine non si completa nello sguardo, cioè l’immaginario non si definisce nel simbolico, si ha un contemporaneo spostamento dal piano del desiderio al circolo del godimento.
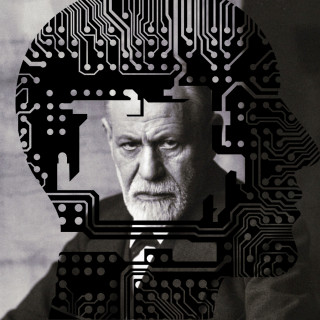
Il soggetto piccolo
Il tempo trascorso davanti allo schermo ha stravolto l’articolazione tra immagine, fantasia e realtà, mentre la potenza delle tecnologie informatiche ha conferito un ruolo decisamente più importante al funzionamento dello scenario immaginario. La pervasività delle immagini digitali ha intaccato considerevolmente la funzione della fantasia, che per il soggetto serve a dare un ordine, seppur provvisorio, al territorio che lo circonda. Infatti la fantasia è «ciò che fornisce il quadro della realtà»11, è cioè quel processo diretto e primario mediante il quale l’esperienza acquista una forma e un primo accenno di significato.
Al contempo, la fantasia è quel meccanismo che controlla che la connessione con la realtà esterna sia sempre confortante. Tra realtà e fantasia esiste un margine che non è mai cauto attraversare, senza incorrere in un profondo scompenso nel processo di soggettivazione; infatti il filtro fantastico assicura che le immagini che provengono dall’esterno non producano un effetto perturbante sui singoli. Qualora rimuovessimo questa lente fantasmatica, i soggetti scoprirebbero con sgomento che «dietro di essa non c’è nulla, e che questo nulla è proprio ciò che la fantasia maschera»12. Quindi, tra fantasia e realtà c’è una reciprocità che assicura che le due dimensioni siano in relazione, in contatto, ma non si confondano. Il display diviene il diaframma fantasmatico dell’iper-modernità, che si frappone tra le singolarità e la realtà, così che lo schermo di ogni device diventa l’accesso privilegiato e talvolta unico al mondo esterno.
Con il prevalere del circolo immaginario, in cui è il virtuale a prendere il sopravvento, non solo si genera una confusione, ma è la fantasia ad acquisire una valenza che la dimensione digitale amplifica, con la possibilità che «quando però si tratta di un’immagine fantasmatica, predomina un movimento ripetitivo e chiuso su se stesso. L’immagine fantasmatica […] è […] prevalentemente un’immagine immobile, un elemento sospeso, fisso, anche se erratico»13.
La superfice immaginaria dell’era tecnologica proietta delle GIF (Graphics Interchange Format), cioè delle immagini in movimento, o meglio una breve sequenza di frame che continua a riprodursi senza fine. Solo che tale movimento si articola in un loop che confonde l’utente – non si è più soggetti – e permette un continuo salto dimensionale, dentro e fuori dallo schermo, tanto da rendere possibile alle singolarità di vivere sempre più spesso nell’intersezione tra queste due superfici.
La circolarità delle immagini digitali quando si ripete non fa altro che riferirsi a se stessa, una ripetizione che taglia fuori la dinamica del desiderio dal soggetto, perché desiderare è sempre «una dipendenza […] rispetto al desiderio dell’Altro»14 e porta in primo piano un’immagine primaria, una certezza quasi immediata, cioè la corporeità dei singoli e la molteplicità delle sue declinazioni.
All’interno dell’universo digitale, il piano corporeo subisce un intervento costante e massiccio, perché questa procedura ripetitiva, che annienta la spinta propulsiva del desiderare, nella realtà è estremamente più proficua, perché il corpo è una superfice che permette delle continue manipolazioni e modificazioni, e, allo stesso tempo, implica una forma di piacere maggiormente diffusa, perché «un corpo è qualcosa che si gode»15. Ovviamente, il godimento nasce nella ripetitività e si nutre di tale movimento. Quando questo circolo assume un valore negativo, si avvita su di sé e degenera, «è questa ripetizione dell’Uno di godimento, che si può chiamare pura ripetizione, e alla quale oggi è stato dato il termine di addiction, dipendenza»16.
Le patologie che affliggono il desiderio hanno nomi diversi, ma insistono proprio su un movimento ripetitivo: shopping compulsivo, iperattività sono i nomi di dipendenze indotte dalla modificazione della scena immaginaria, un cambiamento che è manifestazione di una jouissance sfrenata che ha cancellato la dialettica del desiderio.
Le immagini di uno smartphone costituiscono il portale fantastico mediante il quale il soggetto diviene oggetto ma non del proprio desiderio, perché desiderare non è mai un rapporto con l’oggetto, ma sempre qualcosa che va oltre, anzi «la possibilità stessa dell’esistenza di un IO è così messa in relazione con il carattere fondamentalmente desiderante […] del soggetto»17. La funzione desiderante è una meccanica che non si può ridurre, mentre nel registro tecnologico immaginario è la proiezione incessante e pervasiva a legare i soggetti a immagini che lo avvolgono, lo irretiscono e, soprattutto, lo ammaliano. Quel che le foto digitali restituiscono, o meglio ritraggono, è un corpo in una molteplicità di declinazioni, ma la centralità della fisicità sposta decisamente il paradigma dal desiderio al godimento.
Finora, l’immaginario ha rappresentato un primo accesso alla dinamica del desiderio, anzi solo quando «gli oggetti reali, che passano per l’intermediazione dello specchio e attraverso di esso, si trovano allo stesso posto dell’oggetto immaginario. Ciò che è proprio dell’immagine è dato dall’investimento da parte della libido. Si chiama investimento libidico ciò per cui un oggetto diventa desiderabile»18. Purtroppo, la digitalizzazione dell’immagine ha stravolto la visione e ha ridotto lo sguardo del soggetto, tanto che da soggetto del desiderio si è ridotto a oggetto piccolo a, cioè il più evanescente ed effimero delle tensioni desideranti. In molti casi quello che si percepisce e si indica come oggetto, è assolutamente un nulla, che ha il solo merito di essere all’interno di un cono di luce, che ne permette la visibilità.
All’interno della nuova funzione immaginaria l’oggetto piccolo a è un barlume che promette e che affabula, ma si rivela purtroppo un’illusione. La peculiarità di ogni oggetto piccolo a è il vuoto che custodisce, solo che nello spazio dei pixel questa mancanza si riempie di lusinghe che ammaliano il corpo dei soggetti, che si perdono nelle gallerie di immagini che affollano le numerose applicazioni di fotoritocco. Nel bagliore dello schermo, l’oggetto piccolo a abbraccia «tutte le forme capaci di imprigionare il soggetto in nome del desiderio, della sua propria immagine allo specchio fino all’immagine in quanto tale»19. In questo inganno di riflessi, soggetto e oggetto piccolo a si scambiano di posto, in una confusione, o meglio sovrapposizione, da cui il soggetto non riesce più a districarsi, fino a provare turbamento di fronte alla propria immagine, talmente priva di difetti da affascinarlo e legarlo a uno stato in continuo cambiamento.
Nell’immaginario tecnologico, il soggetto piccolo a racchiude l’indeterminatezza della propria identità, proprio perché è un’illusione che inganna e che non porta da nessuna parte, sebbene si mostri sullo sfondo di un movimento incessante. Il soggetto piccolo a per propria costituzione sarà quindi nostalgico, perché sempre alla ricerca; questo perché «l’oggetto a è qualcosa da cui il soggetto, per costituirsi, si è separato come organo. Vale come simbolo della mancanza, del fallo, ma in quanto esso fa mancanza»20.
Il paradosso di questo processo è che produce continuamente la mancanza che lo sostiene: il soggetto rincorre un’immagine mutevole, che non è e che non sarà, mentre, a sua volta, l’immagine cambia nei diversi filtri che la producono. Il soggetto piccolo a si avvita su se stesso in una dinamica che potrebbe non avere fine, anzi è forse meglio che non abbia fine, perché al termine della ricerca potrebbe essere turbato dalla effimera bellezza della sua stesa immagine, infatti «l’oggetto sublime è un oggetto a cui non ci si può accostare senza che esso perda le sue caratteristiche sublimi e si trasformi in un volgare oggetto comune; esso può persistere solo in un interspazio, in uno stadio intermedio, osservabile da una precisa prospettiva, intravisto»21.
Conclusioni
Con il termine di immagine regina Jacques Lacan indica le immagini che sopravvivono al naufragio dell’immaginario. Secondo la sua interpretazione, sono tre, cioè il corpo proprio, il corpo dell’Altro e il fallo, ovvero la contrapposizione netta tra il pieno della corporeità e la vuotezza del fallo.
È da sottolineare che la dimensione corporea balza in primo piano «dalla mancanza d’armonia significante»22, ovvero quando l’ordine simbolico perde parte della sua funzione, allora il corpo diviene il luogo in cui l’immagine e il godimento si congiungono. In altre parole, «si è arrivati a dover constatare che il soggetto una volta che aveva disinvestito il suo desiderio […] è il godimento che viene in primo piano, quello del corpo che si chiama corpo proprio»23.
Nelle intenzioni di Lacan, una nuova teoria delle immagini è possibile proprio qualora la si studi a partire dal desiderio e dal godimento, una linea di indagine che risulta davvero utile e piena di conseguenze, qualora la si utilizzi per indagare quanto è accaduto con la rivoluzione informatica all’interno del registro immaginario.
Il corpo è il protagonista principale dell’era digitale, perché si annuncia in una profusione di immagini che prima hanno invaso il web, e poi si è imposto come tema in tutte le applicazioni che hanno come caratteristica la possibilità di intervenire con modifiche sempre più radicali nella fisicità dell’utente.
La corporeità è il luogo su cui si intersecano due superfici, cioè reale e virtuale, ed è divenuto lo spazio su cui è lecito sperimentare qualsiasi forma di modifica e di trasformazione. Dal make-up al fitness, dall’abbigliamento alla pubblicità, non c’è veicolo migliore che l’immagine di un corpo, non importa se distorta o meno. Anzi maggiore è la distorsione, migliore è la fascinazione che produrrà nei soggetti. Infatti, da una trasformazione estrema dei corpi scaturisce una tensione/eccitazione imitativa nei soggetti/utenti che comporta uno sforzo che trova appagamento nell’accrescimento o nel decremento della propria fisicità.
La continua e crescente richiesta di modificazione corporea, che proviene dalle immagini digitali, poggia sul meccanismo del godimento che non si arresta mai. La jouissance è una forza ripetitiva, che ha un movimento circolare che si alimenta nell’esposizione sempre più decisa e ammiccante dei corpi propri dei soggetti; in termini di social network, ogni nuova immagine non farà altro che rinnovare tale dinamica, perché le gallerie delle applicazioni sono sempre piene di nuove immagini o video che ritraggono corporeità dedite alle più disparate attività.
In questa prospettiva il dolore è un’accezione del godimento, una forma di piacere di segno negativo, ma che comunque innesca una forma di appagamento, che non comporta assuefazione, se non nel fatto di una ricerca continua.
1.Jacques Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud. 1953-1954, tr. It., Einaudi, Torino 2014, p. 96.
2. Ivi, p. 147.
3. Elle Hunt, Faking it: how selfie dysmorphia is drIving people to seek surgery, The Guardian online, 2019, 17 Febbraio, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/23/faking-it-how-selfie-dysmorphia-is-driving-people-to-seek-surgery, (consultato il 6 luglio 2020).
4. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud. 1953-1954, tr. it., p. 149.
5. ibidem.
6. Slavoj Žižek, L’oggetto sublime dell’Ideologia, tr. it., Adriano Salani Editore, Milano 2014, p. 137.
7. Massimo Recalcati, Le nuove melanconie. Destini del desiderio nel tempo ipermoderno, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, pp. 25-26.
8. Michel Foucault, Raymond Roussel, tr. it., Cappelli Editore, Bologna 1978, p. 113.
9. Slavoj Žižek, L’oggetto sublime dell’Ideologia, p. 137.
10. Jacques Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud. 1953-1954, p. 167.
11. Francois Ansermet, Pierre Magistretti, A ciascuno il suo cervello. Plasticità neurale e inconscio, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 41.
12. Slavoj Žižek, L’oggetto sublime dell’Ideologia, p. 161.
13. Jacques Alain Miller, Delucidazioni su Lacan, tr.it., Antigone Edizioni, Torino 2008, p. 397.
14. Jacques Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio. 1957 – 58, tr. it., Einaudi, Torino 2004, p. 279.
15. Id., Il Seminario. Libro XX. Ancora. 19672 – 73, tr. it., Einaudi, Torino 2011, p. 23.
16. Jacques Alain Miller, Antonio Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, Astrolabio, Roma, 2018, p. 129.
17. ivi. p. 326.
18. Jacques Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora. 19672 – 73, p. 167.
19. Jacques Alain Miller, Antonio Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, p. 51.
20. Jacques Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. 1964, tr. it., Einaudi, Torino 2003, p. 104.
21. Slavoj Žižek, L’oggetto sublime dell’Ideologia, p. 204.
22. Jacques Alain Miller, Delucidazioni su Lacan, p. 397.
23. Jacques Alain Miller, Antonio Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, p. 159.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo