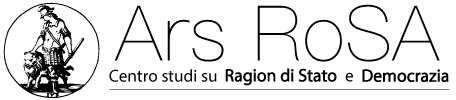Pubblichiamo in traduzione italiana un intervento dello storico Adam Tooze pubblicato lo scorso 17 ottobre su Foreign Policy sulle prospettive globali della lotta al cambiamento climatico che seguiranno le recenti prese di posizione del Presidente cinese Xi Jinping. L’intervento descrive in maniera efficace l’orizzonte politico globale entro il quale potrebbero rafforzarsi gli sforzi di decarbonizzazione, ma anche i rischi che questi nuovi assetti prospettano. Nella versione originale pubblicata su Foreign Policy sono presenti una serie di link di approfondimento che in questa versione non abbiamo conservato.
Adam Tooze è professore di storia e direttore dell’Istituto Europeo della Columbia University. Il suo ultimo libro è Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World, e sta lavorando ad una storia della crisi climatica – Twitter: @adam_tooze
Le grandi potenze hanno fatto grandi passi avanti nella lotta al riscaldamento globale. Ora l’attenzione si rivolge al resto del mondo.
L’impegno unilaterale della Cina a favore della neutralità dal carbonio entro il 2060 ha colto di sorpresa l’Occidente. A dare credito alle parole del presidente Xi Jinping, il Paese che emette più anidride carbonica di Stati Uniti, Europa e Giappone messi insieme sta avviando un programma radicale di de-carbonizzazione. A livello globale, la politica di contrasto al cambiamento climatico acquista una marcia in più.
Senza dubbio ci sono motivi tattici nella scelta dei tempi dell’annuncio di Xi. Ma immaginare che la strategia della Cina sia solo un diversivo propagandistico, o una concessione alla diplomazia occidentale – una contropartita liberale alla dittatura di Xi – è tanto una sopravvalutazione del peso dell’Occidente, quanto del problema climatico. È proprio perché il regime del Partito comunista è deciso a plasmare il prossimo secolo che il suo leader prende sul serio il climate change. Nei calcoli del regime, le inondazioni del fiume Yangtze sono, come i contestatori dei diritti di Hong Kong, una minaccia per la conservazione del proprio potere. Il futuro dell’autoritario China Dream di Pechino appare molto più incerto in un mondo di in cui il riscaldamento globale è fuori controllo.
La mossa di Xi potrebbe stravolgere i preconcetti occidentali, ma è apparso evidente fin dall’inizio di questo secolo che la Cina avrebbe avuto giocato un ruolo decisivo nel futuro del clima globale. Un quarto di secolo prima del previsto superamento degli Stati Uniti in termini di PIL, la Cina lo ha superato in termini di emissioni di carbonio. La Cina domina tutte le industrie fortemente inquinanti del mondo: carbone, acciaio, alluminio, cemento. E questo una volta si poteva dire della produzione occidentale. Oggi la Cina consuma la maggior parte della sua produzione industriale pesante in patria. Con il suo impegno di decarbonizzazione, che eclissa ogni plausibile mossa futura che l’UE o gli Stati Uniti potrebbero fare, Xi ha semplicemente chiarito dove è il vero luogo della decisione.

In effetti, individuare la strategia della Cina prima di tutto in relazione alle relazioni Est-Ovest è di per sé una prospettiva che guarda al passato, e sempre più anacronistica. Con il passare degli anni l’importanza dell’UE e degli Stati Uniti nell’equazione che descrive il cambiamento climatico diminuisce. Nel 2018, gli Stati Uniti e l’Europa rappresentavano insieme 8.9 gigatoni di emissioni di carbonio, non più di un quarto del totale globale. La Cina da sola ha superato questo dato con emissioni totali, su base produttiva, di 10.1 gigatoni. Se si sommano tutti e tre questi attori – Cina, Stati Uniti e UE – si ottiene poco più della metà del totale globale. Il resto, 17.9 gigatoni, il doppio della produzione degli Stati Uniti e dell’UE, è rappresentato dall’India e dal resto del mondo. Inoltre, mentre le emissioni dei “tre grandi” sono in stagnazione – il calo negli Stati Uniti e nell’UE compensa l’eventuale aumento in Cina – la tendenza nel resto del mondo è fortemente al rialzo. Sempre più paesi entrano in una fase di crescita ad alta intensità energetica e a medio reddito, e mentre questi si urbanizzano – costruendo centrali elettriche e con i loro cittadini più abbienti che acquistano auto e condizionatori d’aria – le emissioni complessive di CO2 aumentano. Questo è il risultato ambientale dell’ascesa della classe media globale. Di conseguenza, siamo già ben oltre il punto in cui una stabilizzazione climatica globale può essere raggiunta con un accordo tra i G3. Ciò di cui sia la politica climatica occidentale, che quella cinese ha bisogno è un patto che coinvolga non solo l’India, ma anche altre grandi economie di mercato emergenti come il Brasile e l’Indonesia, i futuri giganti della popolazione come il Pakistan e la Nigeria e i grandi produttori di carbone, petrolio e gas, come l’Australia, il Canada, la Russia e gli Stati del Golfo. Questi dibattiti sono in corso da anni nei colloqui sul clima globale. Ma l’annuncio della Cina cambia le regole del gioco per tutti i giocatori.

Le narrazioni statunitensi sulla politica climatica tendono a concentrarsi sull’accordo globale di Parigi del 2015, la prima occasione in cui praticamente tutti i paesi della terra hanno accettato di prendere provvedimenti per affrontare il riscaldamento globale. Ma Parigi è stata ingannevole. Ha fissato un obiettivo di innalzamento massimo di temperatura di 2 gradi, e l’aspirazione a raggiungere non più di 1,5, lasciando ad ogni nazione il compito di fare quanto nelle loro possibilità. Ha così “disinnescato”, ignorandola, la questione esplosiva di una più giusta allocazione di ciò che restava delle quote di emissione di carbonio. Il risultato è stato un pacchetto di impegni che i modelli hanno rivelato essere del tutto inadeguato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del riscaldamento.
Le emissioni globali hanno continuato ad aumentare. Il mix energetico complessivo non si è quasi mai spostato. La crescita economica ha annullato ogni guadagno in termini di efficienza energetica. Il ritiro di Trump da Parigi ha peggiorato una situazione già disastrosa, aprendo la porta a scivolamenti da parte di brasiliani, australiani, russi e sauditi. È stata questa situazione profondamente allarmante a innescare la mobilitazione politica di base per l’azione a favore del clima che è stata una caratteristica così notevole degli ultimi anni. All’inizio dell’anno, la questione era se l’uscita dell’America da Parigi sarebbe stata compensata da nuovi impegni da parte dell’UE e della Cina. L’annuncio di Xi è allora andato oltre le aspettative.
Nel 2015, il rifiuto della Cina di impegnarsi in un percorso chiaro di riduzione delle emissioni ha segnato il pasticcio parigino. Con la fetta più grande del futuro che rifiutava di impegnarsi, non era in alcun modo possibile stabilire l’equazione da risolvere. Ora, Pechino ha chiarito la propria posizione. Ha abbandonato una volta per tutte la linea che separava le economie emergenti dalle economie avanzate assunta nei precedenti colloqui sul clima. Questo renderà più difficile per l’Europa sottrarsi agli impegni e metterà sotto pressione sia l’India che gli Stati Uniti. Ma segna anche il termine della strategia di contrattazione delle superpotenze che ha posto le basi per Parigi. Ora dobbiamo finalmente fare i conti con la multipolarità.
Quando è iniziata la politica climatica così come la conosciamo, il mondo era un posto diverso. Negli anni Ottanta, gli scienziati europei e americani parlavano del clima come di un problema globale, ma era un globo immaginato e analizzato dal punto di vista dell’Occidente. Le economie di Cina e India rappresentavano pochi punti percentuali del PIL globale. L’Occidente e l’Unione Sovietica dominavano il bilancio delle emissioni.

Poi, negli anni Novanta, un tema che era stato di appannaggio di una élite di scienziati occidentali è esploso nella dura politica dei moderni negoziati sul clima globale. L’incontro annuale dei 197 paesi che hanno aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – le cosiddette Conferenze delle Parti (COP) – sono incontri in stile assemblea generale delle Nazioni Unite e sono tanto ingombranti e complessi quanto questo confronto lascia pensare. Come esemplificato dal protocollo di Kyoto del 1997, il conflitto fondamentale era quello tra i grandi mercati emergenti guidati da Cina e India, che insistevano sul fatto che il problema del clima doveva essere risolto dalle economie industrializzate, e gli Stati Uniti, che si rifiutavano di firmare qualsiasi accordo che non includesse anche la Cina. Vi è questo alla radice dell’opposizione degli Stati Uniti al protocollo di Kyoto. Naturalmente, c’è stata anche la posizione antiscientifica che alcuni nei GOP hanno adottato. C’erano gli interessi dei combustibili fossili guidati da Exxon che sponsorizzavano posizioni negazioniste. Ma, alla fine, l’obiezione al Protocollo di Kyoto, condivisa praticamente all’unanimità da entrambe le parti del Congresso, era di natura geo-economica. Qualunque fosse la storia delle emissioni, la Cina era la futura superpotenza climatica e gli Stati Uniti non avrebbero ratificato un accordo che non la vincolasse.
È stata l’interpretazione del problema in termini di giustizia climatica da parte della Cina e dell’India, e di geo-economia da parte degli Stati Uniti, che ha richiesto in fine un accordo tra superpotenze. All’inizio sono stati gli europei a portare al tavolo dei negoziati l’India e la Cina assumendo un impegno unilaterale a favore di una seconda tornata di tagli come stabiliti negli accordi di Kyoto. Poi, l’amministrazione Obama ha negoziato accordi bilaterali con la Cina e l’India. Sono stati questi accordi tra superpotenze a porre le basi per l’assemblea generale che si è tenuta a Parigi nel dicembre 2015.
La Cina ha in sostanza rilanciato rispetto al quadro di Parigi. Per la prima volta dall’inizio dei negoziati sul clima all’inizio degli anni Novanta, il più grande inquinatore si è impegnato a decarbonizzare. Ma per quanto ciò sia importante, da solo questo passo non sarà sufficiente. Ciò di cui Pechino e chiunque altro si preoccupi della stabilizzazione del clima hanno bisogno ora non è solo un impegno parallelo da parte degli Stati Uniti, ma di impegni vincolanti da parte del resto del mondo. E per questo, è necessario un quadro adeguato.
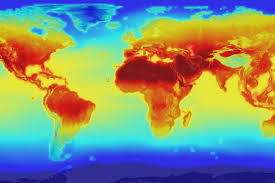
Quando si tratta di governare la decarbonizzazione, il gruppo di paesi che hanno un impatto significativo è infatti ampio ed eterogeneo. Esso comprende sia i grandi consumatori di energia che i grandi produttori di energia. La decarbonizzazione può offrire un beneficio lordo complessivo, ma i compromessi distributivi sono dolorosi. E alcuni Stati possono ritrovarsi perdenti netti. Nessun altro mercato emergente ha le risorse della Cina per compensare i costi settoriali della transizione energetica. Nessun altro Stato, ricco o povero, può eguagliare la capacità autoritaria del regime cinese di reprimere il dissenso tra i perdenti interni di questa transizione. I produttori di energia a medio reddito cercano disperatamente di mantenere le loro esportazioni di petrolio e gas. Molte economie a medio e basso reddito saranno influenzabili da offerte di energia a basso costo e senza alcun vincolo. In tutto il mondo, i sussidi per l’energia, che si aggirano sulle centinaia di miliardi di dollari all’anno, continuano ad essere una parte importante della negoziazione sociale, soprattutto per quanti aspirano alla classe-media. In tutto il mondo, centinaia di milioni di persone non hanno ancora accesso all’elettricità. Se è difficile per i paesi ricchi immaginare una transizione, è ancora più difficile per quelli che si trovano ancora nelle prime fasi dell’industrializzazione.
Ci sono diverse centinaia di grandi e redditizie aziende il cui intero modello di business sarà modificato da una rapida e profonda decarbonizzazione. Le major petrolifere occidentali come la Exxon sono in cima a quella lista. Ma delle dieci società che negli ultimi cinque anni hanno aumentato in modo drammatico le loro emissioni di CO2, quattro erano indiane, due cinesi, le altre australiane, russe e coreane. La svizzera LafargeHolcim, tra i principali produttori di cemento al mondo, è arrivata al secondo posto. L’energia è un business per i capitalisti di Stato. Dodici delle prime 20 aziende che emettono CO2 sono di proprietà dello Stato. Le società petrolifere nazionali di Iran, Iraq, Messico, Algeria e Venezuela non sono solo imprese. Sono pilastri delle loro economie nazionali e delle finanze statali.
Una preoccupazione è che si sviluppino coalizioni recalcitranti; ossia i cui progetti per l’autonomia energetica e lo sviluppo economico ostacolano la spinta generale alla decarbonizzazione. Anche all’interno dell’UE, la Polonia, con la sua forte dipendenza dal carbone, si è rifiutata di aderire all’impegno altrimenti unanime di raggiungere lo zero netto entro il 2050. Nel luglio di quest’anno, ha usato il suo potere contrattuale per minare i requisiti di riduzione del carbonio nel Recovery Fund europeo. Se Ripetuta su scala globale, questa è una prospettiva preoccupante. Ne è un esempio la lotta sempre più frenetica per il controllo sui giacimenti di gas del Mediterraneo orientale. La Turchia ha una domanda di energia in rapida crescita. Vuole nuove fonti di gas per alleviare la sua allarmante dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia.
Se le assemblee globali sono ingestibili, e gli accordi tra le superpotenze sono troppo limitati, ciò che serve è un raggruppamento più gestibile all’interno del quale sostenere la decarbonizzazione. Il G20 è un quadro di riferimento ovvio. La sua storia corre in parallelo con quella della politica climatica e riflette la stessa lotta per trovare un quadro appropriato all’interno del quale coordinare e legittimare la governance in un mondo multipolare del XXI secolo.
Le origini del G20 affondano nella controversia causata dalla crisi del debito in America Latina e dalla crisi finanziaria asiatica degli anni Novanta. A partire dalla sua fondazione a Bretton Woods nel 1944, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) che ha guidato gli sforzi per combattere la crisi è stato dominato dai suoi azionisti americani ed europei. Nel dopo-guerra fredda, nel mondo postcoloniale, i suoi metodi troppo duri sono stati visti sempre più come un’intrusione inaccettabile nelle sovranità degli Stati. Nel 1999 il G20 è stato nuovamente riproposto per dare alla gestione dell’economia mondiale una base politica più ampia. La storia narra che l’allora Segretario del Tesoro statunitense Larry Summers incaricò il suo vice, Timothy Geithner, insieme al suo omologo tedesco, Caio Koch-Weser, di compilare una lista di Stati candidati. Elaborando una tabella in cui erano messe in rapporto la popolazione e il PIL, hanno inserito la Francia e il Sudafrica, lasciando fuori Nigeria e la Spagna. Il risultato è stato un raggruppamento dominato dal G-8 e dai cosiddetti BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), con l’aggiunta di nuovi arrivati al primo posto come Arabia Saudita, Indonesia, Argentina, Messico e Turchia.
In origine era una riunione dei ministri delle finanze. Quando la crisi bancaria è scoppiata nell’Atlantico settentrionale nel 2008, il G20 è stato promosso in un forum per i capi di governo. Naturalmente, tali raggruppamenti selettivi hanno i loro problemi di legittimità. Il G20 è stato denunciato come un ritorno al “concerto tra potenze” del XIX secolo. Ma era proprio questo il punto. La nozione di sovranità, che tratta gli Stati con popolazioni che si contano in migliaia come eguali a Cina o India può soddisfare i giuristi internazionali, ma svanisce di fronte alle differenze reali di capacità e di potere. Il motivo per cui il G20 potrebbe non essere adatto alla prossima fase della politica climatica non è che esclude i piccoli Paesi, ma che non include i grandi giusti. Nel fare politica climatica, la Russia, l’Arabia Saudita, il Brasile, l’Indonesia, la Corea del Sud e la Turchia sono tutti cruciali. Ma come si possono escludere grandi Stati come il Bangladesh, il Pakistan, l’Etiopia, l’Egitto, la Nigeria e l’Iran? Un forum adatto a una negoziazione difficile che affronti l’imminente catastrofe climatica deve essere un G40 piuttosto che un G20.

Ma, immaginare un forum è un primo passo, la domanda seguente è: quali forze potrebbero effettivamente costringere all’accordo? Se la Cina e l’UE stanno guidando la spinta alla decarbonizzazione, che influenza potrebbero avere nell’accelerare il processo? Se la storia ci dice qualcosa, è che le grandi potenze lontane possono avere solo un’influenza limitata. L’impero informale non è così facile come sembra. L’influenza reale dipende dall’allineamento con gli interessi dei potenti attori locali e ha il prezzo di investimenti pesanti e di rischi considerevoli. Questo è esattamente ciò che la Cina ha intrapreso con l’iniziativa tentacolare One Belt One Road. Dall’anno scorso, 126 Paesi sono stati coinvolti nella Belt and Road Initiative. All’epoca, questi paesi rappresentavano i due terzi della popolazione mondiale, il 23 per cento del PIL mondiale e circa il 28 per cento delle emissioni globali di carbonio. Essi sono anche la sede del 75 per cento delle riserve mondiali di combustibili fossili. Se continuano sulla strada della crescita ad alta intensità di carbonio modellata dalla Cina mentre il resto del mondo procede alla decarbonizzazione, il risultato entro il 2050 sarà che i clienti cinesi di One Belt One Road finiranno per essere responsabili del 66% delle emissioni globali. I fumi rilasciati dalle loro centrali elettriche sarebbero di per sé sufficienti a gettare il mondo in uno scenario da 3 gradi di riscaldamento.
Pechino ha promesso in passato di “rinverdire” la One Belt One Road. Ma nel suo storico discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Xi non ha fatto alcun riferimento ai progetti esteri della Cina. Sarà cruciale verificare se l’impegno di Pechino per la neutralità del carbonio si applica anche alla One Belt One Road. Ciò potrebbe incontrare l’opposizione della pesante lobby industriale cinese, ma Pechino ha una leva enorme nelle sue banche di sviluppo. La China Development Bank, da sola, dovrebbe prestare 40-45 miliardi di dollari all’anno ai progetti BRI.

Una One Belt One Road verde sarebbe una proposta ancora più impressionante della versione originale a base di carbone. Allineare tutti i 126 membri del progetto ad uno scenario a 2 gradi, consentendo loro di raggiungere lo sviluppo economico e industriale, richiederebbe, secondo una serie di stime, un investimento di 11,8 trilioni di dollari entro il 2030. Questa cifra è gigantesca, ma dopo lo shock COVID forse non è più del tutto inimmaginabile. Si stima che la risposta fiscale globale cumulativa alla pandemia di quest’anno sia stata di 7 trilioni di dollari.
Ma mentre la Cina è abituata ad impegnare finanziamenti esteri sulla scala dei trilioni di dollari, per l’Occidente questi numeri indurranno probabilmente uno shock. Quando la Germania, qualche anno fa, ha avanzato l’idea di un Piano Marshall per l’Africa, ha subito concluso che i 600 miliardi di dollari all’anno necessari per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU non potevano provenire da fondi pubblici. Piuttosto che da interventi “sul campo” nelle infrastrutture locali, Berlino sperava ardentemente che le risorse proprie degli Stati africani e il capitale privato potessero servire allo scopo.
Se ciò è davvero quanto di meglio l’Occidente può fare, la questione è come incentivare gli investimenti necessari. Le normative, come il divieto di importazione di auto con motore a combustione interna, sono essenziali. Altrettanto importante sarebbe un prezzo uniforme del carbonio a livello globale per fissare un tetto per il commercio globale. E ciò può partire solo con sistemi regionali di fissazione del prezzo del carbonio che devono però andare oltre, verso tasse di frontiera sul carbonio. Questa tassazione è cruciale non solo come misura nazionale, ma anche per contenere le strategie delle multinazionali che altrimenti esternalizzeranno la produzione ad alta intensità di carbonio nei mercati emergenti.
Quest’estate l’UE ha messo sul piatto la minaccia di tasse sul carbonio nei suoi negoziati con la Cina. Questo potrebbe aver spinto Xi a fare il suo annuncio. In base alle dimensioni del suo mercato, l’UE è una superpotenza normativa, ed anche gli Stati Uniti potrebbero esserlo. Tuttavia, sempre più spesso l’asse più dinamico del commercio globale non è con l’Occidente, ma tra i grandi mercati emergenti in rapida crescita. E la Cina sta sviluppando un meccanismo per fissare il prezzo del carbonio. In quanto gigantesco mercato per le importazioni dai mercati emergenti a basso costo, la Cina potrebbe voler implementare un sistema di tasse di frontiera sul carbonio. Se venissero adottate dall’UE, dagli Stati Uniti e dalla Cina, le tasse sul carbonio eserciterebbero un’enorme pressione sulle scelte energetiche in tutto il mondo. L’esportazione di paesi che utilizzano l’energia solare ed eolica, piuttosto che il carbone, il petrolio e il gas, sarebbe un enorme vantaggio; il denaro sicuramente ne seguirebbe.
Uno sguardo che si limiti ai prezzi e ai margini di profitto a breve termine potrebbe sottovalutare le forze che sono all’opera. Ci sono segnali che, come il regime comunista di Pechino, anche in Occidente il “big money” comincia ad assumere una visione strategica. Nella settimana precedente il discorso di Xi all’ONU, Climate Action 100 Plus, un gruppo di lobby i cui membri rappresentano investitori globali con un patrimonio collettivo di 47 mila miliardi di dollari, ha annunciato che giudicherà 161 delle più grandi aziende, collettivamente responsabili fino all’80 per cento dei gas serra industriali globali, in base ai loro progressi verso le emissioni di carbonio a zero.
Come nel discorso di Xi, anche in questa dichiarazione c’è stato senza dubbio un elemento di greenwashing. Ma può anche essere letto come un riconoscimento da parte di giganteschi asset manager come BlackRock e Pimco che la stabilità dell’accumulo di capitale dipende a lungo termine dal mantenimento di un quadro ambientale stabile. Per il capitale occidentale come per i regimi di Xi, questi rischi sono politici oltre che naturali. In caso di future crisi climatiche, le aziende che potrebbero essere viste come tra quelle che in maniera spericolata pregiudicano la stabilità del clima potrebbero rischiare di perdere in un colpo le loro autorizzazioni ad operare. L’esperienza delle compagnie aeree nel 2020 ha dimostrato come la risposta della società a una futura crisi ambientale può improvvisamente mettere a repentaglio un intero settore.
Si è quindi tentati di sperare che con gli impegni climatici della Cina e dell’UE il mondo abbia raggiunto una massa critica. Il cambiamento tecnologico, la leadership normativa, gli incentivi ai prezzi e la pressione degli investitori guideranno la decarbonizzazione. Ma contare solo su queste forze è un’ingenuità.
I sistemi di combustibili fossili che caratterizzano la nostra vita non sono ancorati solo alla tecnologia e al profitto. La decarbonizzazione, come è stato in origine per la costruzione dell’economia dei combustibili fossili, comporterà questioni di potere internazionale e di geopolitica. C’è chi si aggrappa al sogno degli anni Settanta che le energie rinnovabili possano condurci verso una nuova era politica fatta di energia “soft” e decentralizzata. Ma anche se questa improbabile visione rimane un obiettivo, per raggiungerlo è necessario un atto di potere: lo smantellamento dei bastioni dell’energia fossile. Questi, da soli, non si arrenderanno. Per contro, come ha recentemente sottolineato Jason Bordoff, la geopolitica della decarbonizzazione sarà complessa e non lineare. Ed è qui che entrano in gioco gli Stati Uniti.

La Cina e l’Ue stanno fissando l’agenda della decarbonizzazione. Ma nessuna delle due ha la portata geopolitica degli Stati Uniti. Una spinta politica progressista da parte degli US renderebbe più facile sostenere la decarbonizzazione in India, America Latina, Canada e Giappone. Un cambiamento di posizione negli Stati Uniti ribalterebbe anche il carrozzone degli scettici trumpiani, al quale i governi conservatori di Australia e Brasile si sono felicemente uniti. Questo è un settore in cui gubernare discòsto (leading from behind) potrebbe non essere un ossimoro.
Gli Stati Uniti esercitano un ruolo unico per quanto attiene la produzione dei combustibili fossili. Gli USA sono stati l’architetto e l’áncora dell’ordine dei combustibili fossili del XX secolo. Quando i progressisti americani sostenendo con passione il Green New Deal evocando le conquiste dell’ “arsenale della democrazia” nella seconda guerra mondiale, non dovrebbero dimenticare che quelli furono i trionfi di un industrialismo alimentato dal petrolio e dal carbone. Fu a metà secolo, nel periodo di massimo splendore dell’attivismo statale e della creativa statecraft statunitense, che l’impero petrolifero nel Medio Oriente – questo nesso tra le società petrolifere, l’apparato di sicurezza nazionale americano e i regimi locali – fu forgiato. Le alleanze americane nella Guerra Fredda, sia in Europa occidentale che in Asia orientale, sono state costruite sulla piattaforma energetica mediorientale.
La crisi del 1973 mise in discussione quel sistema. Negli anni Settanta, il governo degli Stati Uniti divenne il primo sponsor delle ricerche sui cambiamenti climatici e sulle energie rinnovabili. Ma, alla fine, come ci ha mostrato Victor McFarland con il suo recente studio Oil Powers (Columbia U.P., 2020), gli Stati Uniti optarono per l’alleanza con l’Arabia Saudita e per la Dottrina Carter, che rendeva esplicito l’impegno dell’America a difendere le forniture di petrolio dell’Occidente. Queste scelte hanno posto le basi per decenni di un impegno sempre più profondo e militarizzato in Medio Oriente.
Stanchi delle guerre rovinosamente costose in Iraq e in Afghanistan, l’applicazione commerciale su larga scala del fracking sembrava offrire agli Stati Uniti una carta vincente sia nella politica climatica che nella più complessiva strategia. Ma il nuovo vanto dell’indipendenza energetica sotto Obama si è trasformato rapidamente in una pretesa di dominio energetico con Trump. Invece di uscire dal gioco dell’energia fossile, gli Stati Uniti sono stati risucchiati in una nuova partita. In alternativa al gas russo, gli Stati Uniti si sono posizionati come fornitore di gas naturale (GNL), definito dall’amministrazione Trump come “molecole di libertà”. Come ha dimostrato la recente guerra dei prezzi del petrolio, il risultato dell’eccessiva espansione del settore del fracking non è stato il dominio da parte degli Stati Uniti, ma la ragione delle nuove vulnerabilità della stessa economia statunitense.
Se questo è il momento in cui gli Stati Uniti devono effettivamente allontanarsi dai combustibili fossili, ciò non deve comportare solo un nuovo ordine energetico in patria. Gli Stati Uniti devono lavorare con la Cina e l’UE per contribuire a stabilire un quadro globale che mantenga interrate la gran parte delle riserve di combustibili fossili conosciute.
Naturalmente, la geopolitica dell’uscita dai combustibili fossili non è un problema solo americano. Nell’ultima metà del secolo l’Europa ha costruito il suo rapporto prima con l’Unione Sovietica, e poi con la Russia, su una politica di importazione di energia. (Il gasdotto Nordstream 2 è la progenie di quella storia). Il Giappone e ora la Cina sono oggi i principali clienti degli Stati del Golfo. I principali Stati dell’OPEC dispongono di notevoli riserve e difendono con vigore la loro autonomia. Nel Golfo, i costi di produzione sono così bassi che Stati come l’Arabia Saudita e il Qatar possono tranquillamente aspettarsi di essere tra gli ultimi fornitori di combustibili fossili al mondo. I fragili produttori ad alto costo, come la Nigeria o il Venezuela, per esempio, avvertiranno per primi i colpi. Ma alla fine, l’equilibrio tra domanda e offerta si sposterà e, se il prezzo minimo del carbonio funzionerà, le guerre dei prezzi non permetteranno alcuna via di scampo. Tra il 2040 e il 2060, il secolo dell’economia globale alimentata dal petrolio finirà.
Sarà una trasformazione rivoluzionaria, e gli Stati Uniti dovranno calibrare attentamente il loro intervento. Ci sono naturalmente molte ragioni per accogliere con favore l’indebolimento sia della Russia che dell’Arabia Saudita. Le prospettive di un cambiamento di regime saranno allettanti. Ma dovremmo essere chiari sui rischi. Il semplice fatto di prospettare ai produttori di combustibili fossili un fait accompli, senza via d’uscita, favorirà le resistenze e incoraggerà gli attori in difficoltà a fare azzardi pericolosi per la salvezza. Un approccio così conflittuale può apparire attraente per coloro che vogliono non tanto un New Green Deal quanto una Rivoluzione verde.

Ma se l’orizzonte temporale è così pressante come suggerisce la scienza, allora la priorità assoluta è la decarbonizzazione. A tal fine dobbiamo definire quei percorsi e quegli strumenti per convertire e far convergere gli assetti esistenti verso un nuovo mondo a basse emissioni di carbonio. La priorità è generalizzare l’interesse per un progetto di stabilizzazione del clima. E questo, almeno, è qualcosa che ora l’Occidente ha in comune con Pechino.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo