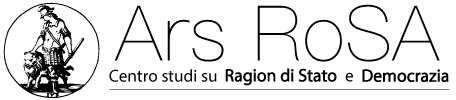di Federico Simonetti. Nelle settimane tra ottobre e novembre si sono susseguiti una serie di nuovi provvedimenti che hanno modificato in maniera sostanziale il rapporto tra i cittadini e il proprio tempo, confinandoli solo parzialmente all’interno dello spazio domestico. Il 3 novembre del 2020, dopo ormai più di nove mesi di emergenza, un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto a sancire, per lo meno implicitamente, la possibilità di un nuovo lockdown localizzato che minaccia di riportare l’Italia alla situazione di marzo e aprile. Scrivo “minaccia” perché in realtà ci sono delle differenze sostanziali tra le due situazioni profilate all’interno dei DPCM e che, strutturalmente, sembrano segnare ancora di più le tracce per una espropriazione del tempo operata a colpi di dispositivi emergenziali, favorita dall’accesso al lavoro da remoto consentito dai dispositivi digitali.
Durante il primo lockdown ci siamo trovati tutti, più o meno d’improvviso, a vivere uno stato di eccezione straordinaria. Cioè uno stato di eccezione ancor più eccezionale di quanto non sia normale lo stato di eccezione permanente che rappresenta, per varie ragioni e a vario titolo, la nostra quotidianità.
Il mio amico Alberto Guidetti, tra le anime della band “Lo Stato Sociale” e della rivista Fantastico!, musicista e autore ben più saggio di me, ha usato il termine “attesocene” per indicare quello stato di attesa indefinita, nel quale si alternavano velocità molto diverse, sincronismi e diacronismi che spingevano il tempo in direzioni e a velocità molto diverse, che avevano come comune denominatore la nostra proprietà sul tempo.
Nelle conversazioni professionali e personali svolte nelle lunghe settimane tra marzo e aprile, ho notato alcuni comportamenti e “tipi umani” che si ripetevano, applicandosi a persone e situazioni tra loro diverse. È per questo che a un certo punto ho sentito la necessità di elaborare una matrice con la quale catalogare il modo di usare il tempo delle persone con le quali mi interfacciavo (almeno virtualmente). Mi è parso di poter dire che la stragrande maggioranza delle persone, almeno in quella fase, si potesse dividere in tre macrogruppi:
· gli annoiati hanno passato buona parte della pandemia cercando di trovare alternative alla socialità, trovando anche alcuni momentanei surrogati del contatto umano, surrogati che però non sono riusciti a radicarsi o a trovare una continuità sufficiente a occupare un tempo per sua natura eccedente perché espropriato;
· gli indaffarati sono rimasti in qualche modo incatenati a una forma di continuità produttiva (retribuita o meno), ma avendo molto più tempo a disposizione sono sostanzialmente passati da un’occupazione full time a una full contact, rinunciando a qualsivoglia forma di intermittenza;
· i disperati hanno dovuto rinunciare al fatto di essere proprietari del proprio tempo, per ragioni anche molto diverse (accudire la famiglia, non avere più continuità di reddito, essere vittime di violenza domestica o di ricatti lavorativi, etc.): si tratta di vite fortemente precarie e sull’orlo della disperazione già prima dell’attesocene.
In un ideale quadrato semiotico, nel quale ponessimo sull’asse delle X la proprietà sul proprio tempo e su quello delle Y le cose da fare, noteremmo che c’è una drammatica assenza: lo spazio di chi ha piena proprietà del proprio tempo e poche (o nessuna) cose da fare, riuscendo a dare una torsione positiva alla situazione di attesa. Si tratta dello spazio dell’ozio che sembra essere completamente scomparso dalla nostra abitudine sociale, uno spazio dove l’isolamento può attivare una forma di diletto virtuoso nell’uso creativo del tempo.
Si tratta chiaramente di una situazione di privilegio (ideale, spirituale e materiale) che mi sembrava sparita già prima dell’attesocene, se non per pochissimi privilegiati. L’introduzione del primo lockdown sembrava aver costretto i più a rifare i conti con il tempo e, in parte, a riprenderne possesso: l’attesocene è stato infatti caratterizzato da un fermo generalizzato di tutte le attività, anche di quelle produttive non strettamente essenziali, con la promessa di un seppur parziale rimborso economico. Le persone si sono quindi trovate senza cose da dover fare, con tanto tempo “vuoto” a disposizione, ma almeno ancorate alla speranza di un aiuto economico che risolvesse le ristrettezze immediate.
In seguito agli ultimi provvedimenti emergenziali, viceversa, dall’istituzione del “coprifuoco” in avanti, è sparita anche questa relativa speranza, col risultato che lo spazio dell’ozio è tornato a obliarsi, forse definitivamente.
Il filosofo francese Bernard Stiegler, recentemente scomparso, segnala da circa trent’anni la progressiva sparizione dell’otium dalle vite della nostra civiltà1: nelle epoche passate il ruolo dell’ozio era quello di distinguere, tutelare e separare il sé dalle preoccupazioni ordinarie e quotidiane del negotium. Nella nostra contemporaneità, invece, tutte le pratiche che hanno a che fare con il sé sembrano essersi progressivamente sottoposte a qualche forma di negotium e concentrate a garantire la sussistenza. Anche il diletto e il divertimento, infatti, sono sempre più considerati come forma di soddisfazione momentanea di un interesse personale, insomma come “qualcosa da fare”. Stiegler, infatti, definisce il negotium come commercio umano incentrato su “l’imperativo della sussistenza” nella misura in cui addirittura “rendere inaccessibile la dignità dell’esistenza”.
Stiegler (tra molti altri) sostiene che le democrazie industriali e in generale la logica del calcolo, tipica dell’età moderna, abbiano reso sempre più difficile stabilire una forma di vita modellata su logiche diverse da quelle del mercato e sulle pratiche di consumo. L’otium è stato incorporato nell’industria culturale la quale incorpora le pratiche del sé e le confeziona in beni, servizi o relazioni di consumo, impacchettando e vendendo prodotti basati sui nostri gusti ed elaborati a partire dall’osservazione e l’accumulo di dati sui nostri comportamenti.
Va detto che il dominio del negotium non distrugge completamente l’otium, ma lo rende indistinguibile dalla sua controparte: l’otium non modella più un’esistenza separata dalla sussistenza, ma esistenza e sussistenza sono confuse. Potremmo dire, a un certo punto, che l’esistenza è sottoposta alla mera lotta per la sopravvivenza.
Ma cosa è cambiato ancora nelle settimane tra ottobre e novembre del 2020? Cosa è cambiato attorno a noi con l’istituzione del “coprifuoco” e la chiusura di alcune attività e non di altre? Se proviamo a osservare quali esercizi sono stati chiusi e in che modalità, ci accorgiamo che a essere colpita non è la socialità in sé, ma un certo tipo di socialità che è definita “non essenziale”.
Sono stati infatti chiusi del tutto, senza neanche avere possibilità di effettuare orari diurni, tutti i circoli sportivi e le palestre – al netto del fatto che lo sport non è di per sé un’attività ludica, ma può essere (ed è per molti) una vera e propria pratica di sé e di riappropriazione del proprio tempo.
Sono stati chiusi del tutto anche i circoli culturali e ricreativi, malgrado in molti casi conservino una struttura paragonabile a bar e ristoranti: quasi come se a essere definito come “non essenziale” sia il tempo che uno si prende per sé.
Non è un caso che a rimanere aperti siano i negotii tradizionali, di ogni ordine e specie, sostanzialmente tutti i luoghi di lavoro e anche le scuole: si tratta di luoghi nei quali non c’è “tempo da perdere” e quindi non è possibile prenderselo per sé, questo tempo. In questo senso, pare coerente anche la decisione di chiudere i centri commerciali di sabato e domenica, ormai luoghi neo-tradizionali del “passeggio” più o meno orientato al consumo.
Ancora più drammaticamente, nel primo lockdown permaneva una situazione di relativa speranza grazie alla promessa di estesi ammortizzatori sociali, specie per le classi di soggetti più esposte alla crisi economica. Ciò rendeva il tempo più vivibile e, in qualche modo, rendeva possibile viverlo con piena proprietà. In questa seconda fase, invece, l’assenza di simili misure generalizzate – e anche solo di una loro promessa – obbliga quegli stessi soggetti non tanto all’inazione, quanto all’inutilità. Li condanna, cioè, a un processo di colpevolizzazione per non essere “essenziali”, a un lavoro ridotto, nell’orario e negli introiti, a una sorta di coazione a ripetere che non garantisce neanche la sussistenza. In questo contesto, tanto il tempo di lavoro (che non produce sufficiente reddito) quanto il tempo “libero” (che produce noia o angoscia) non è un tempo di cui è possibile riappropriarsi, ma a tutti gli effetti un tempo perso.
Questa situazione mi pare non essersi modificata in maniera radicale neanche a seguito delle nuove e più stringenti misure che hanno diviso l’Italia in differenti “zone di rischio” (gialla, arancione, rossa): pur con notevoli restrizioni, infatti, all’interno delle nuove “zone rosse” non è presente né un divieto totale di uscire di casa, né una restrizione completa e capillare dei tipi di attività lavorativa che è possibile svolgere. Nel primo lockdown, l’accesso alla mobilità era regolato da una minuziosa partizione delle attività attraverso i codici ATECO che, allo stato attuale, è molto più generica e affidata al “buon senso individuale”, col risultato che moltissime attività che potrebbero approfittare del lavoro da remoto, di fatto, non lo fanno.
È chiaro che, tra la miriade di scelte possibili per fronteggiare una pandemia che ci mette di fronte a scelte drammatiche, come società ma anche come civiltà, evitare la tragedia è un imperativo sul quale difficilmente si può transigere. Eppure, la scelta di lasciare aperto tutto il resto, ma di escludere da questo resto “il tempo che ci resta”, rischia di confinarci tutti, specie gli indaffarati e i disperati, in un limbo fatto unicamente di negotium e di noia.
L’imperativo finale di questa fase, seppur cangiante e ballerina, sembra essere il grido “non ci possiamo permettere un nuovo lockdown”: pertanto è mandatorio rinunciare al tempo “libero” (seppur non “liberato”), al contatto, alla sussistenza di chi di quel tempo viveva. Ma siccome “non ci possiamo permettere un nuovo lockdown” è altrettanto mandatorio aumentare i ritmi di lavoro (specie per chi lavora da casa), ridurre le attività di acquisto a mere transazioni fugaci o meglio ancora elettroniche, funzionalizzare e grammatizzare ogni atto e ogni spostamento.
Se il primo lockdown aveva dato, perlomeno ad alcuni, il lusso di “avere tempo da perdere”, questa nuova configurazione – che si spera transitoria – sembra legare i soggetti alla prosecuzione del negotium senza pause, a una cessione completa del nostro tempo alle maglie della produzione, della noia o della disperazione. Se è vero che “non ce lo possiamo permettere” viene spontaneo chiedersi: che cos’è, allora, che ci possiamo permettere?
1 Cfr. Bernard Stiegler, Pour une nouvelle critique de l’économie politique, Paris 2009, Galilee
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo