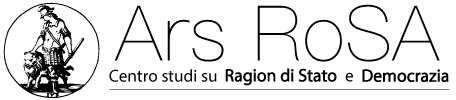di Franco Maria Di Sciullo (Univ. di Messina).
Che la storia sia maestra di vita o che, al contrario, l’esperienza dimostri che essa non ha mai insegnato niente ai popoli né a chi li governa, resta il fatto che l’appello esclusivo al giudizio della storia è destinato, in politica, a suscitare serie perplessità. Come mai il capo di un governo in carica, nel presentare un programma di interventi e misure al Parlamento e all’opinione pubblica di un paese a democrazia matura, sente di dover dichiarare e precisare che sarà «la storia», «domani»,a dare un giudizio sulle scelte e le azioni del governo (specificando, nel caso non fosse abbastanza chiaro, che tale giudizio è del resto irrilevante per il presente)? Di quale «storia» parla? Si tratta solo di un espediente retorico stanco e abusato (per non dire stantio), o c’è dell’altro?
Provo a svolgere qualche considerazione a partire da queste domande. Quanto alla «storia» in questione, temo che il riferimento possa essere alla «Storia», come quando si afferma: «oggi stiamo facendo la Storia». Dico: temo, perché in genere quando si parla così ci si sente chiamati a un rapporto diretto con qualcosa che ci trascende e assomiglia, almeno in parte, a una sorta di Spirito assoluto che si dà in forma storica; il quale Spirito, solo, in ultima istanza, è legittimato a valutare. Mi auguro che questo timore sia solo un fantasma nella mente di un vecchio professore costretto a una prolungata solitudine al chiuso – privo, dunque, non solo dei benefici dell’aria aperta e della luce solare diretta, ma anche della feconda possibilità di confrontarsi quotidianamente con quegli amici, colleghi, familiari, studenti, che svolgono solitamente la funzione salutare di metterlo di fronte alle sue inadeguatezze, riportandolo dalle sue elucubrazioni intellettualistiche al cosiddetto piano di realtà. Anzi, direi che dev’essere senz’altro così. Non posso credere che in una società democratica avanzata i cittadini e i loro rappresentanti debbano essere ritenuti e ritenere se stessi inadatti a giudicare, qui e ora, le scelte politiche del governo oggi in carica, né che essi debbano limitarsi a ubbidire e subire, rimandando alle future generazioni il privilegio di formulare, col senno di poi, critiche e valutazioni sicuramente corrette ma, come è stato ricordato, a quel punto politicamente irrilevanti e inutili.
Scartiamo pertanto questa ipotesi, oltre che fantasiosa, poco generosa – in quanto, se confermata, implicherebbe una scarsa sensibilità democratica in chi guida il governo – e procediamo, cercando di confrontarci con quanto è implicito nelle altre domande: c’è qualcos’altro, oltre a una retorica scadente, nell’affermazione che il giudizio politico è riservato solo alla «storia» e al futuro?
Forse sì. Forse c’è qualcosa che riguarda, a diversi livelli, il meccanismo di fiducia sotteso a ogni politica democratica matura. E c’è qualcosa che riguarda il rapporto tra la politica e la vita.
Per semplificare, sulla scorta di un’ampia letteratura, propongo di distinguere 3 tipi di fiducia: (1) fiducia nel sistema; (2) fiducia nelle istituzioni; (3) fiducia negli operatori. Possiamo dire che confidiamo nella tenuta generale del sistema, abbiamo fiducia nelle istituzioni, diamo fiducia agli operatori istituzionali (sul piano politico, tipicamente, attraverso il mandato elettorale).
A volte c’è chiara interconnessione e interdipendenza tra i tre tipi di fiducia, altre volte le cose sono meno evidenti. Sul piano politico è spesso difficile distinguere. La democrazia rappresentativa enfatizza la responsabilità e l’autonomia del cittadino elettore. Il dare fiducia agli “operatori”, ossia a rappresentanti e amministratori, dovrebbe perciò prevalere sull’avere fiducia nelle istituzioni e soprattutto sul confidare nel funzionamento generale del sistema. Tuttavia, ciò non sminuisce l’importanza di un’attitudine volta a confidare nella tenuta complessiva del sistema. Anzi, proprio questa disposizione – che molti studiosi considerano parte essenziale del capitale sociale – scongiura il rischio che una crisi nel sistema democratico, dovuta a performance deludenti dei governanti, si trasformi senz’altro in una crisi del sistema. Il sistema deve però, a sua volta, essere palesemente ritenuto e presentato dagli operatori e decisori politici come dotato di effettiva capacità di tenuta per una sua intrinseca razionalità complessiva: la fiducia dei cittadini nel sistema – più in generale: il capitale sociale – si nutre anche della fiducia che gli operatori/decisori istituzionali dimostrano nella razionalità dei cittadini.
Il funzionamento di questo delicato meccanismo sociale è obiettivamente difficile in condizioni di emergenza e lo diventa tanto più quanto più la politica si pone in rapporto paternalistico con la vita e la salute dei cittadini. È vero che il paternalismo appare ben difficile da evitare quando, come avviene ormai da secoli, ai poteri e alle funzioni tradizionali della politica si aggiunge il compito di determinare o favorire condizioni economico-sociali e igienico-sanitarie atte a promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e a scongiurare o ridurre progressivamente il rischio di morte per denutrizione, per malattia e perfino per eventi naturali. Ma questo non deve mettere a tacere il nostro senso critico; non deve impedirci di vedere che tanto la mentalità sociale quanto l’atteggiamento della politica hanno finito per attribuire a quest’ultima, sempre più diffusamente, il ruolo di potenza salvifica e, per converso, la responsabilità delle conseguenze di eventi la cui origine e il cui controllo non rientrano nelle disponibilità del governante o del legislatore. La capacità di gestire il non politico si è trasformata in fonte fattuale di legittimazione del potere, sia in assenza che in presenza di procedure e sistemi istituzionali per la legittimazione formale di esso.
Convivono quindi nelle moderne democrazie due fonti di legittimazione. Una è quella razionale, che si manifesta attraverso procedure legali opportune e maturi rapporti tra governanti e governati. L’altra è arcaica e ci riporta, sul piano sia filogenetico che ontogenetico, alla nostra memoria psicologica primordiale, ossia all’ubbidire alle figure che sono in grado di proteggerci.
Entrambe queste fonti di legittimazione riposano sulla fiducia. In un caso si dà fiducia ad alcune figure selezionate per alcune loro (presunte) specifiche qualità e capacità “tecniche” e si confida nella razionalità generale di un sistema sociale complesso. Nell’altro, ci si affida, per esigenze psicologiche, a un sistema primitivo di comandi e ubbidienze, che si struttura sul modello del rapporto fedele/Provvidenza divina, o – se si preferisce un’immagine meno impegnativa – su quello bambino/adulto, nell’ambito del quale tutti siamo cresciuti e che tutti siamo propensi a riproporre o ritrovare nel passaggio dalla nostra vita infantile a quella adulta, vissuta nel mondo, a di fuori delle pareti e dei rapporti domestici.
La sollecitazione a valorizzare questo secondo rapporto di fiducia a discapito del primo appare con particolare chiarezza nell’attuale insistenza con cui nella comunicazione pubblica (compresa la stampa d’opinione) il cittadino viene riportato e rinchiuso nell’alveo primitivo, quello domestico, in una condizione infantile nella quale sta a un’autorità genitoriale, prerazionale e “indiscutibile”, in quanto fonte della protezione primaria, dettare le condizioni per le quali il bambino è autorizzato a uscire di casa, così come è di esclusiva competenza di essa determinare per quanto tempo, in quali situazioni e a quali scopi il bambino può farlo. Il bambino, come è noto, non è in grado di entrare nel merito, non ha ancora sviluppato le capacità necessarie e sufficienti. Solo da adulto potrà capire; solo in futuro, nella sua storia futura, potrà giudicare. Intanto, deve affidarsi ai genitori.
Una comunicazione pubblica di questo genere può provocare contraccolpi fortemente negativi. Si è conferito l’attributo di luogo potenzialmente letale allo spazio aperto in quanto tale. L’indicazione medica del distanziamento sociale è stata tradotta sul piano normativo – e soprattutto su quello comunicativo – in prescrizione di isolamento all’interno dello spazio domestico. Nello spazio aperto e pubblico, ci ricorda un’informazione martellante e incessante, si muove un terribile nemico interno, un nemico invisibile, col quale siamo in guerra: una guerra nella quale ciascuno è coinvolto. Frequentando lo spazio pubblico – compreso lo spazio riservato al culto –, è stato detto e ripetuto infinite volte, si corre il rischio di portare involontariamente nello spazio domestico il nemico invisibile, che può uccidere, oltre che noi, le persone a noi più vicine e più care. Nella reiterazione narrativa i rischi si sono inevitabilmente ingigantiti: è stato presentato come pericoloso perfino frequentare lo spazio pubblico in solitudine. Muoversi nello spazio aperto è parsa addirittura un’azione sovversiva, da punire, nella migliore delle ipotesi con gravi sanzioni giuridiche, nella peggiore con aggressioni, verbali o fisiche, da parte dei cittadini.
Non è una novità, si dirà a ragione. Le pagine dedicate da Alessandro Manzoni alla persecuzione degli “untori” sono indimenticabili. Il protagonista del Diario dell’anno della peste, scritto da Daniel Defoe oltre un secolo prima de I promessi sposi e ambientato nella Londra del 1665, ricorda come coloro che non potevano allontanarsi dalla città si chiudessero in casa per evitare il contagio e non si lasciassero impietosire neppure dalla morte degli amici e degli affetti più cari, preoccupandosi solo di scampare alla stessa sorte. Non c’è pertanto da stupirsi di certe reazioni. Sono nella nostra memoria ancestrale. La differenza sta nel fatto che il confinamento di cui parla Defoe non dipende da decreti. La politica non rientra nell’orizzonte della narrazione. Il protagonista del libro resta a lungo preda di un’angosciata irresoluzione, non sapendo decidere se mettersi al riparo dal contagio lasciando Londra o correre il rischio di restare, per non perdere la sua attività, il suo magazzino, tutti i suoi beni. La decisione è solo sua. Egli non si aspetta di essere salvato dalla politica, che non ha ancora questo compito e questa responsabilità. Altre sono le forze alle quali il personaggio si rivolge. La sua scelta avviene infine sulla base della bibliomanzia: apre a caso la Bibbia e si affida al senso delle prime parole che gli capitano sotto gli occhi. Nella Provvidenza divina, come tutti sappiamo, confidano anche i personaggi manzoniani, collocati dall’autore anch’essi nel XVII secolo.
L’esaltazione di un meccanismo di fiducia arcaico e regressivo a discapito di quello razionale può revocare in dubbio la razionalizzazione dei rapporti di comando e ubbidienza. Si può arrivare, senza neppure rendersene conto, a vedere nei decreti governativi “un segno” di un’entità superiore, un barlume di luce in un’eclissi totale di fiducia razionale nel sistema, di quella fiducia fondata sulla convinzione della solidità di un ordinamento retto non su un paternalismo irriflesso, ma sulle potenzialità e sulla versatilità della costituzione materiale della società nei periodi di crisi e di emergenza.
L’efficacia della fiducia democratica necessita di reciprocità e bilateralità. Una comunicazione pubblica impostata in senso paternalistico svela una tendenza all’unilateralismo. Si chiede al cittadino di confidare nella saggezza e nella competenza del potere democratico, mentre non si allentano, ma si moltiplicano le occasioni e i mezzi di controllo, dimostrando che il livello politico e l’informazione diffidano nelle capacità razionali del cittadino. Si producono pertanto, inavvertitamente, condizioni che sbilanciano e incrinano il sistema sociale.
Quando al distanziamento sociale si aggiungono strategie di controllo e appelli all’aspetto arcaico e prerazionale della fiducia, si finisce per erodere il capitale sociale e mettere a repentaglio la solidità complessiva del sistema. Per gestire il sistema sociale in una fase di emergenza, se ne contraddicono e quindi se ne minano i presupposti e i pilastri portanti.
Troppo a lungo l’opinione pubblica si è lasciata intrappolare nella sciatta alternativa tra timida passività di fronte a uno Stato/Provvidenza (o a un governo/genitore) e becera contrapposizione, per mero spirito oppositivo, a ogni politica governativa. Dopo che le più recenti dichiarazioni hanno dimostrato una inequivocabile coazione a ripetere, si comincia forse ad avvistare qualche segnale – almeno nell’opinione pubblica qualificata – di recupero di un adeguato senso critico, in grado di sfondare quell’alternativa, e di una disponibilità ad assumersi il rischio di giudicare, dissentire razionalmente – e sbagliare. Senza aspettare «la Storia».
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo