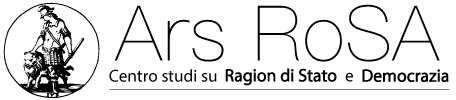di Maria Pia Paternò (Univ. “Federico II”, Napoli)
Non sono sicura di avere qualcosa da dire su questa emergenza che incombe su di noi. Non so se l’elaborazione dello shock è riuscita già a formare un grumo di pensiero. O se la psiche è ancora rattrappita, se l’impatto della percezione si scarica su un soggetto ripiegato su di un sé, che si sente troppo minacciato per poter vagare –seppur a tentoni- per il mondo. Per coglierlo nella sua trasformazione e individuarne la direttrice: verso una catastrofe annunciata, il collasso economico e sociale, la liberazione dai vincoli disumani del capitalismo estrattivo o cognitivo?
Non ne so nulla ancora. Eppure non si può dire che si sia trattato di qualcosa che davvero in nessun modo mi aspettassi: uno shock epocale o un’irruzione di minore impatto… comunque un evento globale che non avrebbe rispettato i confini degli Stati e non avrebbe conosciuto –così avrei forse immaginato se avessi potuto mettere bene a fuoco- la distinzione tra ricchi e poveri o tra pubblico e privato. Qualcosa che, senza sapere altro, sapevamo tuttavia che poteva a ogni momento capitare. Che ci stupivamo addirittura, tra Cernobyl e Fukushima, di avere in così tante occasioni potuto costringere dentro una parentesi, bloccando per tempo la catena delle conseguenze di disastri ambientali e socio-sanitari.
Adesso l’evento è proprio qui e ha l’aspetto di un virus che, invisibile, si intrufola silente. Si svela solo con la tecnologia adeguata, che ce lo mostra come esteticamente bello. Un fiore letale dai colori seducenti, che avanza secondo una logica di tipo esponenziale senza delineare una vera distinzione neppure lungo la linea generazionale, dal momento che colpisce -sebbene generalmente con un differente impatto- anche giovani e bambini. Non c’è nessuno dunque, contrariamente a quanto era sembrato a primo acchito, che possa a ragione chiamarsi fuori dalla lista delle vittime possibili.
Uno di quegli eventi che invadono il profondo.
È un virus che viene in mezzo a noi e si ferma purtroppo per restare, fino a quando non avremo trovato un modo più o meno efficace di convivere o di poterlo effettivamente contrastare. Finché non avremo trovato la strada giusta nello sforzo globale di una comunità scientifica abituata, speriamo, alla libera collaborazione dei cervelli. Sappiamo ormai che, comunque, ciò non sarà nell’immediato. Ciò che al momento vediamo agire, è infatti la potenza sovrana degli Stati: ci protegge isolandoci, ciascuno con disposizioni sue particolari, senza rifuggire a volte dal miope opportunismo di una tempistica che spera di trarre vantaggio dal disagio di chi ci è capitato prima. Siamo in contemporanea su due tracce di binari: sull’una il tragitto di un virus che non conosce confini nazionali, sull’altra il percorso reattivo degli Stati sovrani ancora muniti del più tradizionale degli arsenali. Ma è qui –soltanto qui- che si è proceduto nel tentativo di tutelare gli individui: quelli più fortunati almeno, che hanno vinto qualcosa alla lotteria della nascita e rientrano nella categoria dei cittadini di Stati ancora in grado di fare in qualche modo fronte. Generazione Erasmus e cittadini del mondo sono ora rientrati in massa, dalle destinazioni più disparate, nel grembo in questi tempi più accogliente della loro madre-patria.
È alla politica nazionale che, allo stato attuale, è affidato quasi per intero un compito che sappiamo non potersi però affrontare se non a un livello che è globale. Forse, se ce la riusciamo a fare, con l’Unione Europea potremo spostarci almeno su un piano regionale. Ma è allo Stato che -faute de mieux- siamo soprattutto costretti a fare appello perché trovi il modo di gestire un’emergenza che si protrae nel tempo. Qua si tratta di affrontare a mani nude un problema che ci coglie palesemente impreparati.
Colpevolmente, certo. Mai per un istante sono mancati i moniti contro la hybris di un uomo irrispettoso di sé e dell’ambiente. Ma sono sembrati troppo vaghi ed indeterminati, troppo moralistici o intrisi di toni apocalittici, troppo inquietanti per guardarci dentro fino in fondo. Ce ne siamo riempiti gli occhi al cinema e ci abbiamo fuggevolmente messo il cuore attraverso le pagine di libri che siamo arrivati ad amare, ma poi li abbiamo lasciati andare prima che arrivassero a toccarci per davvero. Si è trattato di un dolore dal quale abbiamo cercato di proteggerci con strategie che non ci hanno potuto tutelare. Tanto più quando le minacce ci sono sembrate plausibili e ben documentate: nulla hanno potuto contro questa nostra ostinazione la sars, l’aviaria, l’ebola, la peste di Camus o quella di Manzoni. Ma ora questa epidemia è diversa, perché è quella che viviamo e che non siamo riusciti a controllare.
Se allora il mio pensiero non riesce a formulare un’ipotesi di lavoro sul futuro (non saremo più come prima ripetiamo quotidianamente, ma senza poter immaginare com’è che saremo invece) – se dunque non è in questa direzione che riesco a lavorare, posso provare però a impegnarmi in un qualche altro sforzo: voglio iniziare in modo responsabile e, resistendo alla fascinazione di ragionamenti troppo sofisticatamente congegnati, procedere in modo inaspettato, cominciando con il prendere sul serio le emozioni.
Sono smarrita e ho paura, lo voglio dire onestamente, con l’ambiguo coraggio di chi è disposto, per un attimo, a farsi vedere dentro. Temo per la mia salute e quella dei miei cari, così come per le condizioni future della mia esistenza in vita, dovesse il virus graziosamente risparmiarci tutti. Piango per i ragazzi miei e quelli degli altri, che in quell’età che dovrebbe essere di proiezione sul futuro, sono paralizzati in un presente vuoto, anestetizzati da un flusso ininterrotto di comunicazioni a distanza che, dai social alle lezioni in streaming, impediscono loro di toccare la paura e di imparare quale può essere un modo di reagire.
Filosofia e psicanalisi ci invitano a prendere coscienza che questa è angoscia e che non è produttiva come invece la paura. Sarà pur vero che c’è diversità e che quello che è invisibile e indeterminato produce emozioni di tipo differente. Eppure non mi pare che ciò escluda la reazione; che impedisca si possa mettere a frutto un saper fare; che inibisca necessariamente il desiderio di affrontare seriamente un compito e di prendersi qualcosa in carico, di pensare di poter essere qualcuno che, a un qualche livello, fa la differenza per davvero. Non è che sia indispensabile essere medici o infermieri per poterlo fare. Ci sono anzi altre strade che potremmo pian piano imparare ad esplorare a partire dalla consapevolezza di quello che ci sentiamo dentro e dalla necessità di dire cos’è che ci è capitato di scoprire.
Ciò che ho pensato di poter fare io al momento sta nel regolare le mie lenti a un nuovo fuoco: per potere inquadrare questo istante e scattare un’istantanea del momento. Nella foto di queste strade vuote, di queste vetrine cieche e degli spazi ora disabitati dei tavolini dei caffè vedo questo presente in un modo nuovo. Metto a fuoco l’idea di un rovesciamento, mi chiedo se il troppo pieno che vedevo prima non era già anch’esso un vuoto. La foto mi pare al fondo svelare la continuità di un elemento che è sempre stato talmente noto e familiare da restare occultato dalla sua evidenza stessa. Il nuovo focus mostra quello che è da tempo stato e inquadra un’assenza di impegno e di persone: illumina, nel vuoto della piazza, quello che è il centro della nostra incuria.
Perché sapevamo dei rischi della nostra condizione. Ci è stato detto forte e chiaro su più fronti: dal lato della teorizzazione della società del rischio e dell’incertezza e da quello della proposta delle teorie del caring. Sapevamo un sapere che, senza una messa a fuoco emotiva, è sconfinato nel non sapere. Abbiamo reagito con fastidio quando le prefiche impotenti della catastrofe hanno alzato troppo la voce, abbiamo smussato, ridimensionato, negato. Per potere andare avanti come sempre, lamentando la precarizzazione della popolazione, la vulnerabilizzazione degli anziani, l’infantilizzazione di giovani, lo spostamento delle linee generazionali e il deserto emotivo condiviso un po’ da tutti. Senza affrontare mai i problemi, senza rovesciare mai, neanche una volta per davvero, un tavolo. Neanche quelli in cui le partite che si giocavano ci sembravano importanti.
Giorno dopo giorno i problemi si sono ingigantiti: abbiamo visto l’erosione della solidarietà e del potere d’acquisto, il crescere delle diseguaglianze, lo svuotamento dei diritti economici e sociali, il prosciugamento delle risorse del welfare, la disattesa di aspirazioni della cui legittimità non abbiamo dubitato. Abbiamo trascurato i trasporti, l’istruzione, la sanità: è per questo che c’è scarsità di letti, di terapie intensive, di presìdi medici assolutamente indispensabili. Abbiamo realizzato profitti che ora non ci servono, accumulato ricchezze che si sono accompagnate a altre povertà. Lo sapevamo, ma non lo sapevamo. Era tutto al centro di un’incuria di cui non è stato certamente sufficiente limitarsi a discettare: con l’implicita speranza che, comunque, restava ancora la possibilità di rinviare.
Ora che la misura della nostra incuria è colma, nessun diniego ci potrà accompagnare ancora. Siamo costretti alla presa d’atto dell’incapacità di azione cui questo atteggiamento ci ha condannato e delle conseguenze che è suscettibile d’ora in avanti di esplicare, venuti meno gli argini che pure sapevamo non essere alla lunga in grado di trattenere il flusso degli eventi.
E adesso che questo esercizio di messa a fuoco ha riattivato un poco la circolazione del pensiero e i movimenti inizialmente troppo intorpiditi e lenti, ecco apparire da uno sfondo opaco una visione ben riconoscibile, sebbene dai contenuti ancora incerti: l’idea che il cambio di registro di cui non possiamo fare a meno possa passare dal calcolo del rischio all’impegno della cura. Cioè alla messa a fuoco di un modo diverso di immaginare il potere politico, in cui non vada ancora una volta perso di vista quello che costituisce oggetto privilegiato di attenzione nella nostra vita vera che, incapace di effettuare distinzioni chiare tra zoè e bìos e di rinunciare all’idea di almeno un minimo di “bene”, pensa sempre all’una e all’altra insieme. Si tratta di un’immaginazione che richiede di pensare il sé e l’altro insieme, nonché di abbandonare i tempi troppo brevi dell’economia per abbracciare una politica che sappia posizionare nel suo centro ciò che costituisce il centro delle nostre vite, impegnate per grande e significativa parte di tempo in pratiche di cura: di protezione, di sostegno, di riparazione del dolore e dei legami usurati dal disimpegno e dalla disattenzione se non, a volte, da ciò che costituisce vero e proprio abuso.
L’idea sarebbe quella di ragionare attorno ad un approccio politico alle teorie della cura che, mantenendosi consapevole dei rischi di prevaricazione e di infantilizzazione, sappia tenersene quanto più possibile lontano, coltivando un approccio realistico alla realtà delle cose e dei legami all’interno di una cultura che sappia accogliere il senso dei propri limiti e la possibilità, sempre presente, dell’errore. Un approccio riflessivo, che sappia fare tesoro della consapevolezza della inevitabilità dell’esposizione al rischio di quelle creature vulnerabili che siamo e possa lavorare seriamente a uno sforzo responsabile in direzione di un suo contenimento. Si tratta di un’ottica che rende pertanto necessaria una ridefinizione dei compiti e una più ampia partecipazione agli oneri che nascono dalla consapevolezza della gravosità di un impegno politico concentrato attorno alle pratiche necessarie per “mantenere, continuare e riparare il nostro mondo e viverci nel miglior modo possibile”, come propongono Joan Tronto e Berenice Fisher nel definire un concetto politico della cura che possa rivivificare l’impegno democratico a partire dal riconoscimento della realtà dell’interrelazione e delle peculiari connotazioni che assume l’aspirazione all’autonomia in soggetti fragili e vulnerabili quali noi siamo.
Bisognerà allora effettuare un nuovo investimento sul concetto di cittadinanza. Che sia italiana, globale o europea -oppure, come è da sperare, a diversi livelli tutte le cose assieme-, essa dovrà fondarsi su una nuova condivisione degli impegni che scaturiranno dalla necessaria ridefinizione dei bisogni. Il collegamento dell’idea di cittadinanza con un dovere di contribuzione fiscale e con l’ormai quasi inoperativo obbligo alla difesa dei confini della patria potrebbe così arricchirsi, nel segno di un’iterazione di prestazioni reciproche tra lo Stato e il cittadino, con la messa in opera di un servizio sociale attivo che, abolita ormai da anni la ferma obbligatoria, apra in altre forme i giovani (e non solo) a un impegno reale nella collettività.
Questo, al fondo, mi pare possiamo cominciare a trarre come insegnamento da questa nuova tipologia dell’emergenza: la necessità di una messa a fuoco che inquadri i molteplici luoghi della nostra passata incuria e, assorbendo pian piano il trauma attuale, ci aiuti a prepararci, come possiamo, alla possibilità di estendere la nostra visione e potenziare la nostra capacità di immaginazione.
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo