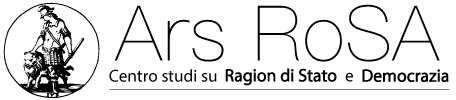“I primi secoli della modernità politica, in modo peculiare nei paesi romanzi rimasti fedeli alla Chiesa di Roma, risultano profondamente segnati dal lascito del Segretario fiorentino” (p. 5). Sullo sfondo di tale consapevolezza storiografica si incastrano i pezzi del mosaico composto da Gennaro Maria Barbuto nel suo ultimo saggio, All’ombra del Centauro. Tensione utopica e verità effettuale da Machiavelli a Vico (Rubbettino, 2019). Da Leonardo a Guicciardini, a Montaigne a Campanella, dai gesuiti Ribadeneyra e Graciàn, per finire a Pascal e Vico, il saggio di Barbuto offre una intrigante panoramica di gradevolissima lettura sulla presenza di Machiavelli all’interno di alcune tra le più importanti figure – personaggi e correnti di pensiero – che hanno segnato in profondità la modernità politica.
Che lo si accolga o lo si rigetti, il fulgore prodotto agli inizi dell’età moderna dallo scandalo machiavelliano produce in ogni parte d’Europa un movimento di attrazione e repulsione, che tuttavia nel suo passaggio lascia dietro di sé alcune zone d’ombra, in cui il rigetto si fa segreta operazione di assorbimento e viceversa la ricezione espelle o neutralizza parti comunque significative dell’opera del Segretario. Accade così per il “momento machiavelliano”, destinato, com’è noto, a perdurare ben oltre la biografia del suo autore. Su tali zone d’ombra, potremmo dire, si concentra il saggio di Barbuto, che mette in campo un’originale chiave interpretativa che non cede alle scorciatoie delle facili contrapposizioni dicotomiche, che scorgono la modernità politica proprio lì dove essa appare più distante dall’opera del Segretario (ad esempio nelle teorie contrattualistiche della sovranità moderna). Al contrario, le tracce di quest’ultima si trovano in luoghi teorici spesso impensabili e negli ambienti intellettuali all’apparenza più retrivi di fronte all’accettazione della verità effettuale che promana dall’arte della politica appresa alla scuola di Machiavelli. Serve così un lavoro di fine ricognizione per svelare le segrete trame del machiavellismo in epoca moderna. Non solo quindi per evidenziarne le esplicite (nonché, a dire il vero, rare) forme di adesione, ma anche per scorgerne i (più frequenti) tentativi di neutralizzazione che, al di là del semplice rifiuto, disegnano i contorni di un creativo e a tratti paradossale divergente accordo (anche quando tali istanze perseguono consapevolmente, come nel discorso della ragion di Stato, l’obiettivo della conservazione politica).
Il testo di Barbuto rifugge dalle facili dicotomie, si è detto: realismo e utopia, verità effettuale e tensione riformatrice, che sembrano procedere su binari paralleli, non vengono qui contrapposte, ma messe in tensione all’interno di una polarità in cui entrambe concorrono alla definizione della proposta politico-teorica del fiorentino che, se da un lato non si arrende alla cruda realtà della contingenza, da essa tuttavia prende le mosse e si fa concreta modalità dell’agire (politico). È dall’angolo visuale creato da questa tensione tra realismo e utopia – tra questi due vettori che convivono nella proposta politica del Segretario (come aveva osservato acutamente Gramsci) – che Barbuto ha scelto la prospettiva a partire dalla quale mettersi sulle tracce di Machiavelli. Se da un lato ciò significa, per Barbuto, evidenziare il realismo della costruzione machiavelliana nel riconoscimento del ruolo positivo svolto dai tumulti, dall’altro lato l’autore sollecita anche l’attenzione degli studiosi sull’aspetto ordinativo – istituente si potrebbe dire – del pensiero machiavelliano, la cui originalità consiste proprio nella funambolica e precaria compresenza di ordine e conflitto, non garantita – sia detto esplicitamente – da alcun fondamento o archè. Al contrario, secondo Barbuto, è proprio per restare fedele al metodo della verità effettuale che il pensiero di Machiavelli si apre ad una dimensione utopica, che non è mai vagheggiamento, ma istanza trasformatrice, innovatrice dell’agire politico. Del resto, Machiavelli ha imposto una torsione originale al lascito antropologico fondamentale dell’Umanesimo: dignitas e indignitas hominis, riconoscimento di una realtà umana “per nulla armonica, ma essenzialmente drammatica se non dilaniata” (p. 12). È la dimensione tragica che comunque pervade l’esperienza umana e che in Machiavelli diventa consapevolezza dell’essere infondato dell’agire dell’uomo in quell’agone polemico che è la politica. La politica è “arte” (Machiavelli) che si apprende a “bottega” (Guicciardini) e la sua infondatezza appoggia sul sentiero scivoloso dell’occasione, manifestazione del caso, dell’alea che avvolge l’umano agire. Da qui le tracce platoniche che Barbuto evidenzia nell’elaborazione machiavelliana dell’alea che apre alla figura del Principe come “tiranno accettabile”, la cui necessità emerge nella contingenza, lì dove cioè nella fortuna si apre uno squarcio possibile per la virtù, che prende appunto il nome di occasione. Non si tratta – chiarisce Barbuto – di rendere Machiavelli un epigono del platonismo malgré lui, ma di riconoscere proprio nel (neo)platonismo fiorentino, uno degli elementi cardine della formazione culturale del Segretario, che contribuisce ad introiettare – sulla scia di Ficino e di Pico della Mirandola – “il dissidio, la dissonanza, la conflittualità” (p. 18) all’interno del suo pensiero. Machiavelli, dunque, come “platonico selvaggio” (p. 19). L’eredità del disincanto platonico (Cacciari) rivive dunque nelle pagine machiavelliane, aprendo al riconoscimento della necessità di fare i conti con il limite, con “l’impraticabilità di ogni seduzione faustiana”, con la mala contentezza che non può non avvolgere il destino dell’umano agire. È da qui che ne deriva l’idea di uno “Stato come opera d’arte” (secondo l’intuizione di Burckhardt richiamata da Barbuto) intesa non solo come espressione di un calcolo razionale, ma anche come il risultato dell’agire, nella storia, di “forze irrazionali e ferine, centauresche” (p. 20).
Così, conclude Barbuto, il “dover essere” machiavelliano (ovvero la sua tensione utopica) “non si costruisce in isole fuori del tempo e dello spazio. Ma si radica nelle necessità della storia” (p. 23).
Da tale prospettiva, dunque, Barbuto mette in campo la sua chiave ermeneutica a partire dal confronto che Guicciardini instaura con il Segretario fiorentino, lì dove cioè la rinuncia ad ogni tensione utopica da parte dello storico (nel passaggio dal Dialogo alla Storia d’Italia) testimonia (sullo sfondo di eventi storici traumatici, come il sacco di Roma) il ripiegarsi di ogni istanza trasformatrice sul realismo di una storia costruita nominalisticamente sull’accidente, sulla scorcio di eventi che lo storico può sì spiegare nel loro accadere, ma senza potervi scorgere alcuna trama, alcuna tendenza sulla quale l’agire politico possa avere presa. Non si può discutere per universalia (da qui il rimprovero che Guicciardini formulava all’indirizzo di Machiavelli), ma solo “caso per caso, particolare per particolare, accidente per accidente” (p. 57).
La stessa tensione tra verità effettuale e tensione utopica la si ritrova, secondo Barbuto, in un attento lettore sia dell’opera di Machiavelli che di quella di Guicciardini nel contesto di quel particolarissimo fenomeno rappresentato dalla ricezione francese dell’opera del Segretario fiorentino, che, nel corso del XVI secolo, fa oscillare la sua figura tra quella del “maestro di arte politica” e quella di “scrittore diabolico”. Fuori dalle controversie di ordine morale, tuttavia, la traccia machiavelliana si presenta in Montaigne filtrata attraverso il metodo storiografico di Guicciardini: è la denuncia di non seguire alla lettera il metodo della verità effettuale, di essere mosso dall’istanza normativa (utopica?) di piegare la realtà ad un dover essere che classifica nei “reticoli concettuali la realtà mutevole delle cose e gli infiniti avvenimenti della storia” (p. 94) che ispira la critica che il filosofo francese rivolge all’indirizzo di Machiavelli. Il termine bransle traduce l’attenzione di Montaigne verso il riconoscimento che la realtà è così mutevole da essere refrattaria ad ogni proposta di ordine, fosse anche nel campo della conoscenza e del sapere riguardante l’arte della politica. “Crisi e ordine, rimuovendo il conflitto” (p. 99) è questa la strategia messa in campo da Montaigne per digerire il machiavellismo e far fronte alla crisi storica apertasi in Francia con le guerre di religione. Da qui la proposta di un assolutismo non confessionale, il solo in grado, appunto, di risolvere la crisi anestetizzando la politica da ogni contaminazione con la sua dimensione tragica, conflittuale e utopica. Sono in questo modo poste le basi per una neutralizzazione del pensiero di Machiavelli, lì dove il metodo della verità effettuale assume una torsione scettica che depotenzia ogni pretesa che tale verità possa darsi come agire concreto, come prassi all’altezza della trasformazione politica.
Diversa, perché impiantata sull’istanza di una ragion metafisica denunciata (a giusta ragione) come assente in Machiavelli, è l’opera di neutralizzazione svolta da Tommaso Campanella nei riguardi del pensiero politico del Segretario fiorentino. Neutralizzazione che, appunto, come sottolinea Barbuto, non è mai semplice rifiuto, ma confronto dinamico e creativo che segna, in Campanella, la “compresenza di machiavellismo e antimachiavellismo”. Così, prosegue Barbuto, sul rifiuto del carattere infondato della ragione umana, Campanella può innestare il principio (machiavelliano) del pro bono malorum, che tuttavia acquista senso, nell’ottica del filosofo calabrese, solo all’interno dell’ordine divino delle cose. In questo modo, afferma Barbuto, “tecniche machiavelliche e ragion di Stato erano adottate da Campanella, che non era affatto inconsapevole della concretezza e della ruvidezza della politica” (p. 115), a patto tuttavia di innestarsi sul solido fondamento di una ragion metafisica (antimachiavelliana).
La torsione che Campanella innesta sul rifiuto creativo del machiavellismo è un esempio tra i più significativi di ciò che Barbuto chiama il “paradigma della mediazione” e che troverà una consistenza specifica nell’antimachiavellismo gesuitico di fine Cinquecento e inizio Seicento. Anche qui, “antimachiavellismo” non significa semplice rifiuto, ma capacità di assumere e volgere ad un nuovo specifico fine alcuni dei lasciti più importanti del Segretario. Da Machiavelli, infatti, gli autori gesuiti seppero trarre spunti per elaborare una “forma cattolica della politica moderna”, che superasse (anche qui, senza rinunciare) le vuote astrazioni etico-teologiche della sintesi tomista, a favore della necessità di un venire a patti col mondo con la finalità di rinsaldare la presa della Chiesa cattolica sul governo degli uomini, messo a serio repentaglio dalla Riforma. Da qui il riconoscimento (ma si potrebbe anche dire l’invenzione) da parte gesuitica dell’esistenza di due ragioni di Stato, una “falsa ed apparente, un’altra solida e veritiera”; la prima, che essi presumono diretta filiazione del Segretario; e la seconda, che viene piegata all’istanza cattolica nel servizio che Dio rende ai governanti che seguono i provvidenziali ammonimenti divini come bussola per “entrare nel male”. Barbuto ribadisce l’indebita associazione che i gesuiti instaurarono tra Machiavelli e la ragion di Stato, all’origine di un vero e proprio misunderstanding che si sarebbe protratto per secoli. Tuttavia, Barbuto evidenzia anche come, proprio a partire da tale misunderstanding, si sarebbe formato il “paradigma della mediazione” in autori come Ribadeneyra e Graciàn.
Giova, in ultimo, segnalare la presenza di un antimachiavellismo dissimulato e anti-utopico in Pascal e il grande confronto che Giambattista Vico, il “più grande machiavelliano degli antimachiavellici” (p. 6), istituisce con la figura del Segretario fiorentino. Nel caso di Pascal, la politica, sulla scia dell’insegnamento agostiniano, rappresenta in sé quel “male necessario” funzionale a far regnare l’ordine nella società degli uomini: da qui il confronto di Pascal con Machiavelli quale testimone proprio del carattere tragico dell’esistenza politica degli uomini. Nel caso di Vico, invece, la vicenda del suo confronto con Machiavelli appare più densa e ricca di evidenze. In entrambi, infatti, Barbuto segnala l’uso della metafora come cifra fondamentale del sapere politico, di un “sapere mitico” (p. 164) che, a partire dalla medesima istanza consistente nel “far prevalere il momento immaginativo su quello logico”, svolge tuttavia nei due pensatori una funzione affatto diversa. In Machiavelli, infatti, la metafora del Centauro mette in campo l’immaginazione come strumento conoscitivo che consente di legare il particolare e l’universale all’interno del campo di azione definito dalla politica come istanza autonoma. In Vico, invece, si trova la metafora-mito del tuono, che inaugura il processo di civilizzazione a partire da un evento traumatico che introduce il timor Dei nella vita degli uomini e li spinge a vivere insieme, dandosi regole e ordinamenti. Questa comune caratterizzazione metaforica del politico, lontana da ogni istanza astrattamente razionalistica (alla Cartesio e alla Hobbes), rende Vico particolarmente ricettivo nei confronti dell’idea che la politica è riconoscimento del carattere insopprimibilmente conflittuale dell’esperienza umana. Il linguaggio metaforico sarebbe dunque espressione, comune a entrambi gli autori, di una capacità di congiungere e tenere insieme gli opposti (p. 183). Tuttavia, come segnalato da Barbuto, il riconoscimento in Vico del carattere conflittuale dell’esistenza umana è anche ciò che spinge il filosofo napoletano a rifiutare l’occasionalismo machiavelliano al fine di salvaguardare il carattere provvidenziale dell’accadere storico, che nell’ottica vichiana non risolve, ma apre al problema della libertà dell’agire umano.
In definitiva, All’ombra del Centauro si segnala con particolare riguardo in un tempo storico come il nostro, che sembra aver smarrito la bussola capace di orientare l’agire politico verso una progettualità che non sia ostaggio della contingenza. Non si dovrebbe infatti tornare ad investigare, oggi, sulle tracce dell’insegnamento del Segretario fiorentino, proprio quella tensione irrisolta (e forse irrisolvibile), ma necessaria, tra tensione utopica e verità effettuale?
 Stampa questo articolo
Stampa questo articolo